
Significativamente, Johnson – asceso alla presidenza, in quanto vicepresidente, dopo l’assassinio di Kennedy, e rimasto in carica fino al 1969 – non lanciò una massiccia campagna di creazione di posti di lavoro (come aveva fatto Roosevelt): l’obiettivo principale della sua massiccia campagna di lotta alla povertà non consisteva tanto nel creare occasioni di impiego, quanto nell’insegnare ai poveri a trarre beneficio dalle opportunità che il mercato avrebbe aperto. O meglio: benché il concetto di opportunità sia stato, come vedremo, un potente artificio retorico e uno straordinario catalizzatore di indirizzi di policy all’interno della guerra alla povertà, quell’“opportunità” si riferiva non solo alla concreta creazione di occasioni di inserimento nel mercato del lavoro, ma anche alla creazione nell’individuo della capacità di cogliere quell’occasione. In questo senso, le modalità di governo della povertà che si sono consolidate in quegli anni possono davvero essere lette come una forma di controllo sociale, nel senso delineato nel precedente capitolo: ovvero, come istillazione di una libertà – soprattutto economica – che permettesse al povero di superare le proprie resistenze culturali (fatalismo, dipendenza, rassegnazione) per vestire i panni dell’homo oeconomicus e lanciarsi nella competizione di mercato.
Il più celebre – e controverso – di questi programmi, il Community Action Program, prevedeva la partecipazione diretta – la «massima partecipazione possibile» – dei poveri stessi nell’amministrazione dei fondi federali a livello locale: una «tecnologia della cittadinanza» (Cruikshank, 1999) volta a superare un ulteriore carattere innato della “cultura della povertà” (il disinteresse politico, la rassegnazione, l’apatia) e a produrre cittadini responsabili capaci di “funzionare” ordinatamente all’interno del corpo sociale e politico.
I Community Action Program saranno i primi a cadere sotto la scure della revisione conservatrice della guerra alla povertà, accusati di aver trasformato le agenzie locali in centri di radicalizzazione e sovversione politica: il finanziamento del programma sarà drasticamente ridimensionato nel 1969, e infine sospeso nel 1973 insieme alla chiusura dell’Office for Economic Opportunity, la massima autorità della war on poverty nel suo complesso. La parabola dei CAP segnala evidentemente un limite intrinseco delle strategie di empowerment in generale: basate su una concezione assoluta dei poveri come soggetti passivi, rassegnati, disinteressati, tali strategie si scontrano talvolta con una realtà profondamente diversa, e sono costrette a vedere le armi della partecipazione e dell’auto-organizzazione ritorcersi contro chi le aveva distribuite. Nelle parole di un noto umorista americano, Art Buchwald, «Chiedere ai poveri come vincere la guerra alla povertà è come chiedere ai giapponesi come vincere la seconda guerra mondiale» <53.
Questa battuta, tuttavia, rivela qualcosa di ancor più profondo: come l’analogia tra i poveri e i nemici giapponesi suggerisce, quella di Johnson può essere considerata non tanto una guerra alla povertà, ma una guerra ai poveri in cui questi ultimi, e non la disuguaglianza economica, appaiono come i veri nemici (si veda per esempio la vignetta umoristica qui sotto).
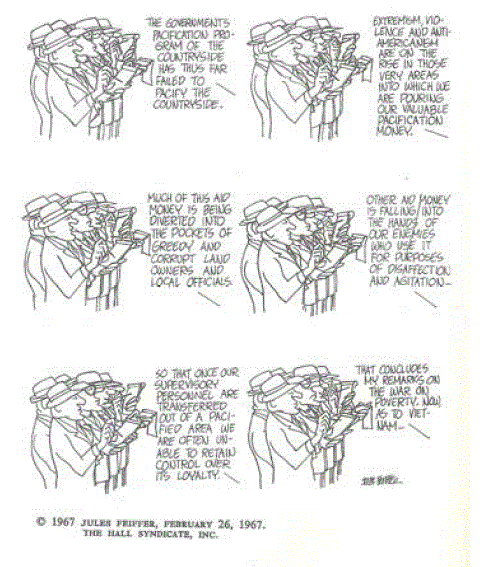
E se mi è concesso proseguire con questa metafora, direi che si è trattato di una guerra umanitaria: orientata non all’annientamento del nemico o al suo semplice contenimento (come avverrà in seguito con lo smantellamento progressivo degli apparati di welfare, da Nixon a Reagan a Clinton), ma alla sua elevazione materiale e morale.
Queste le parole con le quali Lyndon Johnson ha ufficialmente lanciato la guerra alla povertà nel suo discorso inaugurale sullo stato dell’Unione nel 1964: “We are citizens of the richest and most fortunate nation in the history of the world. One hundred and eighty years ago we were a small country struggling for survival on the margin of a hostile land, today we have established a civilization of free men which spans an entire continent […] The path forward has not been an easy one. But we have never lost sight of our goal – an America in which every citizen shares all the opportunities of his [sic] society, in which every man has a chance to advance his welfare to the limit of his capacities. We have come a long way toward this goal. We still have a long way to go. The distance which remains is the measure of the great unfinished work of our society. To finish that work I have called for a national war on poverty. Our objective: total victory. There are millions of Americans – one-fifth of our people – who have not shared in the abundance which has been granted to most of us, and on whom the gates of opportunity have been closed. What does this poverty mean to those who endure it? It means a daily struggle to secure the necessities for even a meager existence […] Worst of all, it means hopelessness for the young. The young man or woman who grows up without a decent education, in a broken home, in a hostile and squalid environment, in ill health or in the face of racial injustice – that young man or woman is often trapped in a life of poverty. He does not have the skills demanded by a complex society. He does not know how to acquire those skills. He faces a mounting sense of despair which drains initiative and ambition and energy […]. The war on poverty is not a struggle simply to support people, to make them dependent on the generosity of others. It is a struggle to give people a chance. It is an effort to allow them to develop and use their capacities, as we have been allowed to develop and use ours, so that they can share, as others share, in the promise of this nation” (riportato in Gettleman, M.E., Mermelstein, D. (eds) (1967), pp. 181-185…).
Ho riportato questo lungo brano dal discorso di Johnson perché esso mette in luce gli elementi chiave di un discorso sulla povertà che ha preso forma nel corso degli anni precedenti alla war on poverty, è stato centrale all’interno di quest’ultima, e ha continuato a costituire il sottofondo di ogni successivo dibattito sul welfare state, sui limiti dell’intervento politico nella regolazione del sociale, e sul principio della responsabilità individuale.
In questo discorso Johnson, nell’ordine: a) fa appello all’ideologia dell’eccezionalismo americano e alla visione comune dell’America come terra delle opportunità aperte a chiunque sappia coglierle; b) riconosce che le porte di queste opportunità sono rimaste chiuse per parte della popolazione; c) con un sottile gioco linguistico, spiega che se alcune persone non hanno potuto varcare quella soglia è non solo perché le porte erano chiuse, ma perché queste stesse persone erano intrappolate nella propria povertà, incapaci di muoversi, senza speranza; d) conclude quindi che la guerra contro la povertà non dovrà rendere queste persone “dipendenti” dalla generosità pubblica, ma dovrà al contrario aiutarle a coltivare le proprie capacità.
Non a caso, lo slogan della guerra alla povertà sarà «a hand up, not a hand out» [una mano ad alzarsi, non una mano a uscire]: i poveri non dovranno essere “tirati fuori” dalla propria situazione e spinti dall’altra parte dell’invisibile soglia delle opportunità, ma dovranno essere aiutati ad alzarsi e a varcarla con le proprie gambe […]
53 Cit. in The War Within the War, «Time», 13/5/1966 (cover story).
Stefania De Petris, Il governo del disastro. Katrina e il discorso su povertà e responsabilità negli Stati Uniti, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2009