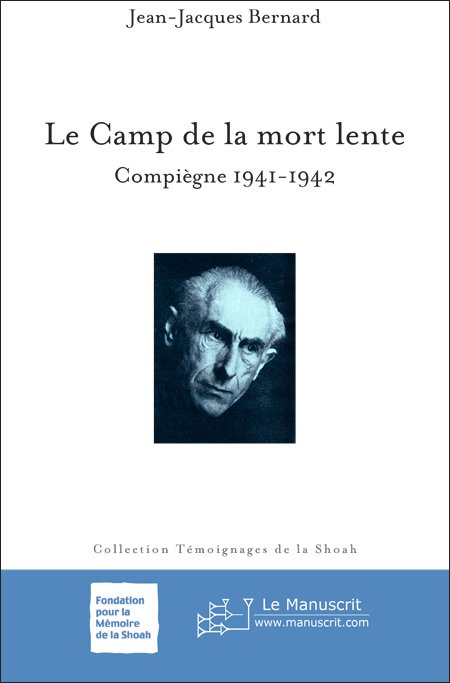
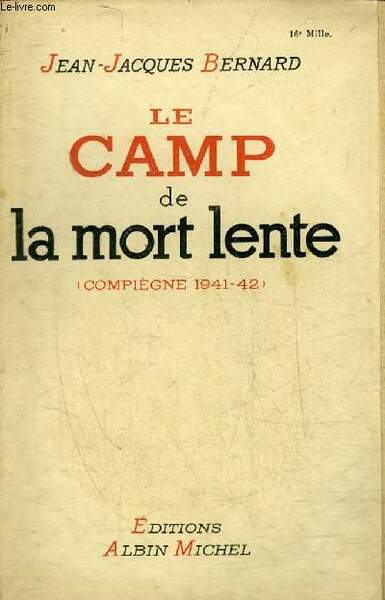
Ci sembra doveroso fornire un resoconto quanto più particolareggiato e obiettivo del libro di Jean Jacques Bernard: “Le camp de la mort lente”, uscito a Parigi nello scorso dicembre. Il campo è quello di Royal-Beu, presso Compiègne: l’autore vi fu internato in seguito a una razzia di ebrei avvenuta a Parigi nel dicembre ’41, esattamente il giorno dopo la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti, e vi rimase fino al marzo ’42, quando fu prosciolto per malattia grave.
Esistono qui in Roma centinaia di famiglie ebraiche, le quali da circa venti mesi vivono nella più angosciosa ignoranza di ciò che sia successo ai loro congiunti, prelevati nella famosa razzia del 16 ottobre 1943. Purtroppo è di ieri la smentita del Vaticano alle voci secondo cui la S. Sede sarebbe riuscita ad avere notizie degli sventurati. Della razzia romana si è giunti a ricostruire il decorso fino al momento in cui le vittime, sul treno piombato in rotta verso il nord, giunsero alla stazione di Firenze. Ma da Firenze comincia la notte inesorabile.
Il Bernard è penetrato nel cuore di quella notte, ne ha vissute alcune ore, scontandone attimo per attimo la sostanza per noi così crudelmente enigmatica, poi ne è riemerso a dirci com’era. Lo si interroga come uno che torni da un remoto e inaccessibile luogo di esilio, dove abbia lasciato persone a noi terribilmente care. E più che luogo di esilio, è una specie di aldilà: per usare la parola ebraica, un gaòl. Le risposte che il Bernard ci dà noi le riassumiamo soprattutto a intenzione dei nostri amici dell’ex-ghetto di Roma, che non potranno leggere il libro.
È quasi sicuro infatti che il racconto del Bernard, almeno fino a un certo punto, può far testo anche per i nostri deportati.
Intanto, fin dove sappiamo, il procedimento seguito nella razzia di Roma collima con quello descrittoci dal Bernard, al punto da far supporre che l’analogia continui anche dove dei nostri non sappiamo più nulla. A Parigi come a Roma i tedeschi si presentarono nelle case degli ebrei verso l’alba, col solito foglio di istruzioni: non ebbero riguardo né per l’età né per le malattie, ingiunsero una scadenza di pochi minuti, sorvegliarono con armata e insolente pignoleria i preparativi dei partenti. Unica differenza fondamentale: invece che le intere famiglie, nella razzia parigina furono presi soltanto gli uomini, anzi soltanto gli iscritti su certi elenchi. Differenza accessoria: non furono subito gli autocarri a portarli via, ma comode macchine chiuse, che li condussero fino alla mairie dell’arrondissment: qui i razziati si trovarono alla presenza di una specie di tribunale militare, ma tutto si limitò a un appello e ad alcune istruzioni berciate dal capo in un tedesco di cui il Bernard non comprese sillaba.
Da questo punto le due storie tornano a coincidere: a pugni e pedate, soprattutto contro chi si attardi perché vecchio o malato o stanco o impaurito, gli ebrei vengono ammassati sui tetri autocarri: questi si mettono a compiere complicati e inspiegabili giri per la città, quasi a scoraggiare vieppiù le vittime, che momento per momento suppongono una diversa meta e a ciascuna associano una specifica angoscia o terrore. Finalmente si fermano alla Scuola Militare. Collegio Militare a Roma, Scuola Militare a Parigi: senza dubbio la coincidenza è fortuita, ma accresce la suggestione dell’analogia.
Le ore passate dal Bernard nel maneggio della Scuola Militare fanno già parte dell’ignoto: di quel gaòl della deportazione, dal quale nessuno dei nostri ci ha più mandato a dire nulla. Per tutta la mattinata le pesanti porte si aprirono cigolando per fare entrare nuovi contingenti di razziati: non mai per farne uscire nessuno, nemmeno quel vecchio che, colpito da malore, dovette essere soccorso dai medici che si trovavano tra i prigionieri. Veramente una deroga ci fu: due individui che, quasi in risposta all’oltraggio, avevano indossato la loro divisa da ufficiali francesi, furono rimandati a mettersi in borghese, ma dopo un’ora rientravano. A ogni nuovo arrivo si riconoscevano parenti ed amici, ed erano scene come di affettuosa e dolente agnizione. Il medesimo dovette succedere anche a Roma: non si sa però se questi incontri fossero un conforto, o non piuttosto un incrudimento della pena, al vederla così specchiata nel viso degli amici, al constatare la impossibilità di un vicendevole aiuto.
Da anni il mondo intero sapeva quale sorte i tedeschi riserbassero agli ebrei catturati. Stupisce che uomini intelligenti come il Bernard e i suoi compagni si siano potuti illudere di essere trattenuti solo provvisoriamente, per qualche diavoleria amministrativa: tutto sarebbe finito al più presto e per il meglio, forse la sera stessa avrebbero già potuto dormire nel loro letto.
Va notato peraltro che quasi sempre i tedeschi effettuarono le razzie dopo di avere per qualche giorno infuso nelle vittime designate un senso di sicurezza e di tranquillità, mediante false notizie e allentamenti della pressione; era un modo di operare sotto narcosi, per garantirsi una più sollecita e calma riuscita dell’intervento. D’altronde, mentre già la punizione era in atto, essi cercavano di non ribadire il senso della punizione, anzi di mascherarlo. In tutta la giornata i rastrellati ebbero una sola visita dell’ufficiale preposto alla razzia: questi fece la faccia feroce, urlò, sbraitò, ma la visita fu brevissima e non portò visibili peggioramenti alla situazione. I giri di vite erano dati subdolamente, le torture erano indirette.
Solo a distanza ci si rende conto che la prima di quelle torture, sugli inizi quasi imprecisabile, come la goccia del supplizio cinese o la curvatura della parete nella cella cilindrica, consiste nel trasformare i bisogni naturali in una ossessione. Parallelo si svolge il tentativo di avvilire l’uomo, di fargli perdere il rispetto verso se stesso e i riguardi verso gli altri, il pudore e la segretezza di certe funzioni necessarie e indecorose. Nelle convivenze forzate, specie di gruppi numerosi, si sa che, una volta passati certi limiti, comincia l’inferno della reciproca insopportazione: e certo anche su questi i tedeschi speculavano. Così gli ebrei si sarebbero tormentati a vicenda. I primi rastrellati erano da poco giunti nel maneggio quando si avvidero che non era possibile appartarsi. Furono costretti a insozzare il luogo in cui dovevano trascorrere molte ore, a infettare l’aria che dovevano respirare, senza dire del disagio di fare ogni cosa sotto gli occhi degli altri (Anche a Roma l’accesso alle latrine fu vietato, o reso oltremodo difficile).
Per fortuna il Bernard non condivide quelle compiacenze sadiche, quel gusto di descrivere il ripugnante e l’orrendo, che avvelenano quasi tutta la letteratura nata dai misfatti del nazismo. Eppure, su questi argomenti addominali, torna con una insistenza esasperata, perfino coatta. Col prolungarsi del soggiorno a Royallieu, dove gli smaltitoi saranno quasi impraticabili, la tortura si aggraverà, e nel descriverla il linguaggio perderà quel contegno, quelle opportune reticenze, che pure l’autore mostra di pregiare. Il Bernard e i suoi compagni non sono più giovani: visceri e reni in loro hanno ormai perduta la necessaria tonicità; di più le affezioni intestinali, costipazione e dissenteria, prodotte da un regime di vita disadatto, renderanno sempre più massiccio quell’incubo. La forza del maleficio tedesco si può misurare anche da questo: che un argomento, stato quasi sempre pretesto di farsa scurrile e di lazzi, assume d’improvviso una serietà drammatica, atroce.
Durante la permanenza nel maneggio, gli ebrei si sentirono oggetto di odiose curiosità (anche i romani lo furono nel cortile del Collegio Militare, soprattutto da parte di certi fascisti repubblicani, che boriosamente ostentavano di essere tra gli organizzatori del disastro, e parevano voler misurare sulla desolazione delle vittime la validità del proprio potere).
Nella parte superiore del maneggio correva il solito ballatoio fatto per assistere alle evoluzioni dei cavalli, senza mettersi in pericolo e senza sporcarsi. Lassù, a una certa ora del mattino, gli ebrei videro comparire due spettatrici: des infirmières de la Croix Rouge allemande, deux grosses filles en blouse blanche à l’allure de nourrices… Elles étraient souriantes et semblaient nous regarder avec un vif interêt. Nel libretto del Bernard, non certo ricco di figure e di rappresentazioni efficaci, queste infermiere sono le sole che condensino un misterioso potere di apparizione, una crudele e allarmante vitalità. Si è quasi costretti a immaginare l’antefatto: le due ragazze poco prima alzatesi da letto, ancora odorose di dentifricio e di caffelatte, coi camici fragranti di ferro da stiro, incontrano in ospedale il compagno bene informato: “C’è una retata di ebrei”. E ottengono dalla compiacenza di qualche ufficiale il privilegiato ingresso al ballatoio, Juden zu sehen.
Nella loro inerzia provocante di spettatrici -dall’alto di quel ballatoio che permette di osservare senza sporcarsi- queste due infermiere precisano il senso della crudeltà tedesca assai più delle SS che menano calci e pugni, più del soldato di cui il Bernard ci parla altrove: il quale, entrato in una camerata di Royallieu, dove decine di ebrei dormivano sulla paglia, si tura il naso ed esclama: “Che puzza!”, alludendo alla proverbiale e maleodorante sudiceria giudaica. Costui almeno ha il coraggio di offendere direttamente. E l’offesa attiva si ritorce sempre su chi la reca: lo abbassa e lo deturpa, ristabilendo così una specie di compensazione.
Di prima sera, poco dopo scese le tenebre, le porte del maneggio furono aperte, e il locale si trovò inondato da una luce di fari. Gli ebrei vennero nuovamente caricati su autocarri che, dopo altri giri viziosi e incomprensibili, li depositarono alla Gare du Nord. Lungo e malagevole tragitto dall’ingresso della stazione fino al treno. È cominciato frattanto il martirio della sete, ma i tedeschi non permettono agli incolonnati di deviare neppure di pochi passi per abbeverarsi alla fontanella che si sente chioccolare nel buio. A questi “signori” della retata parigina (sono tutti intellettuali, magistrati, finanzieri, professionisti) non toccano però i vagoni piombati, bensì dei regolari scompartimenti, dove ciascuno trova il suo posto a sedere.
La meticolosa casistica della repressione tedesca contempla due tipi di campi: quelli propriamente detti di concentramento, e quelli di rappresaglia. Nel recinto di Royallieu erano compresi i due tipi: gli ebrei furono messi in quello di rappresaglia, mentre l’altro era suddiviso tra i “politici” (che con sineddoche stata in uso anche tra noi venivano tutti chiamati “comunisti!”) e gli stranieri: Russi, principalmente, e Americani. Il campo di rappresaglia aveva qualche cosa di non finito, di disorganizzato, tanto che gli ebrei ne concepirono la speranza che il loro soggiorno sarebbe stato di breve durata. I campi di concentramento invece erano delle specie di villaggi con baracche più comode e attrezzate; gli internati vi godevano di un vitto più adeguato: due minestre al giorno, e fitte di legumi a paragone con l’unica brodaglia quotidianamente somministrata agli ebrei. In compenso però, quando occorrevano ostaggi per qualche fucilazione, erano i campi di concentramento a fornire il materiale. Come si vede, l’ingiustizia tedesca distribuiva equamente i suoi malefizi. Un compagno del campo di concentramento dice un giorno al Bernard: “Noi siamo in un vivaio”. Ed è la frase più tragica di tutto il libro, nonché la sola che si senta autenticamente “registrata dal vero”.
Il tormento dei pidocchi, di cui subito si produsse l’incoercibile invasione, non fu quasi nulla appetto alla tortura del freddo e della fame. I geloni, resi maligni dall’insufficienza della nutrizione, cominciarono a suppurare, ad aprirsi, a degenerare in ascessi. La solerzia dei medici (erano anch’essi degli internati) non bastava a compensare la quasi assoluta mancanza di materiale sanitario. Poco più che due mesi di brodaglie erano bastati a ridurre tutti i corpi a scheletri coi ginocchi più grossi che le cosce. A contrasto, le facce erano sovente grasse e lustre, parevano floride di salute, e invece era l’edema da carenza alimentare. Ogni sforzo fisico e intellettuale divenne a poco a poco insostenibile: i brevi passi necessari per presentarsi all’appello parevano una fatica immane. Nessuno riusciva più ad alzarsi da certe indispensabili sedute, senza attaccarsi alla porta o senza il soccorso di una mano amica. E molte costipazioni dipendevano dal fatto che i muscoli addominali non riuscivano più a compiere lo sforzo espulsivo. La temperatura media degli internati oscillava tra i 34° e i 35,5°: un 36,5° era già febbre. Pare che questa ipotermia sia un espediente della natura per ristabilire un certo equilibrio con il gelo dell’ambiente. I morti furono numerosi. L’autorità, da Parigi, fingeva di non ricevere le relazioni del direttore sanitario, che chiedeva il proscioglimento dei più malati. Era come se i tedeschi avessero pronunziato una globale condanna a morte; ma, temendo di eseguirla, ne avessero passato l’incarico alla fame e agli stenti.
Poco dopo la liberazione del Bernard, motivata da uno spaventoso deperimento organico, parte degli internati furono rispediti a casa e gli altri avviati in Polonia. Solo questi ultimi potrebbero veramente darci le notizie di cui siamo più ansiosi, parlarci del gaòl. Speriamo che siano ben presto gli avvenimenti a diradare il mistero che ancora avvolge la sorte di decine e decine di migliaia di ebrei. Quello che il Bernard ci ha detto non è forse moltissimo. Per fortuna sua, egli fece un’esperienza solo parziale e forse attenuata. Inoltre, nel riferirla, per certe ragioni personali che bisognerà discutere, ci defrauda di quella che dovette essere l’intima, la specifica psicologia, la condizione umana degli ebrei deportati. Comunque, in confronto col nulla che fin qui sapevamo, anche il poco sembra già qualche cosa.
Giacomo Debenedetti, Campo di ebrei, «La Nuova Europa», A. II, n. 13, aprile 1945, come digitalizzato in Biblioteca Gino Bianco
La storia del razzismo nacque e si sviluppò ben prima delle pratiche antisemite degli anni Trenta e Quaranta, né aveva sempre avuto aspirazioni genocidarie ma è necessario affrontarla “non come storia di un’aberrazione del pensiero europeo o di sporadici momenti di follia, ma come elemento essenziale dell’esperienza europea”. <1010
Fu il passaggio dalla teoria alla pratica a determinare il punto di non ritorno, mettendo in moto un meccanismo che la legge e la burocrazia resero tangibile fino a farlo diventare la norma. La Shoah ha rappresentato il momento culminante di un lungo percorso in cui l’ideologia razzista si è diffusa fino a diventare uno dei principi fondanti della nuova Europa pensata dal nazifascismo. Queste lunghe radici del pensiero razzista facilitarono l’attecchimento delle sue idee anche in chi non aveva mai manifestato tendenze discriminatorie, perfino Adolf Eichmann, colui che è diventato uno dei simboli dello sterminio e che vi partecipò attivamente, ammise ripetutamente durante il processo di Gerusalemme di non aver alcuna ragione per odiare gli ebrei. <1011
Proprio la pervasività dell’idea di razza, accettata e riprodotta ciecamente, rende necessario uno sforzo per confrontarsi con queste idee che, seppur in modo differente, non sono terminate con la fine della Seconda guerra mondiale. <1012
Si tratta piuttosto di un altro aspetto tipico dell’Europa moderna e contemporanea, ascrivibile alla storia del pensiero europeo e che come tale deve essere affrontato.
Si è a lungo dibattuto sull’inspiegabilità della Shoah, ritendo impossibile spiegare la brutalità dei persecutori e la sofferenza delle vittime, <1013 queste ultime sono state completamente disumanizzate, private del loro essere persone e considerate corpi senza alcun valore. Primo Levi ha utilizzato il concetto di soglia, per definire un punto oltre il quale l’umana comprensione non può andare e si deve fermare, come su una porta che si apre sull’indicibile. <1014 In questo sforzo di comprensione gli storici sono stati aiutati dai testimoni, negli ultimi anni abbiamo assistito spesso all’intreccio tra storia e memoria, tra la ricostruzione narrata e quella scientifica dei fatti, una questione che ha animato il dibattito internazionale tra gli storici, considerate ora in supporto l’una all’altra ora in conflitto. <1015
La memoria è sempre frutto di una rielaborazione, è una ricostruzione che cambia nel tempo, è l’immagine che costruiamo del passato più che il passato stesso, mette in evidenza alcuni elementi e ne trascura altri, spesso semplificando la complessità storica di ciò che vuole ricordare. Sempre più spesso oggi alla storia si affiancano altre discipline che integrano il racconto della Shoah, intrecciando competenze e fonti diverse, su tutte le testimonianze orali, che sono divenute un elemento ricorrente nelle commemorazioni pubbliche.
I testimoni diretti di quegli avvenimenti sono divenuti una figura centrale sulla scena pubblica, da testimoni in cerca di giustizia nei processi, primo fra tutti quello ad Eichmann, sono passati ad essere la voce narrante della Shoah, facendo fare al punto di vista delle vittime un salto di qualità che ne ha fatto il centro del ragionamento negli ultimi anni. <1016
[NOTE]
1010 G. Mosse, Introduzione, in Id., Il razzismo in Europa, cit., p. ix. Fu con gli ideali dell’Illuminismo che iniziò la classificazione degli uomini attraverso misurazioni e confronti basati sulle nuove scienze del Settecento, tra le quali antropologia, frenologia e fisiognomica, a cui si unì un nuovo interesse per la religione ed i suoi valori morali, che insieme definirono i parametri estetici e morali dell’uomo.
1011 “Peggio ancora – scrive Hanna Arendt – non si poteva neppure dire che fosse animato da un folle odio per gli ebrei, da un fanatico antisemitismo, o che un indottrinamento di qualsiasi tipo avesse provocato in lui una deformazione mentale. “Personalmente” egli non aveva mai avuto nulla contro gli ebrei; anzi, aveva sempre avuto molte ragioni private per non odiarli”; in Id., La banalità del male, cit., p. 36.
1012 Nella sua storia del razzismo Mosse ammonisce sull’attualità e gli sviluppi futuri di una storia che non è affatto conclusa e rimane ancora capace di attirare consensi: “Sebbene in pratica tutti i sistemi politici e culturali creati dall’Europa durante gli ultimi due secoli abbiano una maggiore consistenza intellettuale del razzismo, ciò non ci deve distogliere dal compito di analizzarlo con la stessa attenzione da noi dedicata al socialismo, al liberismo o al conservatorismo. Forse il razzismo è stato, in ultima analisi, tanto efficace proprio perché era così banale ed eclettico, e perché, più di qualsiasi altro sistema del secolo XIX, si è adoperato con tanto successo a fondere il fattore visivo con quello ideologico”. Ivi, p. 252.
1013 Spetta allo storico il compito di spiegare gli eventi rendendoli comprensibili, pur con le difficoltà di rendere conto di una tale brutalità; per una sintesi di diverse spiegazioni della Shoah si veda Y. Bauer, Ripensare l’Olocausto, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009 [ed. or. Rithinking the Holocaust, Yale University, 2001].
1014 Cfr. A Cavaglion, La questione della “scrivere dopo Auschwitz” e il decennale della morte di Primo Levi, in P. Momigliano Levi, R. Gorris (cur.), Primo Levi testimone e scrittore di storia, Giuntina, Firenze, 1999, pp. 97-111. Il problema di “scrivere dopo Auschwitz” era molto sentito dallo scrittore torinese e lo condizionò ampiamente nella sua produzione letteraria, cfr. A. Cavaglion, Primo Levi: guida a Se questo è un uomo, Carocci, Roma, 2020.
1015 Critici verso la predominanza della memoria sono stati, in diversi momenti e a diverso titolo, Pierre Nora, Charles Maier, Saul Friedlander, mentre più favorevoli all’uso della memoria, anche contro il montante negazionismo, si sono mostrati Yosef Yerushalmi, Dan Diner e Pierre Vidal-Naquet. Cfr. A. Rossi-Doria, Il conflitto tra memoria e storia. Appunti, in S. Meghnagi (cur.), Memoria della Shoah. Dopo i «testimoni», Donzelli, Roma, 2007, pp. 59-70.
1016 Nel dibattito intorno al Giorno della Memoria Anna Rossi-Doria ha individuato tre criticità che si possono generalizzare al tema della memoria: l’eccessiva centralità dei testimoni, la prevalenza della memoria sulla conoscenza storica e la possibilità che nel lungo periodo la memoria possa essere messa in discussione, in ivi., pp. 59-70.
Giulia Dodi, La spoliazione dei beni ebraici e l’attività dell’Egeli a Bologna e Ferrara, Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 2021
La storia dei profughi ebrei transitati in Italia nel secondo dopoguerra è un argomento che è stato trascurato dalla storiografia italiana e internazionale e la memoria di quegli avvenimenti è stata perlopiù affidata ai diari e ai memoriali di coloro che li vissero in prima persona. Tra il maggio del 1945 e l’estate del 1948 si registrò in Italia una presenza media annua di profughi ebrei compresa tra i 15.000 e i 18.000, per un totale di circa 50.000 DPs che attraversarono il paese. A partire da questo dato numerico eccezionale, in questo lavoro verranno analizzate le conseguenze politiche, sociali e culturali causate da questo esodo di profughi che trovarono un rifugio temporaneo su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una ricerca basata in parte su fonti primarie d’archivio, reperite nell’archivio dell’American Jewish Joint Distribution Committee di Gerusalemme, Central Zionist Archives, Yad Vashem Archives e all’Archivio del Museo del campo di detenzione di Atlit, e in parte su fonti orali, interviste, diari e materiale fotografico inedito. Nella prima parte della ricerca verrà esaminata la reazione internazionale dinanzi alla questione dei profughi, con la creazione di una rete di organizzazioni di soccorso che cooperarono nell’assistenza ai DPs. Verrà ricostruito il percorso che portò alla costituzione nel 1944 della United Nation Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), la prima agenzia delle Nazioni Unite preposta alla tutela e al rimpatrio dei DPs e la sua missione in Italia tra il 1944 e il 1947. Verrà analizzato il ruolo delle numerose organizzazioni volontarie ebraiche, quali l’American Jewish Joint Distribution Committee (AJDC) e l’Organization for Rehabilitation through Training (ORT), che affiancarono l’UNRRA in queste operazioni di soccorso. Dopo anni di discriminazioni, per la prima volta si cercò di garantire ai profughi non solo un sostegno economico e un alloggio, ma anche un processo di riabilitazione morale, intellettuale e professionale. Nell’analizzare il caso dei profughi ebrei scampati alla Shoah, si terrà conto del loro rifiuto a tornare nei paesi che sino allo scoppio della guerra essi stessi avevano considerato “homeland” e del loro desiderio di rifarsi una nuova vita in Eretz Israel, dove di lì a poco sarebbe nato lo Stato di Israele. Dunque, è in questo clima che alle operazioni di soccorso dei profughi si intrecciò la ripresa delle operazioni del Mossad le-aliyah bet, l’organizzazione ebraica che, sfidando la politica del Libro Bianco, cercò di far sbarcare il maggior numero di profughi sulle coste della Palestina, all’epoca ancora sotto il mandato britannico. Sempre in questo contesto, si inserisce la mobilitazione dell’Agenzia Ebraica, che inviò nei campi profughi di tutta Europa i suoi delegati allo scopo di canalizzare l’immigrazione ebraica in Palestina e diffondere l’ideologia sionista tra i profughi. La ricerca si occuperà, quindi, della rinascita ebraica che ebbe luogo all’interno dei campi profughi, tramite l’insegnamento della lingua ebraica, la propaganda sionista e la costruzione di una nuova identità ebraica. La ricerca prosegue poi con l’analisi della vita dei profughi nei campi. Particolare attenzione verrà riservata ai quattro campi di transito del Salento, situati a Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Tricase Porto e Santa Cesarea Terme, e considerati tra i più ampi e attivi di tutta Italia. In questa sezione verrà descritta l’attività delle organizzazioni di soccorso nei campi e le condizioni di vita dei profughi. Verrà lasciato ampio spazio alla voce dei profughi, alle loro aspirazioni e le loro preoccupazioni così come traspaiono nelle interviste, nelle fotografie e nei loro diari. Questo lavoro si propone di dare risonanza a una vicenda che coinvolse tutta la popolazione italiana e che merita di essere inserita nella storia della rinascita del dopoguerra.
Chiara Renzo, “Aprite le porte”. I profughi ebrei nei campi di transito del Salento (1944-1947), Tesi di dottorato, Università Ca’ Foscari Venezia, 2013