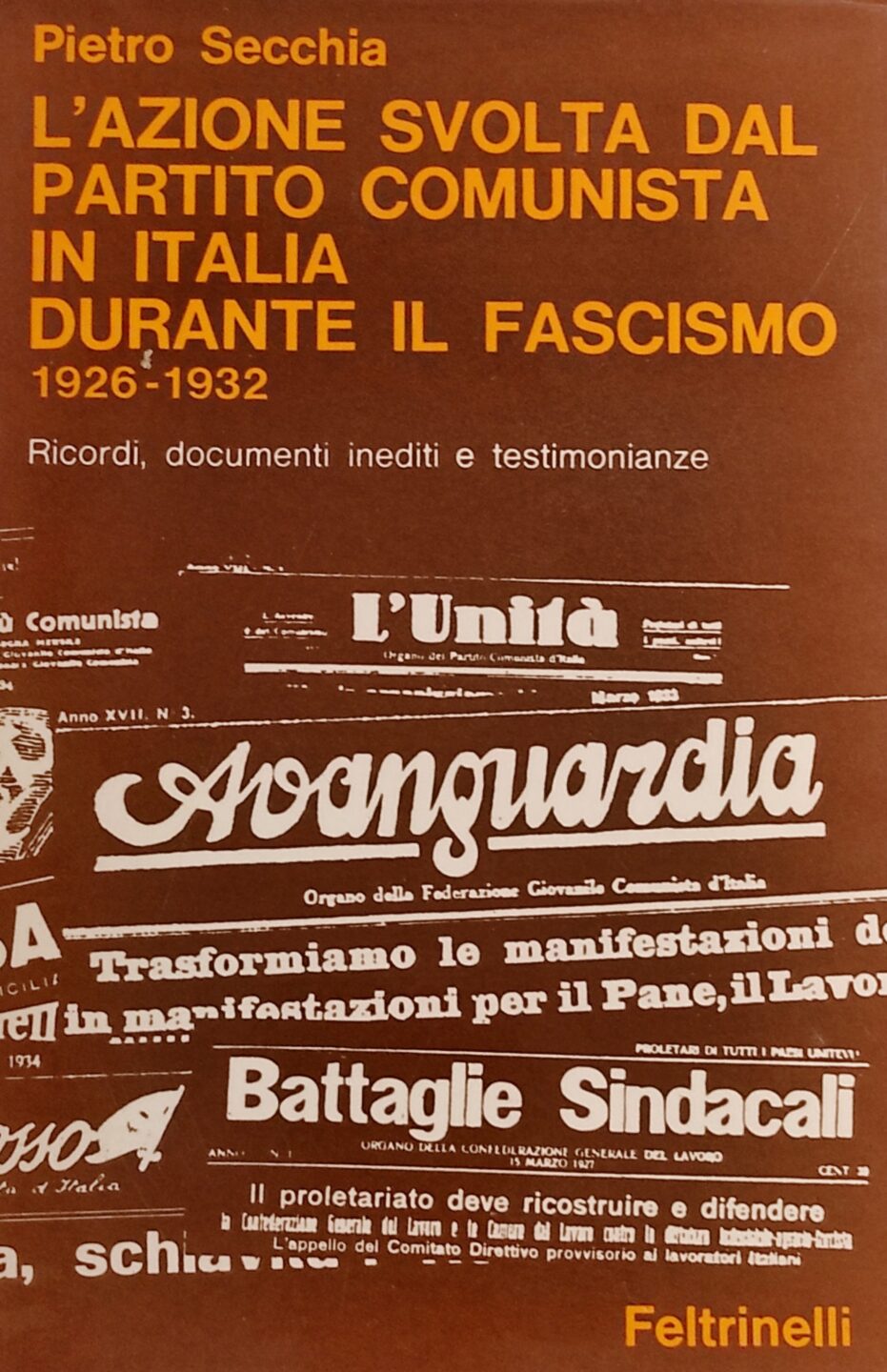
Nello scrivere delle lotte di quegli anni, alle quali ho partecipato in primo piano e con tutte le energie, ho evitato per quanto possibile (benché ciò sia piuttosto difficile essendo inevitabile in una testimonianza la forza soggettiva) gli episodi personali: e ciò non per falsa modestia, ma per il fatto che le vicende personali nel quadro di una grande lotta non hanno alcuna importanza se non per l’interessato e la ristretta cerchia dei suoi amici. Facendo uno strappo alla regola voglio cogliere l’occasione per alcune “precisazioni” circa un “ritratto” che si è voluto fare di me e che è circolato largamente in Italia negli anni trascorsi.
Sono stato presentato dalla grande stampa divisa in formazione come lo “stalinista” per eccellenza, il “conservatore”, l’ultrasovietico, eccetera. Gli uomini non possono essere giudicati da ciò che pensano di se stessi, ma neppure dalle caricature interessate tratteggiate dagli avversari e talvolta non soltanto dagli avversari. Non sempre le etichette, facilmente applicabili, corrispondono alla qualità del vino.
Non ho mai vissuto nell’Unione Sovietica, anche se vi sono stato molte volte, e con piacere; la prima nel giugno del 1924 al quinto Congresso dell’Internazionale Comunista: le cronache non lo dicono, forse perché non c’è traccia negli archivi, forse perché avevo soltanto vent’anni. Ciò non toglie che io vi sia stato con Bordiga, Grieco, Togliatti, Serrati, Maffi, Berti, Gorelli e gli altri delegati e abbia partecipato alle riunioni dei due Congressi, quello dell’Ic e quello dell’Internazionale giovanile, ed alle riunioni della commissione italiana che all’ordine del giorno aveva l’entrata dei terzinternazionalisti del Pci.
Non ho mai frequentato scuole di partito, né in Russia, né altrove, anche se lo avrei desiderato. Ho fatto parte del comitato esecutivo dell’Internazionale giovanile comunista dal 1928 sino al mio arresto (1931); eletto dal quinto Congresso dell’Igc, non ho mai occupato tale posto a Mosca. Nel 1930 mi si chiese di restarvi per un certo tempo con la prospettiva di andare a lavorare nell’America Latina. Declinai l’offerta, sostenendo che il mio posto di lavoro era in Italia. Togliatti fu d’accordo con me ed i compagni del segretariato del Kjm non insistettero.
Il mio terreno d’azione dal 1919 ad oggi, in libertà e in carcere, è sempre stato l’Italia (salvo la parentesi del soggiorno a Basilea e a Parigi negli anni 1928-29). Dall’aprile 1931 all’agosto 1943 rimasi prigioniero del fascismo – un anno di carcere lo avevo già scontato a Trieste prima delle leggi eccezionali, – ma tutt’altro che inattivo.
La mia attività come quella di altri compagni non fu meno intensa in carcere e al confino. Appena liberato fui riassorbito nel gruppo dirigente del partito quasi non avessi mai cessato di farvi parte.
Conobbi personalmente Stalin, per la prima volta soltanto nel dicembre 1947; lo incontrai qualche altra volta negli anni successivi. L’ultimo colloquio lo ebbi poco tempo prima della sua morte. Non ho mai scritto un solo articolo di esaltazione dei processi e delle fucilazioni che a partire da un certo periodo nell’Unione Sovietica, e non soltanto negli anni in cui tali articoli non avrei potuto scrivere perché con altri compagni godevo del privilegio di trovarmi in carcere, ma neppure dopo il 1945 quando ricoprivo posti di alta responsabilità nel partito. Il solo articolo di approvazione di una fucilazione lo scrissi per Rinascita nell’agosto del 1953 in occasione dell’avvenuta fucilazione di Beria.
Ho invece scritto più di un articolo esaltante la Rivoluzione d’Ottobre, l’Unione Sovietica, la sua funzione nel mondo e la figura di Stalin come dirigente politico e uomo di Stato di primo piano, come teorico, esperto militare e grande combattente per la rivoluzione e per il socialismo. Molte delle cose scritte in proposito (tolta la fraseologia iperbolica, allora di rito) le firmerei ancora oggi, poiché tale egli veramente fu, malgrado tutto.
Nel periodo in cui mi trovavo a Ventotene, ebbi occasione di scrivere su uno dei quaderni del confino, una modesta recensione critica sulla ‘Storia del partito comunista bolscevico’ che si diceva elaborata da Stalin o scritta sotto la sua direzione (eravamo riusciti ad averne una copia o due, se non erro, nel 1939). I quaderni di appunti e studi su questioni diverse, li facevamo leggere, sia pure tra una cerchia ristretta: ciò serviva alla circolazione delle idee e al dibattito. Alcuni amici miei che ricordavano di aver letto allora quelle poche pagine, mi consigliarono anni fa di pubblicarle per sfatare certe leggende ed a dimostrazione che non eravamo cervelli in frigorifero, e certi problemi ce li ponevamo anche in carcere e al confino. Non lo feci prima e neppure dopo il XX [Congresso del Pcus], mi sembrava un peccato di immodestia e di esibizionismo, per di più ciò sarebbe potuto apparire come un tentativo di separazione di responsabilità. A parte gli errori che nell’attività e nella lotta politica ognuno compie personalmente – e io non ne sono certo esente – è ovvio che chi fa parte di un organismo dirigente è corresponsabile di tutta l’attività del proprio partito, dei successi e degli errori, delle vittorie e delle sconfitte e ne è tanto più responsabile quanto più alto è il posto di direzione che occupa.
Tutto il periodo della cosiddetta “stalinizzazione” dei partiti comunisti, come molti altri miei compagni, lo avevo trascorso in prigionia e non avevamo partecipato pertanto al processo graduale (con i suoi aspetti positivi e negativi) attraverso il quale erano passati i dirigenti dei partiti comunisti in quegli anni.
Nel 1930-31 Stalin, pur godendo di grande ascendente e autorità, non era ancora considerato dai partiti comunisti l’onnipotente, l’infallibile, non era ancora cominciata l’epoca della sfrenata esaltazione; i dirigenti del Pci tra di loro lo chiamavano scherzosamente “don Peppino”. Ricordo che quando nel dicembre 1928 tenne quel tal discorso contro Tasca, qualcuno di noi commentò: “don Peppino ha calzato gli stivali”, ma aggiungemmo anche: “l’ha azzeccata in pieno, non ci ha messo molto a conoscere a fondo Tasca, ha colpito a segno”.
I tenebrosi processi, le grandi purghe, le smisurate esaltazioni, non erano ancora cominciati. Avvennero quando già ci trovavamo in carcere e al confino. Ne fummo colpiti, amareggiati, discutemmo vivacemente anche. Alcuni di noi avevano conosciuto personalmente Bucharin, Kamenev, Trotskij, Zinovev, ed altri. Certe cose sembravano inverosimili, assurde, incredibili. Prevalse sempre in noi la fiducia nel partito, nell’Internazionale Comunista e nell’Unione Sovietica.
Non che non avessimo dei dubbi, le cose erano tutt’altro che chiare, ci era difficile trovare delle spiegazioni che appagassimo noi stessi. Ai pochi compagni che, allora, al confino, si staccarono dal partito, in seguito a questi avvenimenti, noi non avevamo chiesto, non chiedevamo fiducia cieca, ma fiducia nella causa per cui lottavamo; non pretendevamo dovessero rinunciare ai loro dubbi, che erano anche i nostri, ma chiedevamo disciplina, consigliavamo di attendere prima di prendere delle decisioni di rottura. “Noi qui al confino siamo prigionieri del fascismo, dobbiamo essere uniti, non ponetevi contro il partito. Aspettatevi di acquistare la libertà e poi forse verremo a conoscere cose che qui ignoriamo e non ci sono chiare”.
Quando compagni autorevoli giunsero a Ventotene nel 1941-42, con i garibaldini di Spagna, esternammo loro il nostro disaccordo sull’esaltazione frenetica di Stalin sulla stampa del partito (a Ponza e a Ventotene riuscivamo ad averla clandestinamente). La risposta che ricevemmo fu: “voi qui siete da anni staccati dal partito e dalla realtà nazionale e internazionale, non avete compiuto giorno per giorno, quasi inavvertitamente, lo stesso processo compiuto da noi.
Sul principio anche noi avevamo dei dubbi su certe esaltazioni che andavamo via via in crescendo, ma poi ci convincemmo che era giusto fosse così. Ci vuole un “capo” amato, stimato, indiscusso; esso rappresenta delle qualità eccezionali”.
E discutemmo a lungo, allora, su e giù per la piazza del Castello a Ventotene, di quella che noi, allora, chiamavamo l’esagerata, l’illimitata esaltazione del “capo”.
Sulle critiche che muovevamo alla ‘Storia del partito comunista bolscevico’, ci si fece notare che si trattava di una “breve” storia, di una esposizione sommaria, un manuale che non poteva essere esauriente, rispondere a tutti i come e i perché. L’argomentazione non persuadeva molto: non si trattava del numero delle pagine, ma del metodo seguito e dall’impostazione dell’opera. Ma tutto finì lì, che poi le cose per noi assillanti e di cui ci occupavamo ogni giorno erano altre: l’allacciamento dei contatti col paese, la corrispondenza coi gruppi comunisti di diverse località, non collegati con alcun centro, e per i quali noi rappresentavamo il centro dirigente. Giaime Pintor ci aveva soprannominati “il governo di Ventotene”.
Comunque, che io avessi a suo tempo mosso delle critiche a quello che poi si chiamò “il culto della personalità” e alla storia del partito comunista bolscevico che si diceva scritta da Stalin, che non avessi mai scritto articoli di esaltazione dei processi e delle fucilazioni (d’altronde non ero il solo), che avessi cercato nel momento del tenebroso processo di Praga e delle esecuzioni di Slansky, Geminder, ed altri di aiutare qualcuno, che nel 1951 mi fossi opposto sino all’ultimo a prendere il provvedimento politico nei confronti di un compagno italiano, ottimo combattente, soltanto perché era stato amico di Rajk (e potrei facilmente citare altri episodi) non diminuisce per nulla la mia piena corresponsabilità con l’indirizzo seguito dal Pci in quegli anni e gli errori commessi in rapporto al “culto della personalità” che non era soltanto il culto di Stalin, ma un metodo di direzione adottato dai partiti comunisti.
Perché con i precedenti accennati sono considerato ancor più di altri uno “stalinista”? Soltanto per la forza odierna dei mezzi di disinformazione? No. In primo luogo perché a differenza di altri che, lui vivo, avevano scritto i poco edificanti articoli di esaltazione delle fucilazioni, delle repressioni, e dei tenebrosi processi, affrettandosi poi, quasi a liberarsi da un peso, a dargli addosso dopo morto, io fui con quei compagni che non sentirono alcun bisogno di associarsi a tale mortificante spettacolo.
Anche dopo il XX Congresso ho cercato sempre di distinguere tra gli atti delittuosi, gli inammissibili metodi di lotta impiegati all’epoca di Stalin, che non possono che essere condannati come si condanna ogni elemento di tirannia, e l’opera sua di rivoluzionario, di uomo di Stato, di combattente per il socialismo che è stata largamente positiva e non può essere buttata via insieme all’acqua sporca. Il giudizio su Stalin deve tenere conto degli elementi positivi e di quelli negativi, delle drammatiche e sconcertanti contraddizioni della sua personalità, oltre che di tante altre implicazioni sino ad oggi tutt’altro che chiarite.
Ma non si tratta soltanto di questo. Certuni hanno salutato il XX e il XXII Congresso del Pcus non tanto perché rivelarono i “delitti” commessi e le gravi violazioni delle legalità socialista, non tanto per la spinta che essi imprimevano al “disgelo”, al ritorno ad una reale vita democratica, al dibattito, al diritto al dissenso (quali noi anziani avevamo conosciuti) in seno ai partiti comunisti, ad una vivace iniziativa, ad una più giusta concezione del centralismo democratico, ma perché ritennero che quei congressi aprissero un periodo di completa revisione del marxismo e del leninismo.
Si fecero avanti certe spinte di coloro che intendevano liquidare non tanto i gravi errori e i delitti, ormai irreparabili, di certi periodi dell’epoca staliniana, certi metodi di direzione allora introdotti, le incrostazioni burocratiche, gli schematismi, il dogmatismo, l’infallibilità dei gruppi dirigenti e dei rispettivi segretari generali, ma l’indirizzo rivoluzionario di una politica di classe. Ciò che taluni intendevano liquidare erano le posizioni di principio e pratiche del marxismo e del leninismo, l’internazionalismo proletario, l’impostazione strategica della lotta mondiale unitaria contro l’imperialismo e per il socialismo.
L’opposizione al dogmatismo, allo schematismo, all’accettazione acritica e supina di tutte le direttiva che vengono dall’alto, la necessità del dibattito, della circolazione delle idee, dell’iniziativa nel lavoro e nell’azione, tutte cose che mi trovano sempre concorde, non hanno nulla a che fare con la tolleranza verso il revisionismo, il socialdemocraticismo, e con l’abbandono dei principi rivoluzionari e internazionalisti che sono alla base dei partiti comunisti.
La necessità di una strategia unitaria antimperialista, la necessità della lotta per il socialismo, esige la massima mobilitazione e il più stretto coordinamento delle lotte di tutte le forze rivoluzionarie, da quelle scaturite dalla Rivoluzione d’Ottobre a quelle che si sono presentate sulla scena politica dopo la seconda guerra mondiale e in questi anni; esige il coordinamento delle energie rivoluzionarie ideali e materiali dell’Unione Sovietica – la cui funzione non può essere sottovalutata – e dei paesi socialisti con le forze di tutti i movimenti rivoluzionari dell’Asia, dell’America Latina, dell’Africa, con quelle del movimento operaio dei paesi capitalisti.
Ecco alcune idee che sono andato sostenendo; ma dopo il XX Congresso e il grande “rinnovamento” si ritenne necessario, per rendere più facile la comprensione del nuovo indirizzo e più efficace l’applicazione della nuova politica, che in ogni partito comunista vi fosse qualcuno, e più di uno, apertamente o allusivamente etichettato come “stalinista”.
Il vino nuovo, si disse all’epoca del VIII Congresso del Pci, non può essere versato nelle botti vecchie. E sia, anche se fra tante botti io non ero certo la più vecchia, né avevo mai stagionato nelle cantine di Stalin.
Ma tant’è, così va il mondo, o per dirla col Manzoni, così andava nel secolo Decimosettimo.
Pietro Secchia, L’azione svolta dal partito comunista in Italia durante il fascismo 1926-1932, Feltrinelli, Milano, 1970

Con Pietro Secchia, si percorre una sorta di “filo rosso” a partire dalla fase immediatamente successiva alla nascita del Partito Comunista d’Italia, nel contesto dell’affermazione del fascismo, alla Resistenza ed alla Liberazione, dalle contromisure da adottare, all’atteggiamento da tenere nelle diverse fasi, alle diverse modalità di lotta, a partire dalla resistenza armata fino alla sua morte nel ’73, a causa dell’avvelenamento subito nel suo viaggio in Cile per mano della CIA.
Già all’età di 16 anni, Secchia, costituisce il primo circolo socialista del proprio paese, Occhietto, nel biellese, sotto l’influenza dell’Ordine Nuovo e dell’esempio della grande Rivoluzione d’Ottobre, che nel corso della sua vita comunista mai lo abbandoneranno. Fin dai primi anni della loro fondazione, Secchia fu uno dei principali animatori, organizzatori e dirigenti della FGCI e del PCI, tra i più attivi quando nel 1931 venne arrestato dai fascisti e imprigionato per 12 anni. Concepì la sua vita come instancabile militante, dirigente, organizzatore, interprete coerente e creativo dell’insegnamento di Lenin e fedele ai principi della III Internazionale, lottando contro le deviazioni di “destra” e di “sinistra” e dando un contributo fondamentale nella concezione del Partito e della lotta in clandestinità contro il regime fascista e per la costruzione ovunque dell’organizzazione di Partito. Fu sempre presente in lui la capacità straordinaria di condurre una analisi concreta sulla situazione concreta, sulla base dei principi del marxismo-leninismo, studiando le contraddizioni, i rapporti di forza, l’individuazione del nemico e del modo migliore per combatterlo unendo le masse popolari intorno alla classe operaia. Così concepì la lotta al fascismo come parte integrante della lotta di classe, da condurre attraverso il “Fronte Popolare”, senza perdere l’autonomia e prospettiva rivoluzionaria propria dell’avanguardia della classe operaia, in cui la strategia insurrezionale era volta anche allargamento dello stato d’agitazione per la rivoluzione contro il potere borghese e il capitalismo. Non sottomise quindi gli interessi del proletariato a quelli della nazione, ma al contrario concepiva che gli interessi del proletariato erano quelli della nazione, lottando incessantemente contro l’attendismo e per l’organizzazione della Resistenza in ogni fabbrica, in modo che gli operai fossero poderosa parte attiva nella lotta e la fabbrica “il fulcro della lotta contro i tedeschi e i fascisti, le agitazioni degli operai appoggiarono le azioni partigiane e queste a loro volta contribuirono a rendere più facile il successo delle rivendicazioni dei lavoratori”. Secchia, diede un grande contributo all’organizzazione della Resistenza, che fu un processo tutt’altro che spontaneo che egli stesso ricorda così: “Se nei grandi scioperi del marzo 1943 e nei movimenti popolari del 25 luglio e dell’8 settembre 1943, il Partito comunista italiano si trovò ad essere alla testa delle masse in lotta, ad essere alla testa del movimento partigiano e della guerra di liberazione nazionale, questo lo si deve all’azione da esso svolta durante tutto il ventennio fascista. Preoccupazione costante del partito in quegli anni «neri» non fu, solo quella di rafforzare la sua organizzazione clandestina, ma un grande sforzo venne compiuto per organizzare, sia pure in forme elementari, le masse dei lavoratori, per sviluppare un’attività sindacale, per rimanere a contatto con le masse degli operai delle città e con i lavoratori delle campagne e soprattutto per riuscire a promuovere e a dirigere le agitazioni, gli scioperi, i movimenti di malcontento, le azioni di lotta contro il fascismo”.
Difenderà sempre questo carattere della Resistenza, che non fu un percorso unitario e che vide enormi contraddizioni tra le forze politiche di classe che sostennero e si impegnarono nella lotta armata per convinzione, e i partiti borghesi che agirono per convenienza, spesso con l’obiettivo di minare fin da subito la profonda portata progressista e innovatrice nella Resistenza. Nel maggio del ’45 Secchia afferma che: ”Il rinnovamento che noi chiediamo non deve limitarsi ad un semplice ed ordinario rimaneggiamento ministeriale, al cambio di qualche persona, ma deve essere una vera e propria svolta nella vita politica italiana, deve significare la eliminazione radicale delle cricche reazionarie dalla direzione del paese, deve voler dire governo del popolo, governo delle forze che sono state l’anima e la forza della nostra insurrezione nazionale”, ribadendo a gran voce la necessità dell’epurazione degli “agenti dello straniero” dalle officine, dagli uffici, dall’amministrazione pubblica, dall’esercito, dalla polizia, dalle scuole, individuandoli non solo in quelli che portavano il “distintivo fascista” ma identificandoli nei nemici dei lavoratori, nei reazionari di tutte le risme che si sforzano di coalizzarsi. Parole che già annunciano il pericolo di ciò che divenne realtà nel ’47, col tradimento dell’ “unità nazionale” da parte della Democrazia Cristiana con l’estromissione dal governo dei comunisti, con l’inizio di un periodo di forte repressione anti-operaia, in cui l’Italia con De Gasperi diventa il nemico numero uno dell’Est e del Socialismo, alle volontà degli USA. Pietro Secchia, in questo contesto si recò in URSS per un incontro segreto con Stalin, Zdanov e altri dirigenti del PCUS, nel quale si evidenziano tutti i punti critici della politica togliattiana dell’ “unità nazionale”, tanto che dopo gli attentati a Togliatti nel 1950, Stalin propose di “spostare” Togliatti dal ruolo di Segretario del PCI destinandolo al pur importante ruolo di direzione del Cominform, cosa che avrebbe condotto alla nomina di Secchia a Segretario del PCI. Proposta approvata dalla Direzione del PCI, ma rifiutata da Togliatti.
Salvatore Vicario
Redazione, Introduzione a Pietro Secchia, Senza Tregua, 19 dicembre 2013