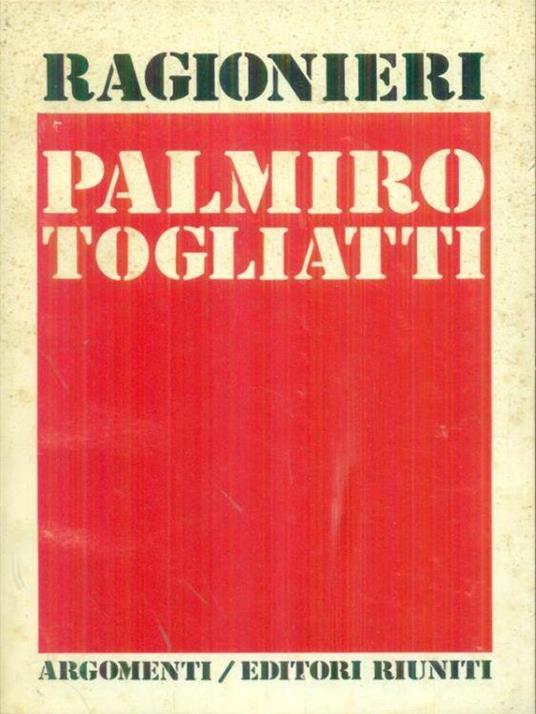
I comunisti che non si piegarono al Patto con Hitler
I dirigenti che ruppero col Pci per il Patto con Hitler furono solo tre. Uno in esilio in Francia e due al confino di Ponza-Ventotene. Un discorso a parte merita Tina Modotti <8.
Il primo fu Romano Cocchi («Adami», 1893-1944) militante antifascista di lunga data le cui origini risalivano al Partito popolare e al Partito cristiano del lavoro. Egli ricopriva importanti cariche nel variegato arcipelago delle associazioni legate al Pci, ma era in particolare il segretario generale dell’Unione popolare italiana. Fondata nel 1937, essa pubblicava in Francia La Voce degli Italiani stampato a decine di migliaia di copie.
Il Partito lo espulse per la sua protesta contro il Patto con Hitler e Togliatti lo diffamò. Dopo alterne vicende di partecipazione alla Resistenza francese, fu catturato dai nazisti, deportato nel settembre 1943 a Buchenwald dove morì a marzo 1944.
L’altro dirigente comunista che avversò il Patto con Hitler fu Umberto Terracini (1895-1983). Questo molto anomalo e molto incoerente dirigente comunista – che da bordighiano era stato criticato da Lenin nel 1920-21 per il suo estremismo, poi staliniano, finendo col diventare un «padre della Patria» cofirmando a dicembre 1947 la Costituzione italiana insieme a Enrico De Nicola e ad Alcide De Gasperi – all’epoca era confinato a Ponza, avendo già scontato 11 anni in carcere.
Dopo lo scoppio della guerra e prima dell’aggressione nazista all’Urss, egli scrisse una «Piattaforma», un testo lungo e prolisso indirizzato a Ruggero Grieco in cui criticava apertamente l’errore compiuto con la firma del Patto Molotov-Ribbentrop e anche la passività con cui il Pcd’I aveva fatto propria quella scelta. Vi affermava che l’hitlerismo doveva restare il nemico principale e che i comunisti avrebbero dovuto lottare per la vittoria dell’Inghilterra. Benché fosse pur sempre un paese imperialista, Terracini non la considerava alla stessa stregua del nazismo. Non poteva ovviamente immaginare che di lì a breve quella posizione sarebbe diventata ufficiale per l’Urss e il Pci.
Alle sue posizioni contrarie al Patto con Hitler si associò Camilla Ravera (1889-1988), anch’essa confinata a Ponza e poi a Ventotene.
Il testo di Terracini e altre questioni che qui sarebbe lungo richiamare, provocarono la sua espulsione dal Partito, nel quale verrà riammesso nel 1943 senza che all’esterno trapelasse alcunché della sua espulsione. Il documento lo ha reso pubblico solo nel 1976, nel suo secondo libro dedicato alle divergenze con il Pci (Al bando dal Partito, La Pietra, pp. 37-54).
Camilla Ravera fu espulsa a sua volta, ma venne reintegrata nel 1945 per intervento di Togliatti, intraprendendo una carriera politica che la porterà ad essere la prima donna senatrice a vita della Repubblica italiana.
Terracini è poi tornato sull’argomento, in forma più sintetica ma molto dura nella sostanza, nell’Intervista sul comunismo difficile, realizzata da Arturo Gismondi (Laterza, 1978). Vale quindi la pena di ascoltare ciò che ebbe a dire, perché dalle sue parole emerge un quadro drammatico, ma veritiero, dell’abisso politico-ideologico in cui era precipitato il Pci nel biennio del Patto con Hitler:
«Così i compagni accettarono, senza subire alcuna crisi, anche l’annuncio del Patto, del quale anzi cercarono di scoprire in ogni modo una qualche giustificazione. E in ciò si spinsero, teorizzandone la bontà, certo al di là delle stesse intenzioni di Stalin. Dal mero campo dei rapporti fra gli Stati, non mancò chi cercò di portare il discorso nel campo ideologico, dei princìpi perenni, con quali mostruosità di teorizzazioni si può immaginare» (pp. 119-20). «Ma da parte dei compagni si fece assai di più [di Stalin], ci si spinse a dare motivazioni di tipo ideologico e dottrinale dell’atteggiamento dell’Urss. Si riprese a sostenere una sorta di equidistanza, di indifferenza tra le democrazie occidentali e Hitler, e la Germania nazista. Si accennava anche a qualcosa di peggio, a vedere nelle correnti democratico-borghesi il nemico peggiore, il più insidioso, o l’ultimo» (p. 122).
Gli storici più coscienziosi hanno da tempo accertato la fondatezza di quanto qui viene raccontato, ma ciò non toglie che vi sia ancora la possibilità di stupirsi sentendolo dire da un interprete diretto della scabrosa vicenda, dotato per giunta di un grande prestigio storico-istituzionale. Che piaccia o no, in queste parole di Terracini si coglie la descrizione di un incipiente trasformazione hitlero-comunista dell’ideologia del Pci nel biennio in esame, che non poté protrarsi solo per l’aggressione nazista all’Urss. Una testimonianza così autorevole dovrebbe quindi togliere ogni dubbio sullo stato di degenerazione politica e ideologica che il Patto con Hitler aveva indotto tra le sparute file del partito e in primo luogo ovviamente tra i suoi quadri dirigenti.
Sarà chiara ora la ragione per cui furono fatti scomparire i verbali e i testi di analisi e di propaganda scritti nel periodo maggio 1939-marzo/aprile 1940 (che non è escluso, però, possano un giorno riemergere dagli archivi russi e del Comintern). E si potrà ora riflettere anche sul tentativo compiuto dagli storici compiacenti per attenuare la portata della svolta politico-ideologica vissuta in quel biennio.
E se Paolo Spriano aveva dovuto bene o male fornire un’interpretazione velatamente critica di quella sciagurata vicenda, altri preferiranno tacerla del tutto, alla maniera del principale e più grossolano agiografo del togliattismo: Ernesto Ragionieri (1926-1975). All’argomento Patto Hitler-Stalin questi neanche accenna nel suo monumentale Palmiro Togliatti (Editori Riuniti 1976), benché il suo soggetto prediletto si trovasse a propagandare tale Patto nella veste di secondo segretario del Comintern, addetto al Centroeuropa, cioè nell’occhio geopolitico del ciclone.
Leo Valiani e Altiero Spinelli
Per completezza d’informazione, ricorderò che al Patto si opposero due noti intellettuali di provenienza comunista: Leo Valiani (italianizzazione nel 1927 di Weiczen [1909-1999]) che ruppe col Pci proprio in seguito all’alleanza con Hitler. Non solo denunciò il Patto in quanto tale, ma commise il sacrilegio irreparabile di dichiarare che esso confermava che Trotsky aveva avuto ragione a partire dal 1938 annunciando che Stalin e Hitler avrebbero finito coll’allearsi. Espulsione immediata <9.
Mentre Altiero Spinelli (1907-1986) – «padre fondatore» dell’Unione Europea – denunciò il carattere reazionario del Patto; ma per altre divergenze era stato già espulso dal Pci nel 1937, durante il confino a Ponza. Era passato poi a Ventotene dove, insieme a Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, scrisse il celebre Manifesto di Ventotene, primo documento programmatico del federalismo europeo.
Opportunismo e autosublimazione repressiva
Il lettore si chiederà a questo punto se nel Pci vi fossero stati in precedenza, prima cioè dell’accordo con Hitler, dei sintomi premonitori dell’adesione al nuovo orientamento di Stalin e del Comintern. Secondo quanto afferma Terracini, in entrambi i testi citati, le radici della nuova «svolta» andrebbero cercate nella prima famigerata «svolta», cioè nella linea del Terzo periodo con la caratterizzazione dei socialdemocratici, i «socialfascisti», come nemici principali di cui si è parlato: e l’adesione acritica al Patto con Hitler starebbe a dimostrare che il VII Congresso del Comintern non aveva cancellato del tutto quell’esasperata forma di settarismo politico.
Non è però così semplice e la questione continua ad essere inspiegabile se ci si limita ad analizzare solo elementi d’ordine politico. Perché, comunque la si rigiri, rimane il fatto che i comunisti italiani, benché cresciuti in un contesto di dura opposizione al fascismo e ancor di più al nazismo, si trovarono a un certo punto coinvolti in un’alleanza con Hitler: un’alleanza, per giunta, non soltanto economica o culturale, ma addirittura militare, in un contesto di guerra guerreggiata e per ben 22 mesi. Anche se, allo scadere del periodo – con l’aggressione nazista all’Urss (giugno 1941) – tornarono precipitosamente alla formazione ideologica delle origini, cioè a considerare come principali nemici il fascismo e il nazismo, e non più i socialdemocratici con le relative «democrazie» occidentali. Se non è schizofrenia questa…
E in effetti entra in gioco anche la psicologia umana, da considerare nel bene e nel male delle sue manifestazioni caratteriali. I comunisti italiani di quel biennio – cioè le poche centinaia di militanti sopravvissuti a tutti i disastri precedenti, alle «svolte», alla repressione fascista e anche a quella moscovita – erano pur sempre esseri umani, cittadini di un paese passato attraverso una trasformazione che potremmo dire «epocale», che vivevano la sorte poco felice di dover lavorare, nutrirsi e studiare sotto l’egida di un regime totalitario la cui natura continuavano a non capire.
Sbandati, dunque, ma irreggimentati ferreamente nell’apparato stalinista italiano e, per alcuni dirigenti, anche in quello del Comintern. Poiché non è immaginabile che tutte le loro posizioni fossero prodotti puri e semplici delle farneticazioni di Stalin e della traduzione organizzativa che ne fornivano Togliatti, Berti, Grieco, Donini, Negarville ecc., occorre trovare un secondo fattore, altrettanto potente, di autopersuasione per spiegare la temporanea svolta filohitleriana, apparentemente così contronatura. E questo secondo principale fattore va individuato nella logica d’apparato, nel fascino della disciplina gerarchica, nel culto del Capo, nel fanatismo partitico e, per alcuni, anche nel senso d’appartenenza a una comunità di eletti: un tremendo connubio di narcisismo e paranoia, santificato dall’aureola del sacrificio personale, quando non addirittura del martirio (purtroppo reale).
Era la logica di un apparato presuntamente «leninista» (anche se col bolscevismo prerivoluzionario non aveva nulla a che vedere), cioè ferreo ed esasperatamente gerarchizzato, che rendeva i comunisti italiani (ma lo stesso dicasi per altri Paesi) succubi del Comitato centrale, quindi dell’Ufficio politico e della Segreteria: tutti organi dirigenti infeudati a Mosca e a Stalin. Questa identificazione «totalitaria» con i vari livelli della gerarchia di partito li consegnava inermi all’accettazione integrale di ogni svolta, ogni menzogna, ogni istigazione proveniente da Mosca o dal suo apparato, purché l’esecuzione e la conseguenza dell’ennesimo diktat (o ukaz) fossero conformi al famigerato principio del fine che giustifica i mezzi.
Difficilmente il lettore riuscirà a trovare un altro tipo di spiegazione, politica o culturale, che non sia riconducibile a uno stato perverso di autosublimazione repressiva per le tante svolte brutali e spesso autodistruttive, ivi inclusa quella di cui ci stiamo occupando.
Un’idea del trauma che i comunisti italiani si dovettero autoinfliggere nel biennio di collaborazione col nazismo, può fornirla un testo nel terzultimo numero prebellico de Lo Stato Operaio (Parigi, n. 10, 15 giugno 1939, p. 227), in cui ancora si denunciava il cosiddetto «Patto d’Acciaio» tra Italia fascista e Gemania nazista, firmato a Berlino il 22 maggio, senza immaginare la nuova svolta di due mesi dopo <10.
«Gli alleati del popolo italiano non sono i tedeschi hitleriani, né i militaristi giapponesi, né i falangisti spagnoli. Gli alleati del popolo italiano sono: la classe operaia internazionale ed i popoli di tutti i paesi che vogliono la pace e lottano per la pace. Perciò, il popolo italiano è dalla parte di questi alleati, dei quali deve aiutare attivamente gli sforzi per l’unione e per la resistenza all’aggressore fascista. Per queste ragioni, che corrispondono ai suoi interessi e ai suoi ideali, il popolo italiano è solidale con le correnti popolari dei paesi occidentali che sostengono la necessità e l’urgenza dell’alleanza difensiva anglo-franco-sovietica, sulla base della reciprocità assoluta tra queste potenze. Questa alleanza potrà garantire e difendere la pace» <11.
I comunisti italiani passarono da parole di così netta opposizione antihitleriana e di ricerca di un accordo con le «democrazie», all’accettazione dell’alleanza coi nazisti nel breve arco di due mesi. Una spiegazione secondo criteri storico-politici sarà quindi insufficiente se non si prende in considerazione anche la componente psicopatologica.
[NOTE]
8 Vidali approvò il Patto e passò due settimane in un carcere messicano, accusato di spionaggio filotedesco, mentre la celebre fotografa udinese vi si oppose. Lo confermano varie fonti, e anche una biografa filostaliniana (Christiane Barckhausen-Canale) ha dovuto ammetterlo nell’appendice aggiunta (ed. it. 2003, p. 229), ma non nella 1ª ed. di Verdad y leyenda de Tina Modotti, Casa de las Américas, La Habana 1989.
Il Patto allontanò Tina definitivamente da Vidali e dal Sri, di cui era stata fervida organizzatrice. Ma conosceva troppi segreti e per questo fu quasi certamente fatta morire a gennaio 1942, in taxi a Città del Messico, nell’identico modo in cui verrà fatto morire (altrettanto quasi certamente) Victor Serge a novembre 1947: arresto cardiaco, taxi, stessa città. Le prove non ci sono, ma sono tali e tante le coincidenze, da non lasciar dubbi sulla natura cruenta dei due decessi (per Serge ne parlai col figlio Vlady a Cuernavaca). Ritengo però che Vidali fosse all’oscuro, benché approfittò del «favore» fattogli dai servizi sovietici, sposandosi pochi mesi dopo con Isabel Carbajal Bolandi da cui ebbe un figlio l’anno seguente.
9 Sulla propria espulsione, si veda la bella lettera, piena di dettagli interessanti, che lo stesso Valiani («Paul Chevalier») scrisse a Spriano a marzo 1970 (in Storia del Pci, III, p. 329n.).
10 Non a caso la rivista chiuderà col n. 12 (15 agosto), cioè quando era ormai chiaro che il Patto stava per essere siglato. Riaprirà a New York a marzo 1940 sotto la direzione di Berti e Donini – due dei più ligi stalinisti dell’apparato – per chiudere definitivamente a dicembre 1943.
11 L’articolo è incluso anche nell’antologia de Lo Stato operaio 1927-1939, curata da Franco Ferri, Ed. Riuniti, 1964, p. 648.
Piero Bernocchi e Roberto Massari, C’era una volta il Pci… 70 anni di controstoria in compendio, Massari editore, Bolsena (VT), 2021
La stampa clandestina del partito, allora certo limitata nella sua diffusione e nella sua effettiva capacità di influenzare il corpo sociale del paese, non aveva mancato di dare risalto ai nuovi accenti patriottici della propaganda comunista: al punto che «l’Unità» aveva lanciato una vera e propria “campagna per la difesa degli interessi della nazione e contro la politica anti-italiana del regime”, costantemente definito “profondamente antinazionale <36”.
Questa prima formulazione dell’antifascismo patriottico e popolare del PCI ebbe però vita breve. Nell’estate del 1939, infatti, la firma del patto Ribbentrop-Molotov e il conseguente orientamento filo-tedesco della politica di Mosca, costrinsero le voci comuniste a ridimensionare drasticamente i propri accenti para-nazionalistici dal carattere rigidamente anti-nazista, per tornare a coltivare più puri orizzonti rivoluzionari che poggiavano sulle consuete dinamiche socio-economiche e sulla dimensione internazionale della lotta di classe. In quel periodo, come è noto, la traiettoria politica del comunismo mondiale tornò ad essere appiattita sulla classica prospettiva anticapitalista e anti-imperialista che, in perfetta sintonia con le nuove esigenze tattiche della geopolitica sovietica, rifiutava la distinzione tra fascismo e antifascismo (entrambi considerati prodotti della detestata società capitalistica) e, con essa, respingeva le logiche di ogni possibile frontismo nazional-popolare <37. Pure in Italia, l’impostazione retorica della politica comunista dovette quindi adeguarsi ai nuovi canoni derivanti dall’abbandono della linea frontista: anche al costo di compromettere o disperdere completamente le preziose sinergie politiche, faticosamente raggiunte, proprio in quegli anni, sul frastagliato versante antifascista (su tutte, ovviamente, quella con i compagni socialisti, bruscamente allontanati dal rilancio della teoria del socialfascismo <38). Per il partito italiano, dunque, tornarono ad essere centrali le suggestioni rivoluzionarie di stampo prettamente classista e internazionalista, che derubricavano scientemente il tema della conflittualità tra fascismo e antifascismo, etichettandolo come un fatto tutto interno a una classe dirigente borghese da abbattere in toto. Nel discorso politico del PCI di quegli anni si fece strada addirittura un programmatico auspicio disfattista che, sebbene indirizzato al rovesciamento del regime e dello status quo capitalista (considerato premessa indispensabile per ogni possibile sviluppo rivoluzionario nella penisola), certo mal si conciliava con un’ancorché debole declinazione patriottica della proposta politica comunista <39. Nell’agosto del 1939, una direttiva politico-propagandistica diramata dalla “segreteria del centro estero del PCI” si soffermava, in
termini piuttosto cinici, proprio sul delicato tema dell’attesa della disfatta, ammonendo circa il fatto che, nell’eventualità – avvertita come assai concreta – di una degenerazione bellica delle tensioni internazionali “i comunisti italiani lavoreranno con tutti i mezzi per la disfatta del fascismo. (…) Si tratta, in fondo, di sapere utilizzare il malcontento provocato dalla guerra e, sin da adesso, dalle misure di guerra, tra le masse italiane, allo scopo di indirizzarlo contro il regime fascista. (…) La sconfitta è terribile, ma è il minor male per il nostro popolo, perchè offrirà al nostro popolo la possibilità di liberarsi dal male maggiore che è il fascismo”. <40
Per ritrovare nella propaganda comunista i toni spiccatamente patriottici sperimentati tra il 1936 e il 1939, si dovette attendere, perciò, l’attacco tedesco all’Unione Sovietica.
[NOTE]
36 LUSSANA F., «L’Unità» 1924-1939. Un giornale “nazionale” e “popolare”, Torino, Edizioni dell’Orso, 2002, p. 293. Come sottolinea l’autrice, figure centrali nell’elaborazione di questa pionieristica campagna “nazionale” del giornale comunista furono quelle di Mario Montagnana e di Emilio Sereni.
37 QUAGLIARIELLO G., Il PCI, il PCF e le conseguenze del patto Molotov-Ribbentrop, in CATTARUZZA M., La nazione in rosso. Socialismo, Comunismo e “Questione nazionale”: 1889-1953, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005, pp. 241-196.
38 NATOLI C., Fascismo, democrazia, socialismo. Comunisti e socialisti tra le due guerre, Milano, 2000, pp. 102 ss.; cfr. anche COLARIZI S., L’Italia antifascista dal 1922 al 1940. La lotta dei protagonisti, Roma-Bari, Laterza, 1976, Vol 2., pp. 511
39 Il tema dell’attesa della sconfitta, considerata momento di catarsi politica e culturale, si riproporrà, seppure con implicazioni decisamente diverse, nel periodo della guerra di liberazione divenendo, come nota Ernesto Galli Della Loggia, un elemento fondamentale intorno al quale si articola il difficile rapporto tra Resistenza e idea di patria: cfr. GALLI DELLA LOGGIA E., La morte della Patria, Bari-Roma, Laterza, 1996, pp. 23 ss. Al tema, affrontato in una panoramica più ampia che va ben oltre lo specifico caso del PCI, ha dedicato pagine intense Claudio Pavone, nella sua fondamentale opera sulla guerra di liberazione italiana: PAVONE C., Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 63-77.
Fabio Calugi, Il tricolore e la bandiera rossa. Patria e interesse nazionale nel discorso pubblico del PCI togliattiano (1944-1947), Tesi di dottorato, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, 2010