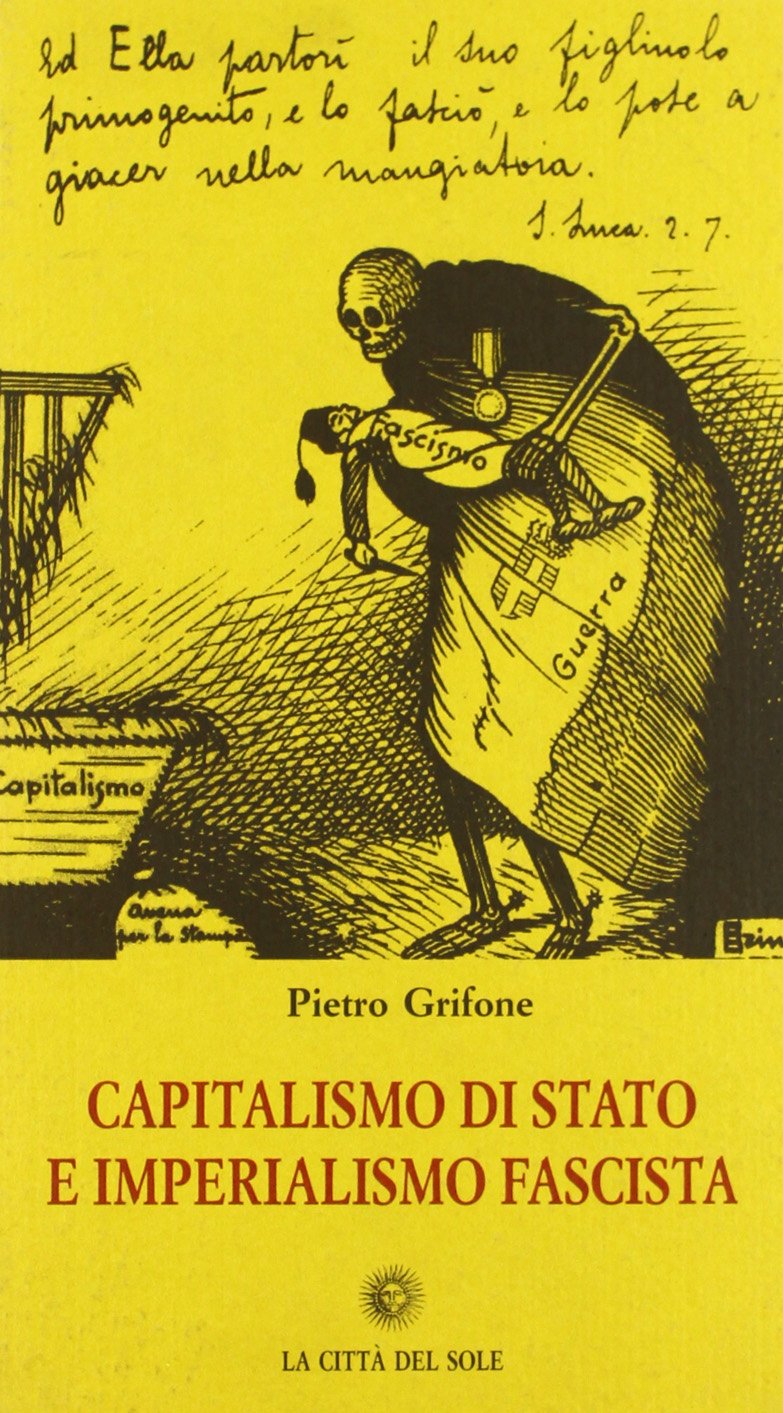
Nel periodo 1923-1939 lo sviluppo industriale riguardò soprattutto alcuni settori, come l’industria elettrica, quella siderurgica, quella automobilistica, quelle chimiche e poche altre. In generale lo sviluppo riguardò le grandi industrie e si collegò al processo di concentrazione delle imprese. Il processo di modernizzazione, che indubbiamente ci fu durante il fascismo, si accompagnò dunque ad una notevole accentuazione degli squilibri sia settoriali che territoriali. Questi ultimi in particolare si aggravarono, soprattutto per quanto riguarda il contrasto tra il Nord e il Sud. Inoltre nel campo agricolo, non solo fallì la politica di “ruralizzazione” ed ebbe risultati parziali il progetto di “bonifica integrale”, ma anche la “battaglia del grano” ebbe risultati diversi nel Nord (dove si accrebbe la resa per ettaro) e nel Sud (dove si estese invece la superficie coltivata a frumento); senza contare che la battaglia stessa, attuata in un periodo di diminuzione mondiale dei prezzi delle derrate e del grano in particolare, ebbe effetti negativi sul valore reale complessivo della produzione agricola.
Negli anni tra il 1934 e il 1939, le spese per il riarmo (peraltro riassorbite in gran parte dalla guerra d’Etiopia e dall’intervento in Spagna, quelle per l’organizzazione delle colonie e per le attrezzature costruite in AOI (1) e in Libia, la svalutazione della lira del 1936 e la linea moderatamente inflazionistica che ne seguì, la stessa politica autarchica determinarono una ripresa degli affari, uno sviluppo di alcune attività industriali, una lieve diminuzione della disoccupazione e un aumento dei salari nominali. Ma la politica autarchica e vincolistica provocò anche un accrescimento artificioso di produzioni poco convenienti per i loro costi eccessivi. In sostanza già si delineavano ormai alcune caratteristiche dell’economia di guerra.
Il bilancio dello Stato, i cui disavanzi erano già aumentati sensibilmente nel quadriennio 1935-1939, variò nel quadriennio dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1943 passando da un disavanzo di 29,4 miliardi di lire correnti per il 1939-40 a uno di 109,8 nel 1942-43. Se si distinguono le spese normali da quelle eccezionali (determinate in un modo o nell’altro dalla guerra), si rileva che le prime ammontarono complessivamente a 168 miliardi e 700 milioni e le seconde a 280 miliardi e 700 milioni in tutto il quadriennio. Per fronteggiare l’aumento enorme delle spese il governo dovette ricorrere principalmente ai debiti e all’inflazione monetaria; tuttavia, esso tentò anche di ricorrere all’aumento della pressione fiscale, ma, come già era avvenuto durante la prima guerra mondiale, con scarsissimo successo, a causa sia del carattere vecchio e complicato del sistema tributario italiano, sia della tendenza inveterata a favorire con vari espedienti i ceti abbienti nell’esazione delle imposte e nel perseguimento degli evasori, sia della difficoltà di accrescere il gettito delle imposte sui consumi, data la diminuzione generale dei consumi stessi determinata dallo stato di guerra.
Un’importanza molto maggiore per il finanziamento della guerra ebbero invece l’indebitamento dello Stato e l’inflazione. L’aumento del debito pubblico tra il febbraio ’40 e il giugno ’43 avvenne principalmente attraverso sei emissioni di Buoni del Tesoro novennali, che furono acquistati fino al ’42 in misura notevole da un pubblico abbastanza vasto di risparmiatori e di operatori economici, oltre che dalle banche e dagli enti pubblici, e servirono allo Stato per rastrellare in parte la carta moneta emessa per pagare le spese eccezionali. Questa era l’intenzione del ministro delle finanze Revel, che sperava di porre con queste emissioni di buoni un freno all’inflazione più efficace di quello che effettivamente fu posto. Ma questa speranza poteva realizzarsi soltanto “se si fossero verificate due condizioni fondamentali: il blocco effettivo dei prezzi e l’assenza della speculazione borsistica, del rialzo incontrollabile dei titoli azionari, che avrebbe stornato il risparmio dai titoli pubblici” (2). Ma il regime fascista non fu in grado di realizzare nessuna delle due condizioni, sia per difficoltà oggettive molto difficilmente sormontabili sia per la sua intima debolezza. Lo stato di guerra stimolando l’attività di molte industrie provocò un aumento generale dei profitti, sicché nelle Borse, pur con alti e bassi determinati dalla ripercussione delle vicende belliche e da ondate speculative, si verificò una forte tendenza al rialzo dei titoli azionari, che fecero concorrenza ai titoli di Stato nella raccolta del risparmio. Nel frattempo diminuì la fiducia nei titoli di Stato da parte dei medi e piccoli risparmiatori. Cominciò quindi a delinearsi un contrasto abbastanza evidente tra gli interessi dell’alta borghesia e quelli della borghesia piccola e media, cioè ad incrinarsi il blocco sociale che fino a quel momento aveva sostenuto il fascismo. Inoltre si accentuò la corsa dei ceti abbienti all’acquisto di beni rifugio: case, terreni, oro e oggetti preziosi, opere d’arte etc.
Il debito pubblico complessivo nei due quadrienni compresi tra il 1° luglio 1935 e il 30 giugno 1943 passò da 40,5 a 235,3 miliardi di lire correnti.
La politica autarchica, che implicò la riduzione forzata delle importazioni, aveva già provocato nel ’38 e nel ’39 una sensibile diminuzione delle materie prime disponibili per le industrie e di parecchi prodotti di largo consumo, che divennero rarissimi, come il caffè, o comunque molto costosi. Questo carenze si aggravarono in misura crescente durante la guerra, soprattutto a causa del blocco navale e della necessità di provvedere ai rifornimenti delle forze armate. La penuria di prodotti di ogni genere e l’inflazione divenuta galoppante tra il ’41 e il ’43, determinarono un generale aumento dei prezzi.
La diffusione del mercato nero dei prodotti alimentari avrebbe dovuto in teoria essere impedita o almeno molto limitata dal sistema degli ammassi obbligatori, introdotto per il grano fin dal 1936 e affidato nel ’38 alla Federazione italiana dei consorzi agrari, poi esteso ad altri prodotti, come la canapa, la lana, l’olio, i legumi, il riso ecc. Ma durante la guerra le norme relative agli ammassi furono via via sempre più frequentemente violate dai produttori, sicché nel corso del ’41 e più ancora del ’42 e del ’43 il ridotto conferimento delle derrate agli ammassi assunse grandi proporzioni, soprattutto nelle province meridionali e divenne quasi totale il mancato conferimento in Sicilia. Questo fatto, dovuto alla cattiva organizzazione dei controlli amministrativi, e la riduzione complessiva della produzione agricola provocata dalla guerra (scarsezza di fertilizzanti, mancanza di carburante per le macchine agricole ecc.) resero molto difficile l’approvvigionamento delle città e favorirono quindi lo sviluppo del mercato nero.
Nel complesso la diminuzione dei salari reali, verificatasi in Italia già negli anni della crisi della rivalutazione tra il 1925 e il 1928 (3) e della crisi economica mondiale, non compensata dalla ripresa economica successiva al ’35, si aggravò grandemente durante la guerra. Di conseguenza si accentuò la tendenza alla diminuzione dei consumi della classe operaia e delle masse contadine, a cui si aggiunse quella di gran parte della piccola borghesia. Le retribuzioni nel ’42 e nel’43 scesero ad un livello medio di poco superiore al minimo necessario per la sussistenza, sicché vasti strati delle masse popolari, soprattutto nelle città, furono ridotti in condizioni di più o meno grave denutrizione. Molto pesanti furono inoltre le condizioni di vita delle centinaia di migliaia di lavoratori italiani, inviati in Germania durante la guerra. Questa emigrazione forzata, le cui rimesse servirono a pagare in parte le forniture tedesche all’Italia, fu composta dapprima soprattutto di manodopera non qualificata, impiegata specialmente in lavori agricoli; poi anche di operai qualificati, impiegati nelle industrie.
Frattanto dall’autunno del ’42 in poi si intensificarono i bombardamenti aerei sui centri industriali del Nord, che resero ancora più dure le condizioni di vita delle masse popolari. Molte furono le vittime e moltissime le abitazioni distrutte o gravemente lesionate; cominciò quindi lo sfollamento delle città con gravi disagi per migliaia e migliaia di lavoratori e per le loro famiglie. Nelle industrie, quasi tutte impegnate nella produzione bellica, i turni di lavoro erano durissimi; il mercato nero imperversava; il freddo e la denutrizione mietevano vittime. Il malcontento cresceva soprattutto nelle città, come Torino e Milano, più colpite dai bombardamenti. Per venire incontro ai disagi e alle spese di trasporto degli operai sfollati, che dovevano compiere lunghi percorsi tra le loro nuove residenze e i luoghi di lavoro, alcune imprese concessero il pagamento di 192 ore mensili oltre il normale salario. Ma questo risarcimento fu richiesto ben presto in tutti gli stabilimenti anche da coloro che erano rimasti in città, esposti a gravi rischi e a disagi non meno gravi. Inoltre si diffuse la richiesta della concessione di un’indennità di carovita. Si arrivò così agli scioperi del marzo 1943, che si iniziarono il 5 di quel mese a Torino nelle officine Fiat di Mirafiori e ben presto dilagarono negli altri stabilimenti della città e di altri centri del Piemonte; poi a Milano e in altri centri industriali lombardi.
Gli scioperi avevano fortemente irritato Mussolini e allarmato le autorità di polizia e i gerarchi del partito. Tra il marzo e il maggio circa duemila persone furono arrestate: in maggioranza comunisti, ma anche aderenti al partito d’azione o ad altri gruppi non definiti. La classe operaia, dopo la fiammata di marzo, sembrò placarsi e riprese a scioperare soltanto nell’agosto, dopo il colpo di Stato (4). Ma i bombardamenti sempre più terribili, ormai estesi a tutta l’Italia, e l’accrescersi delle difficoltà economiche diffondevano ovunque stanchezza, malcontento e irritazione contro Mussolini, contro il regime e contro la guerra.
(1) Africa Orientale Italiana, sigla dei possedimenti italiani nel Corno d’Africa. L’AOI univa all’annesso Impero d’Etiopia le colonie dell’Eritrea e della Somalia.
(2) Giuseppe Maione, “L’imperialismo straccione. Classi sociali e finanza di guerra dall’impresa etiopica al conflitto mondiale”, 1979.
(3) Il regime aveva progettato una fallimentare rivalutazione della lira a “quota 90” (90 lire per una sterlina inglese), espressione lanciata da Mussolini e proposta ufficialmente nel Discorso di Pesaro del 1926.
(4) Il 25 luglio del ’43, il Gran Consiglio del Fascismo aveva votato la sfiducia a Benito Mussolini, arrestato e condotto in prigione sul Gran Sasso. Capo del governo era stato nominato il maresciallo Pietro Badoglio.
Andrea Aloi, Quando l’economia andò alla guerra, striscia rossa, 1 aprile 2020
L’esame della situazione economica italiana della metà degli anni Trenta ci aiuta ad analizzare le motivazioni che spinsero migliaia di uomini ad arruolarsi per formare i contingenti di legionari che sarebbero andati a combattere per la causa nazionalista spagnola <173.
L’economia italiana nel 1935 era strettamente legata alla fase di uscita dalla forte crisi che aveva investito il mercato occidentale a seguito del crollo di Wall Street.
Dal 1933 era iniziato il “periodo di ripresa la domanda aggregata venne sostenuta da una crescita degli investimenti che subì un’accelerazione dopo il 1934, mentre aumentava anche il ruolo della spesa pubblica e della domanda estera <174. La quota dell’Italia sul commercio mondiale crebbe rispetto agli anni di crisi, anche se si trattava di uno sviluppo che doveva tener conto del ruolo giocato dalle esportazioni verso le colonie e soprattutto degli aiuti forniti alla Spagna, a sostegno del regime di Franco <175. Le forniture consistevano prevalentemente in prodotti meccanici e similari; pertanto non si può considerare che queste abbiano influito nel migliorare la difficile situazione valutaria del paese, dovendosi considerare effettivamente le colonie come territorio metropolitano e tenendo presente le difficoltà di pagamento frapposte dal governo spagnolo ai crediti italiani <176.
L’impresa etiopica, in particolare, aveva anche promosso, e forse anche al di là delle intenzioni di Mussolini, in modo tipicamente keynesiano «la ripresa dell’economia a mezzo di un’ampia domanda statale», concentrandola in alcuni settori particolarmente interessati alla congiuntura bellica <177. Queste osservazioni ci permettono di valutare meglio il ruolo svolto dall’imperialismo e dalla preparazione alla guerra in una situazione di debolezza della domanda, nella quale gli interessi dello Stato e quelli degli industriali si saldavano, anche formalmente, con il coinvolgimento dei maggiori nomi della metallurgia, della meccanica, della chimica, della gomma negli organi corporativi. Erano gli Agnelli, i Falck, i Donegani, che teorizzarono, con prese di posizione pubbliche, la necessità di un regime di controllo sulle importazioni, una politica di intervento dello Stato a sostegno della domanda e la diretta partecipazione nei settori di base più gravosi per le imprese private, come quelli delle miniere e della ricerca petrolifera.
In questi anni si realizzò un processo di evoluzione delle strutture dell’industria manifatturiera italiana. In sintesi essa si caratterizzò per lo sviluppo dei settori più strettamente legati alla congiuntura bellica, per una fase di processo di concentrazione tra imprese di maggiori dimensioni e per un rigido controllo sul mercato del lavoro <178.
Dopo la crisi del 1932 era iniziato un processo di sviluppo selettivo a scapito principalmente delle produzioni tessili e di quelle da essa derivate, che vennero ulteriormente danneggiate dal basso contigentamento fissato per le importazioni di materie prime ad esse necessarie <179.
Le vicende del periodo 1935-1939 non si discostarono dalle forme di sviluppo avutesi dopo il 1927 e continuate successivamente nel periodo della crisi, con un relativo boom indotto dalla politica di riarmo, che comportò un aumento del prodotto lordo anche in agricoltura. Questo incremento comportò una ulteriore espansione del settore cerealicolo, delle colture industriali, dell’olio e del vino, a cui fece riscontro una leggera diminuzione degli ortofrutticoli <180.
Gli anni Trenta segnarono anche l’inizio della politica autarchica, nata inizialmente come misura provvisoria mirata ad ammortizzare le misure sanzionatorie adottate dalla Società delle Nazioni contro l’Italia a seguito dell’invasione dell’Etiopia; l’autarchia finì per divenire una presenza stabile nell’economia del Regime. Proprio questa politica economica comportò la riduzione al minimo indispensabile delle importazioni, sostituite con produzioni interne; le esportazioni furono invece incentivate, sempre al fine di diminuire il grave disavanzo della bilancia commerciale <181.
Tale politica non si rivelò all’altezza delle aspettative, sia per la scarsa disponibilità di materie prime nel Paese, sia anche per la dipendenza energetica dall’estero; una realtà che fu forse sottovalutata dal regime e che fu la causa principale del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani autarchici <182.
Nonostante la perseveranza con cui il Regime perseguì l’obiettivo dell’autosufficienza economica, le misure intraprese non furono sufficienti o adeguate. Spesso la produzione dall’interno costava molto di più che i prodotti acquistati all’estero; tale politica provocava inoltre ritorsioni da parte dei Paesi che esportavano in Italia.
Sul piano interno non mancò il generale malcontento della popolazione dovuto alla mancanza di beni che prima venivano importati; inoltre il consumo pro-capite venne ridotto al minimo della sussistenza per poter destinare la maggior parte delle risorse all’esportazione o all’industria di guerra.
L’esperienza degli anni Trenta e le leggi dell’accumulazione capitalistica suggeriscono che gli interventi statali potevano consentire un’uscita dalla crisi solo a condizione di agire da “volano” per gli investimenti privati; quanto fu fatto per le imprese capitalistiche in agricoltura non era certo sufficiente a questo fine, oltre ad urtarsi con una insuperabile crisi di domanda e con i rapporti sociali che la presupponevano. Il boom bellico avvenne, in generale, attraverso una compressione dei consumi e dei redditi, anche se indusse un certo aumento dell’occupazione e del reddito.
Durante il quadriennio 1935-1939 si assistette ad una ulteriore stabilizzazione dell’agricoltura italiana secondo quegli indirizzi di consolidamento ed incentivazione delle aziende capitalistiche e moderne. Per quanto riguarda la situazione del mercato del lavoro tra il 1931 e il 1936, sappiamo che la diminuzione del tasso di attività nei rami “deboli” non significò evidentemente il totale allontanamento di precari dal mercato del lavoro <183.
Esaminando nel particolare la situazione italiana si può rilevare che a Nord l’aumento del tasso di attività fu la logica continuazione dell’andamento del periodo precedente, il che era dovuto, essenzialmente, al forte impulso occupazionale delle industrie pesanti, in particolar modo le chimiche e le meccaniche, secondo lo schema seguito già durante il periodo giolittiano. Per l’industria manifatturiera il tasso di attività rimase stazionario tra il 1931 e il 1936; questo fece sì che la ripresa economica riuscisse ad assorbire buona parte dei lavoratori espulsi precedentemente e parte di quelli agricoli, anche se non fu capace di aumentare il tasso di occupazione <184.
Il Centro vide un aumento del tasso di attività dell’industria manifatturiera, seppur di entità minore rispetto al Nord.
Per quanto riguarda il Sud, la situazione si presentava invece in maniera diversa, poiché vi fu una diminuzione della manifattura e un aumento nel complesso delle industrie, compensato dalla fortissima crescita degli occupati nell’edilizia. In sostanza, nel Mezzogiorno, nel periodo compreso tra il 1931 e il 1936, si ebbe la fortissima propensione ad espellere mano d’opera in momenti di crisi, segno che l’industria meridionale non era in grado di resistere neppure nel breve periodo. I settori in cui si verificò la maggiore diminuzione del tasso di attività furono quello tessile, metallurgico, della lavorazione dei minerali non metalliferi, con il coinvolgimento sia dell’industria leggera che di quella pesante <185.
Le Isole presentavano per molti aspetti le stesse caratteristiche del Sud, con l’aggravante che, oltre a conoscere una maggiore diminuzione percentuale del tasso di attività dell’industria manifatturiera, esse registrarono la stessa diminuzione in tutti i rami industriali. Il fenomeno venne determinato sia dallo scarso sviluppo dell’edilizia, sia, caso unico, dalla diminuzione del tasso di produttività delle industrie estrattive, che costituivano uno dei più importanti sbocchi lavorativi. Le uniche industrie manifatturiere che conobbero un aumento del tasso di attività furono quelle chimiche e meccaniche; inoltre, la situazione delle Isole, anche se a livello di occupazione precaria, fu in qualche modo migliore rispetto a quella meridionale, poiché vide una diminuzione del tasso di attività in agricoltura. Nelle isole rimase rilevante il numero di occupati nel terziario, soprattutto se messo in relazione con la diminuzione verificatasi prima e dopo il periodo fascista <186.
Per quanto concerne l’emigrazione, il quadro della provenienza regionale degli emigrati subì una profonda alterazione. Rispetto al periodo prebellico l’emigrazione dal Mezzogiorno, dopo la momentanea esplosione del 1920, ebbe un drastico ridimensionamento, mentre l’Italia settentrionale, a partire dal 1922, si affermò come area di massimo esodo e conservò tale posizione durante tutto l’arco temporale considerato <187.
[…] In conclusione si può presumere che la situazione occupazionale del 1936 ebbe sicuramente non poca influenza nella scelta da parte dei volontari di andare a combattere in Spagna; riprendendo le tesi dello storico americano Coverdale prima, e degli spagnoli Alcofar Nassaes e Vaquero Peláez poi, lo stereotipo dell’italiano, proveniente dalle zone depresse del Sud e delle Isole che emigrava in cerca di fortuna, si perpreta anche per quanto riguardava la figura del “legionario” che si arruolava nelle fila nazionaliste per trovare sostentamento e avere una via d’uscita alla disoccupazione <190.
[NOTE]
173 Per un’analisi più approfondita dell’economia italiana durante il fascismo, si veda: P. Ciocca – G. Toniolo, L’economia italiana nel periodo fascista, Il mulino, Bologna 1976.
174 Cfr. G. Tattara – G. Toniolo, Lo sviluppo industriale italiano tra le due guerre contenuto in AA.VV., L’economia italiana nel periodo fascista, Quaderni storici, maggio-dicembre 1975, p. 414.
175 Cfr. P. Ciocca – G. Toniolo, L’economia italiana nel periodo fascista, op. cit., p.164.
176 Ivi, p. 178.
177 Cfr. Tattara – G. Toniolo, Lo sviluppo industriale italiano tra le due guerre, op. cit. p. 417
178 La struttura dell’industria italiana in questo periodo può essere divisa in due gruppi: da una parte i settori industriali con un ammontare elevato in mano d’opera, come il tessile, l’abbigliamento e la trasformazione dei prodotti alimentari, i quali presentarono una dinamica dell’occupazione e della produzione sostanzialmente stagnante anche durante la ripresa. Dall’altra parte troviamo i settori che in pochi anni quasi raddoppiarono la produzione aumentando il numero degli occupati in modo addirittura più che proporzionale: si tratta della siderurgia, della meccanica in genere e dei veicoli in particolare, della gomma e in parte dei settori estrattivo e chimico. Negli anni Venti questa contrapposizione non era altrettanto netta, sia perché tutti i settori avevano realizzato aumenti di produzione, soprattutto grazie ad un’accresciuta produttività, sia perché anche l’industria tessile tradizionale e le industrie ad essa connesse avevano trovato nuove possibilità di sbocco sui mercati esteri. Cfr. P. Corner, L’economia italiana tra le due guerre, in G. Sabbatucci – V. Vidotto, Storia d’Italia vol. 4, Guerra e fascismo, Laterza, Roma-Bari 1998, pp.
342-373.
179 Ivi, p. 367.
180 In tutte le sue forme di regolamentazione dei prezzi agricoli, del commercio estero, della politica fiscale, interventi per le infrastrutture e della la politica agraria statale, la successiva rivalutazione della lira e la scelta dell’autarchia granaria si misura descrivendo le conseguenze della ormai accentuata spinta verso lo sviluppo dell’industria, piuttosto che enumerando le misure volte ad attutirne i duri effetti sulle imprese agricole. Cfr. E. Fano, L’agricoltura italiana tra le due guerre in AA. VV., L’economia italiana nel periodo fascista, op. cit. p. 492.
181 Cfr. L’economia autarchica può essere considerata un tratto caratterizzante della politica fascista. L’obiettivo di tale politica era quello di sostituire le importazioni con produzioni nazionali, con particolare attenzione all’autosufficienza in caso (probabile) di guerra: la sua implicazione immediata era quindi di stilare piani diretti alla produzione interna degli strumenti di difesa. Vedi inoltre in proposito: P. Corner, L’economia italiana tra le due guerre, op. cit., pp. 342-351.
182 La produzione prefissata da tali piani per ogni settore produttivo non raggiunse le soglie previste anche per via del calo della domanda sia estera che interna. Non migliorò la situazione la campagna africana tanto cara al Duce, che si rivelò una conquista tutt’altro che conveniente, dal punto di vista delle materie prime, del problema energetico e del miglioramento della bilancia commerciale. Sulla campagna di Etiopia si veda N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna 2007, oltre a A. DEL BOCA (a cura di), Le guerre coloniali del fascismo, Roma-Bari, Laterza, nuova edizione 2008.
183 Cfr. P. Corner, L’economia italiana tra le due guerre, op. cit., pp. 342-351.
184 Ibid.
185 Cfr. P. Sabatucci Severini – A. Tranto, Sul mercato del lavoro durante il fascismo in AA. VV., L’economia italiana nel periodo fascista, op. cit. p. 559.
186 Ibid.
187 Vedi in proposito P. Corner, L’economia italiana tra le due guerre, op. cit., pp. 313-317.
190 Cfr. J.F. Coverdale, I fascisti italiani alla guerra di Spagna , op. cit. J. L. Alcofar Nassaes, C.T.V. Los legionarios italianos en la Guerra Civil española. 1936-1939, Dopesa, Barcelona 1972 e D. Vaquero Peláez, Credere, obbedire e combattere, op. cit.
Giulia Medas, ¿Quiénes fuerón los voluntarios? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con Universitat de València, 2014