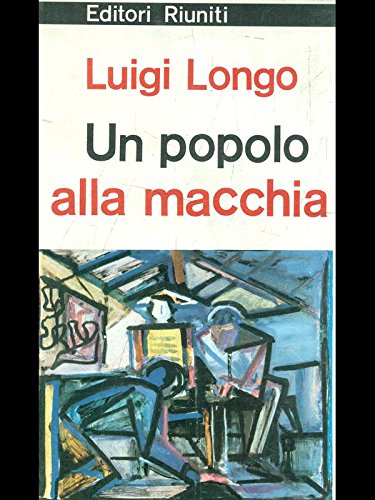Il dibattito sul significato della Resistenza italiana anima da decenni il confronto tra gli storici e ha attraversato nel tempo fasi diverse, subendo una notevole evoluzione. Subito all’indomani del conflitto mondiale, Alessandro Galante Garrone definiva la Resistenza una «guerra di popolo» assai partecipata e dunque capace di legittimare la nuova democrazia sorta nel nostro Paese. Questa interpretazione fu poi messa in discussione, finché all’inizio degli anni Novanta Claudio Pavone pubblicò Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, che ancora oggi rappresenta il contributo più completo ed equilibrato alla comprensione di quegli avvenimenti. Pavone mise in evidenza le tante facce della Resistenza, che fu guerra civile tra italiani combattenti in schieramenti opposti, guerra di liberazione contro il fascismo e il nazismo, guerra di classe per l’avvento di una società più giusta. Egli sottolineò anche come questi diversi aspetti fossero spesso inscindibili e tutti presenti nelle azioni dei protagonisti. Così, negli ultimi venti anni la discussione tra gli storici si è ampliata e ha puntato su l’uno o l’altro dei problemi legati al fenomeno resistenziale. […] Il dibattito sulla Resistenza italiana è tuttora vivo e aperto. F. Cortesi, S. Fedrizzi, A. La Gioia, Onde del tempo, 3 voll., Loescher, Torino 2012

La guerra partigiana è stata, in Italia, un grande moto di popolo. Essa non è stata solo combattuta da formazioni militari, contro Tedeschi e fascisti, ma è stata combattuta e sofferta da intere popolazioni, dagli strati sociali più umili, più tradizionalmente e secolarmente lontani da una partecipazione cosciente ai grandi problemi politici dell’età moderna. Ha investito e sconvolto gli interessi e gli ideali non di una, ma di tutte le classi. Ha posto gli Italiani dinanzi a problemi non specificamente italiani, ma semmai europei, ed universalmente umani. È stata insomma una spontanea «guerra di popolo, nata dal popolo». […] E per questo il suo ricordo durerà a lungo, nelle nostre valli e nelle nostre campagne, trapasserà in leggenda, alimenterà sentimenti ed orgogli e propositi, diventerà comune patrimonio di un popolo. […] Il fatto nuovo, miracoloso che per la prima volta si produsse nella nostra storia fu appunto questo: che il popolo italiano, non trascinato da una dinastia o da un esercito o da un governo legittimo (ed anzi nella totale assenza di questi poteri), spontaneamente scese a combattere per conquistare la sua libertà. Non è possibile intendere il significato politico della nostra guerra partigiana se non si considera questo carattere di spontaneità popolare e di autonoma consapevolezza che essa assunse in ogni regione.
Alessandro Galante Garrone, Aspetti politici della guerra partigiana in Italia, in «L’Acropoli», n. 16, 1946
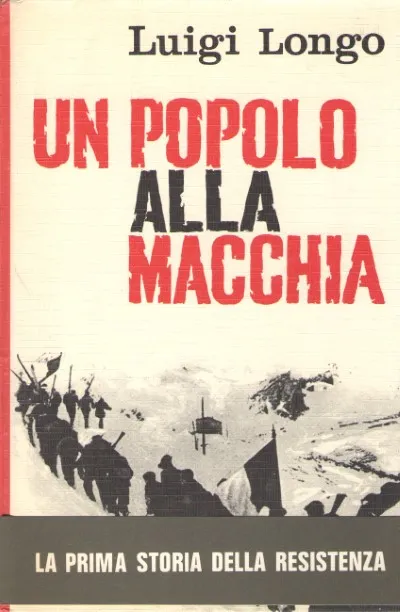
L’avanzata degli Alleati e la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 favorirono la progressiva crescita delle formazioni partigiane. Se ai combattenti si aggiungono tutti coloro, donne comprese, che si occupavano dell’apparato logistico del movimento, si può dire che almeno in alcune regioni la Resistenza riuscì ad acquisire un carattere di massa. Dai circa 12-13 000 uomini armati di fine aprile 1944 (ai quali andavano aggiunti gli ausiliari, i riservisti, le staffette e i componenti delle Squadre armate patriottiche, in tutto circa 25 000 persone), si passò nel mese di luglio a 50 000 e a 80 000 in agosto. Più numerose restavano comunque le forze militari nazifasciste, che raggiungevano le 300 000 unità.
Angelo Ventrone, «Italia 1943-1945: le ragioni della violenza», Amnis, 2015
L’interpretazione della lotta fra la Resistenza e la Repubblica sociale italiana come guerra civile ha incontrato da parte degli antifascisti […] ostilità e reticenza, tanto che l’espressione ha finito con l’essere usata quasi soltanto dai vinti fascisti, che l’hanno provocatoriamente agitata contro i vincitori. La diffidenza degli antifascisti ne è risultata accresciuta, alimentata dal timore che parlare di guerra civile conduca a confondere le due parti in lotta e ad appiattirle sotto un comune giudizio di condanna e assoluzione. In realtà mai come nella guerra civile […] le differenze tra i belligeranti sono tanto nette e irriducibili e gli odi tanto profondi. […] La qualifica di servi dello straniero data ai fascisti non è sufficiente a cancellare in loro quella di italiani, né autorizza a eludere la riflessione sui nessi, non nuovi ma in questo caso strettissimi, fra guerra esterna e guerra interna. Nemmeno si può sorvolare sugli italiani, notevolmente più numerosi dei fascisti militanti, che di fatto accettarono il governo della Rsi, prestandogli in varie forme obbedienza. […] In realtà, è il fatto stesso della guerra civile che reca in sé qualcosa che alimenta la tendenza a seppellirne il ricordo. […] I membri di un popolo che si pongono al servizio dello straniero oppressore vengono considerati colpevoli di un tradimento radicale al punto da spegnere in loro la qualità stessa di appartenenti a quel popolo. […] Il prevalere della formula guerra, o movimento, di liberazione nazionale rispetto a quella di guerra civile occulta dunque la parte di realtà che vide italiani combattere contro italiani. […]
Le reciproche denunce di aver dato avvio alla lotta fratricida furono e restano numerose. Esse non debbono tuttavia spingere a dimenticare coloro che sentirono sì la guerra civile come una tragedia generatrice di tragedie e lutti, ma anche come un evento da assumere con orgoglio, in nome della scelta compiuta e della consapevole accettazione di tutte le conseguenze che essa comportava. Da questo punto di vista la corrente deprecazione può rovesciarsi: fu proprio infatti nella tensione insita nel carattere «civile» che trovarono modo di riscattarsi gli elementi negativi tipici della guerra in quanto tale.
Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati-Boringhieri, 1991

Nei limiti in cui poteva esserlo, [la Resistenza] fu utilissima all’Italia: da un lato dimostrò che esisteva una parte del Paese risoluta a pagare il prezzo più alto pur di liberarsi dal fascismo e dall’occupazione nazista, dall’altro costituì un momento decisivo per l’insediamento nel Paese del nuovo blocco politico-sociale1 che l’avrebbe guidato nei decenni futuri, nonché per definire i caratteri ideologici di quell’insediamento. Ma non poté essere altro. […] Erano solo gli angloamericani, in Italia, a poter stabilire cosa la Resistenza dovesse essere e cosa dovesse contare nazionalmente, ad avere l’ultima parola sull’entità e la natura della sua compartecipazione ai nuovi equilibri politici del Paese, in condominio con il governo, con i partiti di Roma e con gli altri soggetti autorizzati. […] Questo insieme di vincoli […] dipese direttamente da due fattori. Il primo è rappresentato dal carattere nazionale, e non già fascista, che la sconfitta ebbe agli occhi degli alleati, e che quindi ad essa va anche storicamente attribuito, dal momento che non si vede chi, se non i vincitori medesimi, possa decidere come debba intendersi la loro vittoria; il secondo fatto è costituito dalla gestione politico-militare della sconfitta a partire dal 25 luglio e sfociata nell’armistizio dell’8 settembre: una gestione che, al di là dell’intenzione stessa degli angloamericani, produsse per i modi in cui si svolse un disfacimento pressoché assoluto dell’identità politico-statuale italiana, nonché di qualsivoglia soggetto potesse dare voce a tale identità in modo sufficientemente autonomo e rappresentativo di un interesse nazionale. Stando così le cose, all’antifascismo italiano non poté riuscire altro che di fingere di avere riportato la vittoria pur essendo il rappresentante di un Paese in realtà debellato; di fatto, insomma, non potendo fare (ed essere) né il vincitore vero né lo sconfitto.
Ernesto Galli Della Loggia, La morte della patria, Bari, Laterza, 1996
La Resistenza non appartiene a nessun partito.
Uomini di tutti i partiti antifascisti vi portarono il loro contributo, non vogliamo nelle nostre celebrazioni dimenticare nessuno, tanto più che quel contributo lo cercammo con insistenza, fummo noi a cercare ed a volere fortemente l’unità di tutte le forze popolari; ma lasciatecelo dire perché è la verità: specialmente all’inizio quante discussioni dovemmo sostenere, quanta tenacia dovemmo impiegare per convincere, persuadere che era necessario agire subito, batterci contro i tedeschi ed i fascisti. Non ci trovammo subito in molti all’8 settembre, ma non ci chiedemmo se era la nostra ora, non ci mettemmo a contare quanti eravamo. Sapevamo che era un’ora decisiva per l’avvenire del paese. Altri, molti altri di ogni corrente politica, vennero poi ad ingrossare l’esercito dei CVL. L’unità andò realizzandosi nel corso della lotta le forze affluirono nella misura in cui l’azione e il successo insegnarono che si poteva combattere e vincere. Ma all’inizio non eravamo in molti e se molti altri si unirono è anche perché c’era stato il nostro esempio. […]
Il programma della Resistenza non fu quello di restaurare l’antico regime prefascista, ma fu quello di instaurare un regime politico e sociale nuovo che realizzasse profonde riforme nella società italiana.
Non vi è alcun dubbio che la Resistenza, il cui programma era dichiaratamente politico, democratico e antifascista, fu il più grande movimento popolare di massa nella storia del nostro paese, fu un movimento rivoluzionario che avrebbe dovuto portare a profonde modificazioni nella struttura socio-economica del nostro paese e che ha portato ad un inizio concreto di rinnovamento nella vita politica e sociale della nazione.
«Questo rinnovamento», ha ricordato il compagno Togliatti, «non è andato avanti e non si è compiuto come noi avremmo voluto e come avrebbero voluto gli eroi ed i caduti di allora.
Sia detto questo con tutta chiarezza. Avevamo combattuto e con noi la parte migliore del popolo aveva combattuto per aprire all’Italia una via di sviluppo nuovo, di progresso radicale. Volevamo una trasformazione profonda dei rapporti sociali, economici e politici nell’interesse delle forze del lavoro, nel rispetto dell’eguaglianza e della libertà di tutti i cittadini.
«Volevamo che il mutamento di classe dirigente che rese possibile la Resistenza diventasse permanente come fondamento di una nuova società.
«Non siamo riusciti a ottenere che per lungo tempo si procedesse per quella strada.»
Queste cose devono essere dette perché ci sono coloro che lavorano a falsare la storia della Resistenza, che ci presentano una Resistenza senza ideali, senza programma, senza bandiera. […]
Alle volte ci sono anche amici nostri i quali, forse per il timore di alimentare certe amarezze e certe delusioni che talvolta si fanno sentire specialmente negli ambienti partigiani, ritengono più opportuno tacere sul carattere, sugli obiettivi e sugli ideali della Resistenza.
Al contrario, noi riteniamo che quelle amarezze e quelle delusioni, quando esistono e là dove esistono, possano essere meglio superate non tacendo o velando la verità, ma proclamandola apertamente con tutta chiarezza, spiegando chiaramente perché quegli obiettivi non poterono essere raggiunti, indicandone le cause e le gravi responsabilità che pesano per questa situazione sopra partiti e uomini per avere compiuto gravi atti di violazione delle libertà democratiche, per avere spezzato quell’unità di forze democratiche che si era costituita nella Resistenza e sopra la quale doveva essere fondata l’Italia nuova. […]
Pietro Secchia, La bandiera della Resistenza, 25 aprile 2019 in L’Antidiplomatico (Nota di L’Antidiplomatico: Estratto del discorso tenuto a Genova il 26 aprile 1956 – Il 25 aprile, il compagno Secchia aveva scritto il fondo de «l’Unità» con lo stesso titolo, La bandiera della Resistenza, nel quale erano contenuti concetti qui sviluppati)
[…] non si possono studiare i singoli casi processuali senza prima ricostruire il contesto politico e legislativo entro il quale prese corpo il fenomeno del processo alla Resistenza. Ricostruzione che necessita, a sua volta, di un ampio studio delle politiche dei governi di transizione, dei rapporti tra governi di unità nazionale ed organi ciellenistici, delle intenzioni di quelli per un reale svecchiamento delle strutture statali o non piuttosto per la continuità dello Stato nel periodo postfascista. In effetti, proprio dall’osservazione dei provvedimenti legislativi amnistiali, approvati fin dal secondo governo Badoglio, risulta evidente la volontà della classe dirigente italiana di procedere ad un immediato riassorbimento degli illeciti penali commessi dagli ex combattenti durante il periodo bellico, mentre del tutto marginale risulta essere il bisogno di ridefinire un nuovo concetto di legalità alla luce di una guerra rivoluzionaria.
Il tentativo stesso di svecchiare l’organizzazione giudiziaria e rifondarla su nuovi parametri di diritto, vagheggiato dalla dirigenza del movimento partigiano durante il periodo della clandestinità, vacillò di fronte alla volontà del gabinetto Bonomi di favorire una transizione dell’emergenza, caratterizzata da una sostanziale continuità sul piano amministrativo giuridico.
In merito ai singoli casi giudiziari è inoltre inevitabile incrociare le fonti giuridiche, la documentazione fornita cioè dalle sentenze, con quella relativa alle qualifiche dell’imputato, rintracciabile presso il Fondo Ricompartigiani del Ministero della Difesa.
È necessario poi fuoriuscire dall’ottica dello scontro ideologico proprio della guerra fredda e cioè dall’interpretazione data dai contemporanei del processo alla Resistenza come fenomeno proprio del clima anticomunista del dopoguerra, non differente da quello repressivo-poliziesco scatenato contro le lotte operaie e sindacali.
Certamente l’anticomunismo del partito di maggioranza relativa fu uno dei principali elementi a scatenare il fenomeno. La stessa periodizzazione dei maggiori procedimenti giudiziari, quelli cioè celebrati contro intere bande e formazioni di brigata, (14 luglio 1948 – fine anni ‘50) indica come essi siano stati utilizzati politicamente per colpire il PCI che più di tutti si identificava con la lotta partigiana, e per reprimere il disagio sociale delle classi più deboli, omologandolo con la criminalità comune.
E tuttavia la repressione penale antipartigiana ebbe fasi, caratteristiche e intensità repressiva diverse, connaturate ai cambiamenti delle politiche di governo d’età repubblicana. I primi casi si segnalano, infatti, all’indomani della liberazione, nelle politiche alleate di smobilitazione delle bande partigiane, nel maggio-giugno 1945, con i primi arresti nelle zone del nord e le istruttorie a carico di garibaldini, da parte dei Tribunali militari alleati, per fatti avvenuti in guerra ma ritenuti illegittimi, o per episodi legati all’insurrezione (possesso illecito di arma da fuoco, rapina, saccheggio). All’inizio del 1946 la sospensione e il sostanziale fallimento dell’epurazione fascista condusse poi all’imponente fenomeno della repressione antipartigiana, con la ripresa di procedimenti già archiviati dagli stessi alleati.
Difatti mentre per la repressione dei reati di collaborazionismo era stata messa a punto una politica legislativa speciale, con la formazioni di organi giudiziari, come le Corti straordinari d’Assise, e di leggi straordinarie, vista l’eccezionalità del momento storico appena trascorso, nessuna disciplina legislativa intervenne a sanare i reati commessi dai partigiani durante il periodo della guerra di liberazione, in modo da garantirne il riconoscimento come legittimi belligeranti. La considerazione delle formazioni partigiane come bande armate irregolari rese possibile valutare la fucilazione di una spia come omicidio premeditato, la requisizione di beni e viveri come rapina, l’arresto di collaborazionisti come sequestro di persona […]
Michela Ponzani, L’eredità della Resistenza nell’Italia repubblicana tra retorica celebrativa e contestazione di legittimità (1944-1953), Paper Workshop nazionale dottorandi, 1-2 marzo 2007, Napoli
[…] Il movimento insurrezionale vide il maggior coinvolgimento di classe mai visto prima in Italia. Fu come riconobbe lo stesso Gaetano Salvemini: “il primo caso dal XIII secolo in cui le masse contadine parteciparono ad un movimento insurrezionale”. E questo avvenne anche e soprattutto grazie alla spinta incessante dei comunisti. Nei “Cahiers d’histoire de la guerre” si afferma che : «I comunisti entrarono in blocco nella Resistenza attiva. La loro azione si manifesterà in maniera forte specialmente dal 1943 in poi. Ma sin dall’inizio essi furono temibili per l’occupante sia per la loro esperienza della vita clandestina, sia per il loro coraggio che per la loro abitudine a soffrire. Essi fanno entrare nell’organizzazione clandestina e della Resistenza le masse operaie e urbane. All’azione individuale del sabotaggio, alla raccolta delle informazioni, alle azioni dei gruppi patriottici e dei partigiani aggiungono le armi degli scioperi, del sabotaggio della produzione, delle manifestazioni di massa. Essi non esitano a versare il loro sangue. Forti di una esperienza acquisita nella guerra di Spagna, prendendo esempio dalle istruzioni date da Stalin alle popolazioni dell’Unione Sovietica, organizzano delle formazioni partigiane, ecc.».
La Resistenza italiana differisce, sempre secondo Secchia, dalle altre lotte di Liberazione europee. In Italia si è vista una partecipazione massiccia delle forze operaie (tra il 30 ed il 35%) coadiuvate dal proletariato agricolo (oltre il 15%); Un paese in cui la lotta partigiana è andata, sempre, di pari passo con la lotta degli operai e dei lavoratori delle grandi città industriali, senza contare che molte delle dimostrazioni e delle lotte sindacali, oltre che scopo agitatorio, ottennero un immediato beneficio a livello politico. Secchia si dimostrò quindi lungimirante, più di altri, sulla questione dell’intervento. La Storia ha dimostrato l’utilità dell’insurrezione e della lotta armata, contraddicendo coloro che da subito schierati con la dottrina attesista, si ricredettero a metà del ’44. Quelle stesse forze reazionarie che cercarono successivamente di sminuire il ruolo del PCI nella lotta partigiana, derubricando il suo contributo da vitale, quale è effettivamente stato, a contenuto, proporzionato a quello delle altre forze antifasciste, se non addirittura di assurgere loro a reale guida della Guerra di Liberazione. Anche sotto questo profilo il contributo di Secchia, che negli anni successivi dedicherà larga parte della sua attività alla difesa della Resistenza e a spiegare le ragioni di alcune scelte politiche, è essenziale. La questione dell’insurrezione, su cui le forze più conservatrici all’interno dello stesso fronte anti-fascista ponevano un freno aveva un valore politico essenziale, per determinare una rottura tra il vecchio e il nuovo, impedire che con la liberazione da parte degli alleati, le masse popolari italiane fossero relegate nuovamente a ruolo di spettatori. Nel libro “Aldo dice 26 x1” (il messaggio in codice con cui si dette l’ordine dell’insurrezione ndr) Secchia da alcune indicazioni precise sul modo di concepire l’insurrezione e sul suo significato: «Essa si proponeva innanzi tutto di cacciare i tedeschi, di liberare il paese prima dell’arrivo degli anglo-americani. Con l’insurrezione i patrioti si proponevano di assicurare all’Italia una condizione di forza al tavolo della pace e si preoccupavano di conquistare posizioni politiche che impedissero il ritorno all’Italia prefascista, ai compromessi ed alla corruzione dell’aula “sorda e grigia” e favorissero losviluppo della democrazia.» L’insurrezione si configurava dunque come atto di rottura, non di instaurazione del socialismo certamente, ma di netta cesura tra il prima ed il dopo, nell’ottica della realizzazione di quella democrazia progressiva, che per primo Eugenio Curiel aveva teorizzato e che il PCI aveva assunto come linea strategica. Una democrazia nuova, in cui il peso politico delle masse non si riducesse alle consultazioni elettorali, alla delega ai meccanismi della democrazia borghese, ma richiedesse un nuovo modo di partecipazione […]
Franco Porcù (redazione Senza Tregua), La lotta armata e l’organizzazione della Resistenza in Contributo alla memoria di Pietro Secchia cit. infra

Fasc. 32 – Doc. 3: Francesco Leone “Le Brigate “Garibaldi” nel movimento partigiano in Italia”. Ed. “L’Unità”, Roma, 1944. L’opuscolo, 64 pagine di testo più copertine, form. 18X13, è compreso nell’archivio del Circolo “Virgola” di S. Margherita di Fossa Lupara (Sestri Levante) […]
Diretto ai quadri del partito comunista, l’opuscolo mirava, in particolare, alla formazione degli incaricati di questo partito inviati nelle ‘bande’ con mansioni fiduciario-ispettive, ma aventi il precipuo compito di “istruire politicamente” e “pilotare” i giovani compagni, appena giungevano in formazione, verso quest’unica forza politica. Doveva quindi risultare particolarmente attrattivo verso il PC, ma sopratutto dare un unico e preciso indirizzo alle loro ancora acerbe idee politiche, in quanto la maggior parte di loro arrivava in montagna priva d’un minimo bagaglio di conoscenze politiche. Inoltre, a questi giovani ‘compagni’, l’opuscolo assegnava anche il compito di prepararsi e farsi trovare pronti a sfilare davanti, in prima fila, nelle manifestazioni che sarebbero seguite alla Liberazione nazionale.
Decisamente in anticipo sui tempi, l’opuscolo era uno strumento non solo destinato a dare particolare lustro all’immagine dei giovani neo comunisti. L’autore infatti li assicurava che dai cortei, alla cui testa avrebbero dovuto presto di sfilare, avrebbero ricevuto cospicui vantaggi. Farsi riconoscere come principale forza liberatrice delle città e dei paesi li avrebbe fatti segno, prima, degli applausi popolari; e poi marcatamente privilegiati nell’accumulare preferenze nei successivi confronti elettorali. Redazione, La Divisione Partigiana Coduri, Fonti per la Storia

Nell’ambito del recente dibattito sulla crisi della identità nazionale, una indubbia centralità ha occupato la discussione su Resistenza e antifascismo.
Proprio in concomitanza con il cinquantenario della Liberazione, infatti, la lotta partigiana e la sua successiva rappresentazione sono state sottoposte ad un attacco frontale, senza precedenti nella storia della Repubblica, per estensione e fini.
I punti cardine di questa nuova storiografia sono la equiparazione morale di Repubblica Sociale e Resistenza e la necessità di smascherare la falsa rappresentazione dei vincitori della guerra <1.
A questa offensiva ha replicato una vasta schiera di storici, convinti, pur con notevoli distinguo, della validità della tradizione resistenziale anche in un quadro storico-politico profondamente mutato. Proprio il venir meno di quel particolare sistema bloccato può anzi essere il presupposto per una piena valorizzazione dell’antifascismo <2.
Il contributo principale all’avvio di questa nuova fase della riflessione sulla Resistenza é stato, senzaltro, quello portato dal saggio di Claudio Pavone, Una guerra civile <3 , con il quale si riesce finalmente ad aprire un dibattito interno su questa importante chiave di lettura <4 . D’altra parte, la parzialità con cui questa opera é stata accolta da una parte della pubblicistica e presentata ai mass media é indicativa di come una chiara operazione politica <5 si affianchi alla revisione storiografica <6.
Un elevato numero di convegni e di iniziative editoriali ha scandito l’evolversi del dibattito, che ha talvolta travalicato i confini della controversia storiografica perfino per iniziativa, per la prima volta, di alte cariche dello Stato.
In sostanza, influenti settori delle comunità storiografica e politica considerano i valori della Resistenza, o per lo meno le loro connotazioni, come reperti del passato, che possono solo ostacolare una democrazia matura.
Dei forti dubbi sono espressi anche riguardo la capacità dell’antifascismo di rappresentare tutti gli italiani nel primo cinquantennio della Repubblica.
Le sue istanze sarebbero, infatti, state «nazionali» solo per le esigenze politiche dei partiti di massa, in particolare del PCI, allo scopo di ottenere una legittimazione democratica altrimenti carente.
La strumentalizzazione degli eventi si sarebbe spinta fino a negare la natura di guerra civile dello scontro negli anni 43-45 e ad assegnare valore positivo all’8 settembre, mentre, in realtà, si sarebbe trattato della «morte della Patria» <7 .
Questo uso spregiudicato e particolare di una tragedia nazionale, trasformata in momento glorioso, perchè produttivo dell’evento resistenziale, avrebbe logorato il nostro senso di appartenenza generando una crisi morale della quale, ancora oggi, scontiamo le conseguenze.
Partitizzazione e uso pubblico della memoria sono le accuse rivolte a tutto il «mondo resistenziale», sia politico che storiografico e, in primis, ai comunisti, i veri artefici della costruzione di «memorie private» e strumentali.
Questa rappresentazione di comodo, questa mistificazione, si sarebbe svolta nell’arco di trenta anni, dal 1945 al 1975; dopo questa data il paradigma antifascista inizia la sua lenta crisi che deflagra con il 1989.
1 R. De Felice, Rosso e Nero, Baldini e Castoldi, Milano, 1995; E. Galli della Loggia, La morte della Patria, in G. Spadolini (a cura di), Nazione e nazionalità in Italia, Laterza, Bari-Roma, 1994. Questi saggi si inseriscono nel filone storiografico inaugurato dallo stesso De Felice dalla metà degli anni settanta.
2 Nella storiografia filoresistenziale possono sostanzialmente distinguersi due filoni: uno, riconducibile all’impostazione cattolica, sottolinea il momento di coralità e crescita morale dell’Italia durante la Resistenza e, di conseguenza, il suo fondamentale apporto al rafforzamento di una identità nazionale alternativa a quella fascista. Per contro, é sostenuta da altri storici una visione più elaborata della Resistenza, distinguendo tra un antifascismo esistenziale ed un antifascismo etico ed assegnando un maggiore valore all’esperienza dell’antifascismo negli anni della Repubblica. Le diverse correnti ritrovano comunque unitarietà nel comune riconoscimento del nesso tra antifascismo e Costituzione. Tra i più recenti scritti: P. Scoppola, 25 aprile. Liberazione, Einaudi, Torino, 1995; E. Rusconi, Resistenza e postfascismo, Il Mulino, Bologna, 1995; G. De Luna – M. Revelli, Fascismo, antifascismo. Le idee, le identità, La Nuova Italia, Firenze, 1995.
3 Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
4 Pavone notava già nel 1964: «Non vedo perché nel concetto di guerra civile debba essere implicita la neutralità di giudizio espressa attraverso l’astensione dal giudizio stesso o la paritetica condanna moralistica». [«Rassegna del Lazio», anno XII, numero speciale, 1965, pag. 113].
5 Il passo successivo potrebbe poi essere la messa in discussione di quel surplus di democrazia sociale ed industriale di cui l’antifascismo (soprattutto di sinistra) fu veicolo in fase costituente.
Mario Galleri, La rappresentazione della Resistenza. 1955-1975, Working Papers, ex dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali (Digips), Università di Siena
 Il carattere fondante della scelta di cui questi garibaldini rivendicano l’autonomia, impegna a una continua sua riaffermazione. La scelta da una parte è infatti sentita come irrevocabile, nel senso che «non è più possibile tornare indietro», dall’altra ha bisogno di continue riconferme, implicite o esplicite, a riprova di questa sua irrevocabilità. Le formule del tipo «chi sceglie ha scelto per sempre» sono così insieme una constatazione e una esortazione. Un articolo, Impegno d’onore, comparso su un giornale giellista afferma con vigore questa morale:
Il carattere fondante della scelta di cui questi garibaldini rivendicano l’autonomia, impegna a una continua sua riaffermazione. La scelta da una parte è infatti sentita come irrevocabile, nel senso che «non è più possibile tornare indietro», dall’altra ha bisogno di continue riconferme, implicite o esplicite, a riprova di questa sua irrevocabilità. Le formule del tipo «chi sceglie ha scelto per sempre» sono così insieme una constatazione e una esortazione. Un articolo, Impegno d’onore, comparso su un giornale giellista afferma con vigore questa morale:
Come all’atto di impugnare le armi ognuno di noi è stato mosso da una pura riflessione personale e ciascuno ha valutato chiaramente la portata del suo gesto e se ne è assunta in pieno tutta la responsabilità, così vorremmo che essa, nel prolungarsi della lotta, fosse sempre presente alla mente di ciascuno come un impegno d’onore da cui non si può né si deve deflettere.
L’impossibilità di trarsi indietro è in un altro documento del Partito d’azione presentata quasi come un crudo dato di fatto, ed è volta in incitamento a trarre dalla scelta tutte le conseguenze politiche che essa in nuce contiene, con quella immedesimazione fra coerenza morale e consequenzialità intellettuale che fu propria dell’azionismo.
A tutti coloro che sono venuti alla lotta dalla tragedia del paese, noi diciamo: non fatevi illusioni: rompere con lo Stato totalitario, non presentarsi alla leva, non giurare, resistere in qualsiasi forma e modo, significa mettersi su una via che le cose stesse vi obbligheranno a seguire fino in fondo. La lotta contro il totalitarismo è totalitaria. La «normalità» non si potrà più riconquistare che passando attraverso una profonda rivoluzione.
Continua era la necessità di rinnovare la scelta, talvolta in condizioni, ancor più difficili di quelle dei primi mesi, che riducevano lo spazio concesso alle oscillazioni, ai ripensamenti, agli abbandoni («ben sapevamo (…) che non si poteva impedire a nessuno di scappare, se non voleva più stare con noi»). Sotto l’incalzare di nuovi dilemmi maturarono quelle che potremmo chiamare le vocazioni tardive, indotte dai richiami fascisti alle armi e dalle precettazioni tedesche per il lavoro o frutto di più personali itinerari. La scelta va dunque considerata piuttosto che come un’istantanea illuminazione come un processo che talvolta si apre la strada a fatica, perché affaticati sono gli uomini che lo vivono. Ponendosi dal punto di vista dell’intensità dei valori coinvolti, si potrebbe pensare a una serie di diagrammi non lineari e cronologicamente non sovrapponibili. È comunque ovvio che le scelte della primavera del 1945, quando la fine è ormai imminente e l’esito è scontatissimo, sono diverse da quelle del settembre 1943. Balzare sul carro del vincitore non è una scelta, o per lo meno non lo è nel senso sopra tratteggiato. Giova tuttavia procedere al riguardo a qualche precisazione.
La sicurezza della vittoria caratterizza senza dubbio l’intera Resistenza italiana nei confronti delle altre Resistenze europee. Mentre i resistenti degli altri paesi, nel momento della loro scelta iniziale, rischiarono sia sull’esito che sulla durata, i resistenti italiani rischiarono solo sulla durata. Certo, anche negli altri paesi, in Francia e nella stessa Jugoslavia, la Resistenza prese slancio generalizzato solo verso la fine del 1942, quando Stalingrado, lo sbarco angloamericano nell’Africa settentrionale francese, el-‘Alamein mostrarono, a chi voleva intendere, da che parte ormai inequivocabilmente volgesse la fortuna delle armi. Resta tuttavia quella specificità italiana. Essa non trasforma peraltro i resistenti italiani in «cortigiani della vittoria», come un autorevole filosofo ha di recente affermato. Induce piuttosto a concentrare l’attenzione sul significato che allora assunse la volontà di aiutare il destino per rendersene degni obbedendogli, e diventare così ciò che si era. Fu un atteggiamento agli antipodi di quello praticato da coloro, fra i collaborazionisti, che si erano creduti più astuti degli altri e capaci di piegare il destino ai propri disegni machiavellici. A Roma i resistenti vollero essere diversi dalla massa dei loro concittadini i quali, secondo una caustica definizione, aspettavano la liberazione come un dono dovuto a se stessi e al pontefice.
Anche se la sconfitta nazifascista era una previsione sicura e razionalmente fondata, essa operò nei resistenti italiani come una profezia che conquista la forza di autoawerarsi. Questa fiducia nella vittoria costituì la «chiave di volta del nuovo, ancor povero, sistema simbolico quale andava formandosi in larga misura per via di comunicazioni interpersonali e di opinione pubblica clandestina».
D’altra parte, rischiare solo sulla durata, anche se questa fu in genere nei primi mesi prevista più breve di quanto poi sia stata, non significava non porre a rischio la propria vita. Anzi, morire senza assaporare il frutto di una vittoria ormai a portata di mano poteva essere ancora più straziante. Così Artom, anticipando la propria sorte, scrisse: «Mi pare amarissimo vedere la vittoria sicura, ma sembra di non poterla afferrare e godere perché la morte ci strappa via e ci porta lontano».
Opera, in molti resistenti, il senso di un recupero ancora possibile per sé e per l’Italia, di una uscita dalla minorità troppo a lungo protrattasi. Scrisse Foa: «Da un punto di vista profondo e lungimirante l’occupazione germanica è un grandissimo bene per l’Italia (…). E caduto infatti il triste privilegio italiano di non aver vissuto, come gli altri popoli europei, integralmente l’esperienza distruggitrice della guerra». E il giornale del Partito d’azione: «Non abbiamo più bisogno di scrivere sui muri, di notte, alla chetichella, “W gli eroici Danesi”: siamo anche noi come loro, come i Francesi, i Belgi, gli Olandesi, come gli Jugoslavi e i Greci, come i Cechi e i Polacchi». Il comandante garibaldino Ferdinando Mautino esprime una posizione analoga quando ricorda che lui e quelli come lui scelsero secondo lo spirito dell’appello del PCI – «solo con l’arma in pugno di fronte al nemico noi ci sentiamo ancora uomini e riaffermiamo la nostra umanità e dignità» – ma indipendentemente da esso, «che avremmo conosciuto soltanto a cose fatte».
Dante Livio Bianco si riconosce nella «gioia grande di aver potuto finalmente passare da una posizione teorica a una posizione pratica». Era la stessa gioia, ricorda Bianco, che Carlo Rosselli aveva manifestato appena giunto in Spagna. Negli antifascisti di vecchia data il riscatto era da umiliazioni come quella che aveva patito Filippo Turati, vecchio ed esule, quando il procuratore generale della Senna gli aveva domandato: «Mais, expliquez-moi, monsieur le député, comment donc se fait-il que l’Italie ne se révolte pas?». Nel 1943 sembrava arrivato il momento di cominciare davvero a «rifare tutto da capo», come un altro grande esule, Claudio Treves, aveva con amarezza detto al giovane Giorgio Amendola.
Proprio il fatto di essere arrivati ultimi, con un fardello tanto pesante sulle spalle, rese i resistenti italiani particolarmente sensibili ai problemi di un futuro che non si limitasse alla disfatta tedesca. «Gagner la guerre et gagner la paix», fu la formula in cui il giornale fondato in Francia da Silvio Trentin sintetizzò il problema. Sprezzanti sono, in quel giornale, gli attacchi contro «les patriots de vocation recente», contro «les ouvriers de la dernière heure», contro tutti coloro che «suivent le char de la victoire, sans souci de son conducteur, qu’il soit Hitler, Churchill, Roosevelt ou Staline». Partecipando poi alla Resistenza italiana, Trentin certo non si sentì assimilato a questa «marée déferlante et grondante qui soulève l’astre montant de la Victoire». Sentì probabilmente che i tempi stretti concessi all’Italia richiedevano un impegno ancora maggiore, prima che l’astro della vittoria illuminasse anche gli apprendisti dell’ultimissima ora.
Claudio Pavone, Op. cit.
La memorialistica, per sua natura, è quanto di più soggettivo e personale possa esistere nell’ambito della ricerca storica. Come ricordato da Philip Cooke (2015, p. 60) «si tratta di un termine assai flessibile, che copre un’ampia
varietà di opere animate da ambizioni talvolta molto diverse – dal racconto delle imprese di una singola persona […] alla narrazione delle attività di una particolare formazione o divisione partigiana». L’intricato labirinto delle memorie dei protagonisti porta talvolta a biografie più agiografiche che realistiche come nel caso di Zeduri. Lo storico ha il compito di fare luce sulla memorialistica per indirizzarla nei binari della storiografia; tuttavia il proliferare di racconti e testimonianze ha documentato un aspetto importante. La Resistenza, mito fonda-tivo della liberazione dell’Europa (Ridolfi, 2012, p. 44), era entrata in profon-dità nel sentire comune dell’opinione pubblica, determinando così percorsi di attualizzazione della memoria non sempre tuttavia condivisi.
Le testimonianze orali hanno rafforzato, portandoli alla luce, in alcuni casi elementi contraddittori e differenze spesso impercettibili all’interno della medesima situazione, quando è ricordata da più persone. La battaglia di Poggio Bustone, nel Lazio, è stata ad esempio «oggetto di numerosi racconti che rappresentano l’evento in modi contraddittori, distorti, a volte inventati – sempre creativi» (Portelli, 2007, p. 129), ma che sono indicazioni preziose della soggettività della percezione della memoria. In altre circostanze, come ad esempio l’eccidio di San Miniato in Toscana, il ricordo di un avvenimento particolarmente traumatico ha prodotto narrazioni differenti che hanno portato a galla fratture e divisioni nella percezione della memoria (Cooke, 2015, p. 244). Gli storici dunque si trovano davanti a un compito non semplice.
[…] I mutati scenari geopolitici se da un lato avevano necessariamente rafforzato le speranze palingenetiche di alcune componenti antifasciste (comunisti e socialisti in particolare, ma anche azionisti), dall’altro imponevano un compromesso per un Paese come l’Italia, destinato a ricadere nella sfera di influenza atlantica. Il risultato fu la Costituzione che comunque stabiliva la nascita di una società democratica figlia in gran parte della Resistenza.
Fu a partire da questo compromesso, tuttavia, che le divisioni sul significato della Resistenza ebbero luogo, a cominciare dall’adozione di differenti retoriche (Ridolfi, 2012, p. 42). L’esclusione dei comunisti dal governo De Gasperi nel maggio 1947 spinse il Pci in un angolo: l’intento era isolare dal contesto repubblicano una delle principali forze politiche che lo aveva reso possibile. Si affermava così uno scontro politico fortissimo «fra i partiti di sinistra e il com-posito blocco anticomunista, tra le forze che rivendicavano la Resistenza come fondamento dell’Italia repubblicana e quelle che la emarginarono, quando non la misero sotto accusa» (Perona, 2012, p. 83). La legittimità democratica dei comunisti traspariva d’altronde anche dal peso che le commemorazioni ufficiali della Resistenza andavano assumendo (Ridolfi, 2004, p. 43). Era naturale che i comunisti, non trovando altri spazi politici, insistessero sulla legittimazione democratica a partire dalla strenua difesa della Costituzione nata dalla Resistenza (Cooke, 2015, p. 41).
Su questo terreno maturarono i tentativi, falliti, di dividere il fronte antifascista nelle persone dei partigiani, riunitisi sin dal 1944 nell’Anpi. L’inasprirsi dello scontro politico fra Dc e Pci ebbe vasta eco sulla tenuta unitaria dell’associazione, che subì, in un moto speculare a quello del sindacato, due scissioni nel corso del secondo congresso del 1949 (Cooke, 2015, p. 107). Il Pci faticò non poco, anche al suo interno, nel presentare la Resistenza come momento fondante dello stato democratico, nonostante il largo consenso nell’opinione pubblica per l’istituzione del 25 aprile come festa nazionale (Ri-dolfi, 2004, p. 41; Ridolfi, 2012, p. 48).
Alla luce di tutto ciò è evidente come la fine del mondo, politico e culturale, che si richiamava alla miglior tradizione democratica del comunismo e del socialismo italiano abbia prodotto un trauma all’interno della cultura dell’antifascismo.
[…] In questo contesto il terreno della memoria si fa sempre più fragile e necessita di essere difeso. I limiti della narrazione resistenziale, tuttavia, impongono agli storici di non restare impassibili, ma di «svolgere un ruolo civile» (Cooke, 2015, p. 337) in modo tale da far proseguire il dibattito sulla Resistenza in modo innovativo e dinamico per contrastare efficacemente tanto il dilagare delle retoriche della riconciliazione quanto la crescita delle tendenze storiografiche revisioniste. La ricerca storiografica resta quindi essenziale per ricostruire percorsi, collettivi e soggettivi, in grado di connettere la storia alla memoria e viceversa. Solo così si potrà salvaguardare una memoria della Resistenza non retorica. La centralità di un approccio storiografico militante e scientifico al medesimo tempo (Magagnoli, 1994, p. 437) può essere garanzia di percorsi di ricerca che conducano a risultati innovativi sul piano della tutela e diffusione di una memoria che, a partire dalle dimensioni delle dinamiche locali, sia «fiera e responsabile, perché vigile sul presente e sulle domande che agitano il presente» (Bendotti, 2015, p. 184).
Riferimenti bibliografici
Fonti archivistiche
Archivio Istituto per lo studio della storia della Resistenza e dell’età contemporanea Bergamo (Aisrec), Carte Giovan Battista Corna, b. e., “53a Brigata Garibaldi Cattura e fucilazione dei fratelli Pellegrini”.
Aisrec, Carte Zeduri, b.a., fasc. 3, “3-1-1943”.
Aisrec, Carte Zeduri, b.a., fasc. 4, “8-8-44”.
Aisrec, Carte Zeduri, b.a., fasc. 4, “Zona d’operazione -15-10-44”.
Aisrec, Fondo Petrolini, fald. 3, b.a., fasc. 2, sottofasc. 7, “Incontro con Dante Paci”.
Aisrec, Fondo Petrolini, b.e., fasc. 1, sottofasc. 21-22, “Milano 19-4-46”.
Aisrec, Fonoteca Isrec, “Intervista a Giuseppe Taino”, 7 marzo 1988.
Bibliografia
Alborghetti M. (2006), La 53. Brigata Garibaldi, tredici martiri, S.I.
Andreucci F., Detti T. (1978), Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853-1943, 5 voll., Roma, Editori Riuniti.
Baldissara L. (1994), Gli Istituti della Resistenza e la ‘fine del dopoguerra’. Contributo al dibattito, in «Italia Contemporanea», n. 197, pp. 131-150.
Bauer R. (1976), Ricordo di Bruno Quarti, in «Studi e ricerche di storia contemporane-a», n. 7, pp. 30-38.
Belotti G. (1989), I cattolici di Bergamo nella Resistenza, 2 voll., Bergamo, Minerva Italica.
Bendotti A. (2011), I giorni alti. Bepi Lanfranchi e i suoi compagni, Bergamo, Il Filo di Arianna.
Id. (2015), Banditen. Uomini e donne nella Resistenza bergamasca, Bergamo, Il Filo di Arianna.
Id. (2016), Giuseppe “Popi” Taino, un comunista, in «Studi e ricerche di storia con-temporanea», n. 85, pp. 65-75.
Bendotti A., Bertacchi G., Della Valentina G. (1986), Comunisti a Bergamo. Storia di dieci anni (1943-1953), Bergamo, Il Filo di Arianna.
Bonomo B. (2015), Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella storia, Roma, Ca-rocci.
Le brigate d’assalto Garibaldi nel Bergamasco (1965), Bergamo, Stamperia Stefanoni.
Brighenti G. (2015), Il partigiano Bibi, Bergamo, Sestante (seconda edizione).
Carrara P. (1991), “Quello che mi veniva in mente facevo…”. Testimonianza di Pasqualino Carrara, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», n. 36, pp. 55-78.
Cooke P. (2015), L’eredità della Resistenza. Storia, cultura, politiche dal dopoguerra a oggi, Roma, Viella.
Cremaschi C. (1956), Tormenta (Mario Zeduri), Bergamo, La Modena tipografia.
De Luna G. (2004), La passione e la ragione, Milano, Bruno Mondadori.
Galbani A. (1994), Il Novecento degli Istituti. Resistenza, Istituti e società, in «Italia Contemporanea», n. 197, pp. 831-834.
Galli G. (1994), I partiti politici in Italia, 2 voll., Torino, Utet.
Ginsborg P. (1996), Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Torino, Einaudi.
Grassia A.G. (2014), Storie partigiane. Letteratura e memorialistica della Resistenza, Roma, Sensibili alle Foglie.
Grispigni M. (1994), Una storiografia critica dell’Italia repubblicana, in «Italia Con-temporanea», n. 197, pp. 813-820.
Guerra E. (1994), Istituti e trasmissione dell’esperienza resistenziale. Un’ipotesi di ri-cerca, in «Italia Contemporanea», n. 197, pp. 820-29.
Hobsbawm E. J. (2006), Il secolo breve. 1914-1991, Milano, Bur.
Legnani M. (1995), Dalla introspezione al progetto, in «Italia Contemporanea», n. 198, pp. 109-110.
Id. (1998), La storiografia della Resistenza ieri e oggi, in «Italia Contemporanea», n. 213, pp. 801-806.
S. Lupo (2004), Antifascismo, anticomunismo e anti-antifascismo nell’Italia repubbli-cana, in De Bernardi A., Ferrari P., a cura di, Antifascismo e identità europea, Roma, Carocci, pp. 365-378.
Magagnoli S. (1994), Dagli istituti “militanti” agli istituti “scientifici”, in «Italia Contemporanea», n. 195, pp. 435-445.
Melis G. (2013), Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino.
Pavone C. (1997), Guido Quazza. Un protagonista della nostra storia, in «Italia Contemporanea», n. 208, pp. 535-546.
Id. (2001), La Resistenza oggi: problema storiografico o problema civile, in Collotti E., Sandri R., Sessi F., a cura di, Dizionario della Resistenza. Luoghi, formazioni, protagonisti, vol. II, Torino, Einaudi.
Id. (2006), Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri.
Milesi G., a cura di (2007), I fratelli Florindo e Renato Pellegrini della 53. Brigata Garibaldi. Per non dimenticare, Anpi sezione zona Tredici Martiri di Lovere.
Peli S. (2006), Storia della Resistenza in Italia, Torino, Einaudi.
Id. (2012), Le stagioni del dibattito storiografico sulla Resistenza, in Agosti A., Colombini C., a cura di, Resistenza e autobiografia della nazione. Uso pubblico, rappresentazione, memoria, Torino, SEB 27, pp. 21-37.
Id. (2014), Storie di Gap. Terrorismo urbano e Resistenza, Torino, Einaudi.
Perona E.A. (2012), La Resistenza e i suoi luoghi di memoria, in Agosti A., Colombini C., a cura di, Resistenza e autobiografia della nazione. Uso pubblico, rappresentazione, memoria, Torino, SEB 27, pp. 80-102.
Portelli A. (2007), Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Roma, Donzelli.
Rapone L. (1998), Antifascismo e storia d’Italia, in «Italia Contemporanea», n. 212, pp. 565-575.
Ridolfi M. (2004), Rituali della memoria e linguaggi dell’antifascismo, in De Bernardi A., Ferrari P., a cura di, Antifascismo e identità europea, Roma, Carocci, pp. 35-51.
Id. (2012), La Resistenza nella rappresentazione delle istituzioni: celebrazioni, calendari civili in Agosti A., Colombini C., a cura di, Resistenza e autobiografia della nazione. Uso pubblico, rappresentazione, memoria, Torino, SEB 27, pp. 38-60.
Ruffini E. (2015), Dossier Fratelli Quarti, Bergamo, Istituto per lo studio della storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.
Id. (2015a), Dossier Pasquale Carrara, Bergamo, Istituto per lo studio della storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.
Scott A.J. (2011), Città e regioni del nuovo capitalismo. L’economia sociale delle metropoli, Il Mulino, Bologna.
Scurani A. (1965), Lo ricordiamo così. Profilo di Mario Zeduri, Bergamo, Congregazione mariana San Giorgio.
Togliatti P. (1984), Sui rapporti tra la Chiesa e lo Stato, in Opere 1944-1955, vol. V, Roma, Editori Riuniti, pp. 265-277.
Cristiano Poluzzi, Percorsi personali e memorie dei partigiani nel Bergamasco. Spunti per una riflessione, STORIA IN LOMBARDIA, n. 2 (febbraio 2018)
Se ripenso ai mille episodi di inaudita violenza da parte dei nazisti e dei fascisti di Salò e all’eroismo di tanti partigiani; se rileggo le lettere dei condannati a morte per la libertà, se mi fermo a meditare dinanzi alle pietre che ricordano i fatti di sangue e il nome di tanti eroi giovanissimi caduti perché la nostra, la mia, libertà risorgesse, allora sento quanto quella realtà dolorosa e luminosa sia la mia memoria, la mia ricchezza, il mio impegno. Veramente parte viva della mia vita. E tutto questo vale anche per chi allora non c’era.
Toglietemi queste ricchezze, svalutatemi questi sacrifici e mi avrete immiserito, avrete spento parte della mia esistenza, mi avrete privato di quanto mi sta a cuore, come se cancellaste la piccola, per me grande storia della mia casa, della mia famiglia: la guerra dei miei avi, ignoti soldatini, ma per me vita della mia vita; come se toglieste il racconto semplice e vivo dei sacrifici dei miei nonni e le lotte quotidiane per l’esistenza dei miei genitori.
Oscar Luigi Scalfaro, Non toccate le mie radici, sono sacre!, 2002
Alla metà degli anni settanta, uno dei principali esponenti della Resistenza e del PCI, Giorgio Amendola, aveva richiamato l’attenzione sui «tre obiettivi» fondamentali alla base dell’alleanza unitaria antifascista del tempo di guerra, indicandoli nella «partecipazione autonoma dell’Italia alla sua liberazione», nell’«elezione della Costituente » e nella «firma di un trattato di pace» che «portasse l’Italia fuori dalla condizione di paese vinto». Assieme all’obiettivo di rifondare su nuove basi democratiche il patto di cittadinanza, Amendola sottolineava lo sforzo militare per l’indipendenza del paese e il suo riscatto internazionale come motivi di fondo della collaborazione antifascista.
Le stesse esigenze legate alla mobilitazione bellica contro la Germania e, soprattutto, alla salvaguardia degli interessi nazionali hanno rappresentato, a nostro avviso, il propellente principale del processo di costruzione di una determinata memoria pubblica della guerra e della Resistenza, pesando in modo assai rilevante anche sul giudizio sviluppato sull’intero ventennio fascista.
La storiografia, principalmente italiana, che si è occupata di questi temi si è mossa finora lungo percorsi interpretativi diversi che, salvo eccezioni, non hanno considerato affatto il peso del fattore internazionale o lo hanno considerato come secondario.
Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Laterza, 2013
Si è spesso rimproverato alla Resistenza ed ai comunisti in particolare di non avere avuto un programma o di aver addirittura rinunciato ad ogni programma di carattere sociale e persino alla lotta di classe, per tutto subordinare all’insurrezione nazionale ed alla vittoria contro i tedeschi e contro i fascisti.
Ciò non risponde a verità, già lo abbiamo affermato nella prefazione e riteniamo che i documenti pubblicati nei precedenti capitoli ed in particolare quelli che pubblichiamo in questi ultimi ne diano una chiara ed inconfutabile dimostrazione. Naturalmente le posizioni da noi di volta in volta assunte, le posizioni del Partito comunista, possono essere discusse, criticate e contestate, come quelle di ogni altro partito, d’altronde; ma i fatti sono quelli che contano; assai più delle disquisizioni e delle elucubrazioni valgono i documenti, e più ancora dei documenti contano i fatti, che tali restano al di sopra di ogni disquisizione.
In una seduta alla Camera dei deputati del 10 giugno 1948, a qualcuno che aveva sostenuto che la Resistenza non aveva avuto un programma, il compagno Togliatti aveva risposto: «E’ vero che i CLN non formularono mai una serie di punti programmatici. Fu forse un grave difetto nella loro azione, ma questo non è l’essenziale. Il programma del movimento di liberazione dev’essere cercato nelle aspirazioni delle forze sociali e politiche che lo animarono e lo condussero alla vittoria, nella natura stessa di quelle forze, che non furono né gli industriali collaborazionisti dei tedeschi, né i grandi agrari con la nuca piegata davanti all’invasore, ma furono gli operai, i braccianti, i contadini, la piccola borghesia, gli intellettuali di avanguardia, i socialisti, i comunisti, i membri del Partito d’azione e anche i democristiani ed i liberali sebbene in misura molto minore. Il programma della Resistenza fu quello della creazione di un regime politico e sociale nuovo. Per questo si è detto che è stata un secondo Risorgimento.» (1)
Non è neppure esatto tuttavia che i CLN, quantomeno nel Nord, non abbiano avuto dei punti programmatici.
La costituzione dei Triumvirati insurrezionali e la funzione da essi assolta dimostrano che se fu il partito che più conseguentemente lottò per realizzare l’unità di tutte le forze che accettavano di lottare contro i tedeschi ed i fascisti, il PCI non rinunciò mai ad avere una propria organizzazione attivamente operante per far si che all’insurrezione nazionale partecipasse, nella misura più larga possibile, tutto il popolo e raggiungesse gli obiettivi più avanzati.
Ci piace qui ricordare una frase delle direttive del Comando generale del CVL, scritte dal compagno Longo, sulla “interpretazione” da dare al proclama di Alexander: «non vediamo perché quel che ha potuto fare il popolo jugoslavo da solo, non possiamo farlo anche noi».
Non si tratta soltanto di un incitamento a continuare ed a rafforzare la lotta, ma esprime con chiarezza il nostro orientamento.
Certo, non dev’essere mai dimenticato che non eravamo soli nella lotta e non ci fu possibile fare accettare tutte le nostre posizioni. Nei CLN vi erano uomini e partiti con altre idee e con altri programmi.
La Resistenza italiana fu un grande moto unitario del popolo italiano contro i tedeschi ed i fascisti, risultato di un’alleanza consapevolmente contratta tra le forze popolari democratiche e socialiste e le forze conservatrici; ma in ogni alleanza c’è sempre chi dirige, chi è alla testa, chi dà il più forte contributo e chi invece vi partecipa in posizione più o meno subordinata, vi è l’avanguardia e chi è trascinato e fa anche da remora.
In ogni alleanza, in ogni grande movimento di popolo ha sempre notevole importanza esaminare quali sono le forze che più hanno dato, non soltanto come combattività ma come idee ed orientamenti, e che hanno avuto la direzione.
Se esaminiamo la realtà quale essa fu, in tutti i suoi aspetti, e incontestabile che durante la guerra di liberazione, nella direzione della Resistenza ebbero il sopravvento al Nord le forze di sinistra, a Roma e nel Sud, invece, le forze conservatrici. Si tratta di un giudizio un po’ sommario e schematico che dovrebbe essere meglio precisato tenendo conto delle modificazioni dei rapporti di forza avvenute nel corso dello sviluppo della guerra di liberazione nazionale.
Gli stessi democristiani, liberali e monarchici non possono essere messi tutti in un solo sacco e giudicati in blocco come forze conservatrici; in parte si trattava di forze sinceramente antifasciste, in parte di forze che subivano l’influenza del tempo, le pressioni delle masse in lotta, in parte di forze sulle quali, specie verso la fase finale, influiva la volontà di non lasciare alle sinistre ed a noi comunisti in particolare il merito esclusivo del successo. Tutto ciò facilitò l’azione nostra e delle sinistre.
Quanto meno nel Nord (dove la Resistenza ebbe il suo più grande sviluppo sia nel tempo che come partecipazione delle masse combattenti nelle formazioni partigiane, negli scioperi delle città, nelle dimostrazioni nelle campagne) le forze decisamente antifasciste e di sinistra ebbero funzione decisiva e preminente, furono le principali protagoniste e riuscirono a prendere nelle loro mani la direzione politica dei CLN, del comando del CVL e delle formazioni partigiane.
Il che non avvenne certo senza dibattiti, senza contrasti, senza urti, ma sulle questioni principali le forze conseguentemente democratiche ed antifasciste (comunisti, socialisti, Partito d’azione) riuscirono ad avere il sopravvento, e nell’ottenere questo risultato l’azione dei comunisti fu preminente.
Riuscimmo ad avere il sopravvento sull’attesismo che era l’ideale delle forze conservatrici, avemmo il sopravvento sulla necessità di lottare non soltanto contro i tedeschi ma contro i fascisti, il che significava che per noi non si trattava soltanto di lotta nazionale, ma di lotta di classe.
Quanti passi in avanti furono fatti dall’inizio della Resistenza in poi! Inizialmente si discusse persino sulla possibilità di ammettere i comunisti nei primi comitati delle opposizioni da cui nacquero poi i CLN.
«I primi comitati militari che affiancarono i CLN e che limitarono la loro attività ad assistere materialmente gli ufficiali ed i soldati sbandati osarono rifiutare ogni contributo alle formazioni partigiane nate per iniziativa dei comunisti e di energici popolari. Fu per assumere libertà di azione ed assicurarci un’esistenza autonoma che venne presa l’iniziativa della costituzione delle brigate d’assalto Garibaldi.
Con quest’iniziativa in campo militare, e grazie al successo che essa ebbe, ottenemmo un primo risultato democratico: fummo accettati e riconosciuti in tutti gli organismi politici e militari a parità di diritti e di dignità con tutti. Naturalmente in questi organismi, ogni proposta che tendesse ad allargare la mobilitazione popolare, che tendesse a favorire l’ascesa dei nuovi quadri dirigenti, fu contrastata ed osteggiata dagli esponenti delle altre correnti, dai liberali ai democristiani.
Ciononostante noi riuscimmo a respingere la pretesa di questi stessi esponenti di sottomettere le formazioni partigiane che nascevano al comando superiore di militari che tutto volevano meno che la lotta. Ottenemmo che in tutte le formazioni partigiane trionfasse il principio che il comandante doveva essere il più capace, il più attivo, quello che più aveva contribuito allo sviluppo della formazione.» (2)
Noi fummo sempre favorevoli all’utilizzazione nei posti di comando di ufficiali provenienti dall’esercito (per la loro esperienza questi seppero dare un notevole contributo allo sviluppo della guerra partigiana). La sola condizione che ponevamo era che essi fossero per la lotta, per l’azione contro i tedeschi ed i fascisti. Mentre invece le correnti di destra, col pretesto delle capacità tecniche, tendevano a mettere alla testa delle unità partigiane soltanto degli ufficiali di carriera, uomini per lo più di orientamento conservatore, e spesso reazionario.
Riuscimmo a fare accettare dal CLNAI e dal CVL la nomina dei commissari politici in tutte le formazioni ed anche quando si realizzò l’accordo per l’unificazione di tutte le unità partigiane sotto un solo comando, accettammo il cambiamento del nome ma non mollammo sulla sostanza; il commissario restò col nome di commissario di guerra invece che di commissario politico, ma restò.
Quanto diversa dall’inizio era già la situazione nel gennaio 1944 quando il CLNAI, proprio per rispondere alle manovre conservatrici e reazionarie che si facevano sentire fuori ed anche all’interno di certi CLN, approvava la ormai famosa mozione in cui era detto: «Non vi sarà posto domani da noi per un regime di reazione mascherata e neppure per una democrazia zoppa; il nuovo sistema politico, sociale ed economico non potrà essere che la democrazia schietta ed effettiva. Nel governo di domani, anche questo è ben certo, operai, contadini, artigiani, tutte le classi popolari avranno un peso determinante ed un posto adeguato a questo peso avranno i partiti che le rappresentano. Tra essi il Partito comunista che fa parte del CLN su di un piano di perfetta parità con gli altri partiti, con pari pienezze di autorità oggi e di potere domani, quando il patto di liberazione nazionale sarà realizzato.» (3)
Riuscimmo a fare accettare dal CLNAI che la lotta fosse condotta anche con le agitazioni di massa. Non soltanto facemmo accettare il principio, ma soprattutto la pratica dei grandi scioperi e dello sciopero generale. Altro che rinuncia alla lotta di classe! Dall’inizio alla fine della guerra la Resistenza fu caratterizzata sempre dall’intrecciarsi della lotta armata con le lotte di massa, della lotta nazionale con la lotta di classe. Riuscimmo a fare accettare una concezione della Resistenza che comprendeva non solo la lotta dei partigiani armati, ma anche la lotta delle masse lavoratrici sul luogo stesso di lavoro ed a fare solidarizzare con queste lotte operaie gli stessi CLN.
Alla base dell’azione della classe operaia e dei lavoratori stavano non soltanto le necessità economiche o l’odio contro l’invasore, ma profondi sentimenti di odio contro il fascismo, di amore per la libertà e l’indipendenza da riconquistare, l’aspirazione al profondo rinnovamento della società italiana ed al socialismo. Motivi economici, politici ed ideali si intrecciavano e fondevano in un’unica spinta, come tanti rivoli in un grande fiume.
Riuscimmo a fare accettare la costituzione dei comitati di liberazione e dei comitati di agitazione unitari all’interno delle fabbriche.
Riuscimmo a fare accettare che i CLN fossero costituiti non soltanto al vertice, nel capoluogo regionale, ma in tutti i centri provinciali, nei villaggi e nei quartieri delle città, in ogni località di una certa importanza, poiché nella loro estensione vedevamo il crearsi di organi di autogoverno delle masse, di democrazia diretta ed immediata.
Riuscimmo nel Nord a fare accettare dai CLN il concetto che la lotta aveva per scopo non soltanto la cacciata dei tedeschi e la eliminazione del fascismo, ma la realizzazione di un regime di nuova democrazia (non il ritorno al regime esistente prima del fascismo). In proposito si veda la già citata dichiarazione del CLNAI del gennaio 1944.
E’ vero che alla vigilia dell’insurrezione il dissenso, e proprio su questi problemi: funzione dei CLN come organi della nuova democrazia, esploderà in pieno. Si vedano in proposito più avanti, in questo capitolo, le lettere dei cinque partiti.
Che nell’unità vi fosse il contrasto delle tendenze politiche, nessun dubbio, ed esso era espressione di idee diverse, della diversità delle posizioni politiche ed ideologiche che corrispondevano ai diversi interessi di classe delle forze che partecipavano ai CLN.
Persino alla vigilia dell’insurrezione si tentò ancora dai soliti elementi conservatori dei CLN, apertamente aiutati dalle alte autorità ecclesiastiche, di impedire e sabotare l’insurrezione tentando il compromesso con i tedeschi.
Ma a tutte queste manovre ci opponemmo decisamente e riuscimmo a farle fallire. L’insurrezione nazionale fu l’opera del popolo italiano organizzato nelle sue formazioni di combattimento e nelle sue organizzazioni politiche, e l’apporto di noi comunisti perché essa riuscisse fu decisivo.
Noi comunisti lavorammo sempre per realizzare la più larga unità di tutte le forze nella lotta contro i tedeschi ed i fascisti, ma al tempo stesso ci preoccupammo costantemente di conquistare la direzione alle forze di sinistra conseguentemente democratiche. Tutta la storia della Resistenza è stata una lotta continua non soltanto contro i nemici esterni, ma anche contro le forze conservatrici che cercavano di influenzare gli stessi CLN e di impedire lo sviluppo del moto insurrezionale; è stata un’azione continua per unire tutte le forze attorno ai CLN, ma anche per dare a quest’ultimo un orientamento, una direzione, degli obiettivi, una coscienza ideale.
«Marx, Engels, Lenin, Stalin – scrivevamo – ci hanno insegnato che, nella sua lotta rivoluzionaria, la classe operaia può e deve ricorrere ad alleanze e compromessi: ma in nessuna alleanza, in nessun compromesso, per nessun prezzo essa può lasciare cadere la sua arma decisiva, la sua organizzazione e la sua lotta di classe autonoma e indipendente, la sua funzione di avanguardia nella lotta di tutti gli oppressi, di tutti gli sfruttati.
Il problema della partecipazione al potere, i comunisti lo affrontano non nello spirito del riformismo e del socialdemocratismo, delle combinazioni parlamentari, della rinunzia della classe operaia alla sua lotta di classe indipendente e alla sua funzione di avanguardia di tutti gli oppressi e di tutti gli sfruttati. Lo affrontano con la teoria e con la pratica del marxismo rivoluzionario, col ricorso all’appoggio, all’attività, all’intervento diretto delle masse di tutto il popolo, nello spirito di una democrazia conseguente e progressiva che mobilita le masse per la soluzione dei problemi vitali di tutto il popolo italiano.» (4)
E’ con questo spirito che noi conducemmo la lotta durante la Resistenza. Questo non significa che la nostra linea politica, l’indirizzo della nostra azione lo facessimo nascere da pregiudiziali dottrinarie; esso sgorgava dalla realtà obiettiva e dalla necessità di potenziare al massimo la lotta armata e la lotta di massa, che non era lotta senza principi e senza obiettivi.
[NOTE]
1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 10 giugno 1948.
2) Luigi Longo, La lotta per l’unità nel contrasto delle tendenze politiche, in Rinascita, aprile 55, n. 4, p. 226.
3) Dichiarazione del CLNAI, gennaio 1944, in INSML, Archivio CLNAI, documento pubblicato in Per la libertà e l’indipendenza d’Italia, Roma, 1945, p. 91.
4) La classe operaia classe di governo, in La Nostra Lotta, 30 settembre 1944, n. 16.
Pietro Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione, Feltrinelli, Milano, 1975
Il processo evolutivo verso la realizzazione di un esercito partigiano strutturato in divisioni, brigate, distaccamenti e squadre, raggiunse il parossismo proprio nell’estate del 1944. Rispetto ai mesi precedenti autorevolezza e capacità operativa del Clnai erano decisamente aumentate, grazie all’adesione della maggior parte delle formazioni partigiane al Cvl, e soprattutto alla creazione del comando militare unitario, e dei suoi corrispettivi nei comandi militari regionali e di zona. Molte delle disposizioni introdotte dal Cvl andavano in tal senso, cercando di trasformare le bande, multiformi e multicolori, in un vero esercito. L’adozione di divise e distintivi, dei gradi e del saluto, l’obbligo per ogni formazione di redigere rapporti regolarmente trasmessi al comando generale del Cvl, erano rilevanti della volontà di uniformare i comportamenti delle formazioni partigiane. Il Cvl era perfettamente a conoscenza della difficoltà di regolarizzare l’intero movimento resistenziale. In una direttiva del 23 settembre 1944 si accontentava di prescrivere che gli uomini avessero in dotazione una divisa, i cui capi essenziali erano giubba vento e pantaloni lunghi uso sciatori; ma conoscendo l’enormi difficoltà di dotare tutti i partigiani di una divisa, si raccomandava di fare in modo che le varie fogge degli abbigliamenti avessero un carattere di uniformità almeno all’interno dei minori reparti <248. La divisa portava con sé l’adozione di gradi riconoscibili. Il Cvl emanò anche in questo campo minuziose disposizioni, premettendo però che nel Cvl gli incarichi di comando erano indipendenti dall’eventuale grado rivestito nel disciolto esercito e conferiti in rapporto al merito partigiano e alla competenza tecnica <249. I gradi non cancellavano i distintivi delle varie formazioni. Stellette militari per le formazioni autonome, stella tricolore indossata sul braccio sinistro per le formazioni d’assalto Garibaldi, scudetto tricolore indossato sul braccio sinistro per le formazioni G.L. non erano considerati segni di rivalità e di concorrenza ma simboli della lotta partigiana <250. Il saluto era quello militare: “rettifica della posizione se a capo scoperto, portando la mano destra all’altezza della visiera del berretto ed all’orlo della bustina se con copricapo” <251.
[NOTE]
248 Aisrp, scaffale C, cartella 9, interno a’
249 Rochat (a cura di), Atti del comando generale del Corpo volontari della libertà, p. 491
250 Aisrp, scaffale C, cartella 9, a’
251 Ibidem
Marco Pollano, La 17a Brigata Garibaldi “Felice Cima”. Storia di una formazione partigiana, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Anno Accademico 2006-2007