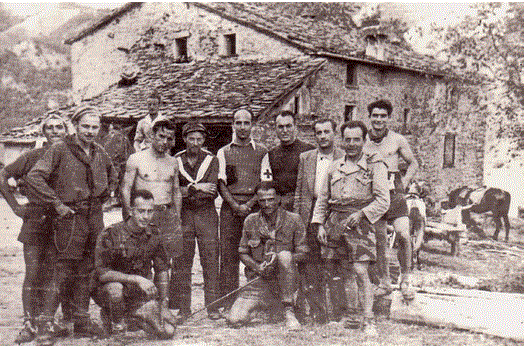
La 36ma Brigata Garibaldi [“Bianconcini”] e la Battaglia di Purocielo
I partigiani morti nella battaglia di Purocielo [nel comune di Brisighella (RA)] sono ricordati a Ca’ di Malanca con un cippo commemorativo che riporta tutti i nomi, le città e le nazioni di origine dei deceduti.
Nella valle Rio di Co’ tra Purocielo e Ca’ di Malanca si erano posizionati il Secondo Battaglione e il Quarto Battaglione della 36a Brigata Garibaldi, comandati da Luigi Tinti, “Bob”. I partigiani erano circa 700, suddivisi in dodici compagnie.
L’attacco
Purtroppo, gli sviluppi degli eventi bellici coincisero con il progressivo rallentamento dell’avanzata degli Alleati. Perciò il comando partigiano decise di tentare lo sfondamento delle linee tedesche per congiungersi agli inglesi, attaccando in direzione di Fornazzano.
Il mattino del 10 ottobre, partendo da Ca’ di Malanca, i partigiani attaccarono le linee nemiche. Ma le difese tedesche li respinsero attorno a monte Vigo. Le compagnie della 36a abbandonarono Ca’ di Malanca. Si attestarono sul crinale in direzione della Torre di Calamello, nell’area di monte Colombo e nelle case situate nella parte bassa della valle verso la Chiesa di Purocielo.
All’alba dell’11 ottobre i tedeschi, muovendo da Purocielo, attaccarono Ca’ di Gostino. Qui aveva sede il Comando partigiano. Caddero il comandante del Secondo Battaglione, Ivo Mazzanti, e diversi altri componenti del Comando. I partigiani superstiti, guidati da Luigi Tinti “Bob”, si sottrassero dall’attacco. La battaglia si sviluppò per tutta la giornata. La maggior parte dei partigiani riuscì ad attraversa il Rio di Cò, grazie anche alla strenua difesa e al sacrificio delle squadre partigiane posizionate sul Monte Colombo. Così raggiunsero Poggio Termine di Sopra, dove era presente anche l’infermeria.
La difesa
Dalle postazioni del crinale della Torre di Calamello e da Poggio Termine, nella notte e nella giornata del 12 ottobre venne organizzata una valida difesa. Furono respinti con successo gli assalti tedeschi. Nella notte successiva, dopo avere ricompattato le compagnie con circa 600 partigiani, il Comando della Brigata iniziò una difficile manovra di sganciamento verso la Chiesa di Cavina.
Con la collaborazione dei partigiani della Brigata “Celso Strocchi” guidati da Sesto Liverani, “Pali”, venne organizzato il trasferimento dell’intera formazione. Marciarono di notte per tre giorni verso le linee alleate. Attraversarono le Valli del Lamone, dell’Acerreta e del Tramazzo. Nel tragitto rimase ucciso uno dei comandanti, Andrea Gualandi, “Bruno”. Infine, gli inglesi li accolsero. Dopo averli disarmati, li trasferirono a Firenze in un centro di raccolta. Nella battaglia di Purocielo morirono cinquantasette partigiani e altissime furono le perdite tra le truppe tedesche.
Dopo la battaglia
Invece per i feriti in battaglia e per il personale medico e infermieristico della Chiesa di Cavina adibita ad infermeria, la tragedia doveva ancora cominciare. I sei feriti non trasportabili non poterono seguire gli altri e gli infermieri, quattro uomini e una donna, restarono con loro. Successivamente furono fatti prigionieri dai tedeschi. Questi li rasportarono nell’Ospedale di Brisighella, ad esclusione di un tenente medico austriaco ucciso sul posto. Tuttavia, qualche giorno dopo, furono prelevati dagli uomini delle Brigate Nere di Faenza che li portarono nella Villa di San Prospero, dove li torturano a lungo. Poi, condotti a Bologna nel Poligono di tiro, furono fucilati. Tra questi, Nino Bordini di Faenza e Teodosio Toni di Solarolo. Una ragazza infermiera, Laura Guazzaloca, fu invece internata a Fossoli, dove morì di stenti poche settimane dopo.
Redazione, La battaglia di Purocielo, Ca’ di Malanca


La pausa dell’offensiva fu provvidenziale per Bob, che ebbe il tempo di preparare adeguate misure difensive per la notte. Quando le mitragliatrici tedesche zittirono e le ombre della sera si allungarono giù dal crinale del Calamello inghiottendo poco a poco le macchie e i sentieri, il Comandante esaminò la situazione con i responsabili delle compagnie presenti.
C’erano degli ammalati e molti feriti da curare; e Deliano e Mao non erano certo in condizioni di muoversi. L’opinione di tutti fu quella di restare, almeno per un giorno ancora. Dovevano fermare i tedeschi ad ogni costo.
Per agevolare l’opera dei medici Bob ordinò che tutti i partigiani privi di un’arma, o non in grado di combattere, si trasferissero nelle retrovie, oltre il torrione di Calamello. Predispose inoltre uno schieramento molto ristretto, ma dislocato in profondità, per tutta la lunghezza del crinale; spedì la compagnia di Ribelle alla Scamigna, con l’incarico di guardare il sentiero di Cà Malanca, e quelle di Pirì, Paolo, Pino e Attila, ora al comando di Cigno, a difesa della dorsale fino alla Serra.
Le compagnie di Amato e di Dino, con i resti di quelle di Tito e di Ettore, sarebbero rimaste invece a difendere l’infermeria.
Appena buio ordinò di scavare trincee nella boscaglia sotto la casa e vi collocò tutti i partigiani in possesso di un’arma automatica.
Giovedì, 12 ottobre 1944
La meticolosità dei tedeschi nel porre fine ad un rastrellamento è proverbiale e favorì non poco i partigiani accorsi a difendere l’infermeria.
Anche se le perdite erano state gravi, il morale era ancora abbastanza alto e la situazione tattica dei due battaglioni si poteva considerare in un certo qual modo soddisfacente, anche perché l’inevitabile realtà topografica della valle lasciava al comando tedesco ben poco spazio per particolari soluzioni strategiche.
Occorre tuttavia rilevare che, se inizialmente l’infermeria era stata, giustamente, collocata ai margini dello schieramento partigiano, ora, dopo le vicende succedutesi sul Monte Colombo, ne era divenuto il punto più avanzato.
Poggio Termine di Sopra s’affaccia sul rio da un esiguo promontorio, in posizione vantaggiosa rispetto ai tedeschi, ma completamente allo scoperto, essendo separata dalla dorsale del Calamello da prato e terreno roccioso.
Attorno alla casa c’erano cento partigiani armati con due mitragliatrici e molte armi automatiche, che l’alba trovò tutti schierati nelle posizioni loro assegnate durante la notte, silenziosi, tesi, ma pronti al combattimento, in una vampata di nuove energie.
Come il sole uscì da dietro la tozza piramide del Colombo a Poggio Termine di Sopra cominciarono a giungere i proiettili dei mortai tedeschi. Erano martellate, quelle dei 120, che piombavano nelle orecchie, rintronavano nei cervelli dei partigiani, i quali avevano l’ordine di restare fermi ai loro posti anche nelle condizioni più difficili. E resistettero, ma anfratti e rocce salvarono molte vite. Il bombardamento durò un’ora circa, mentre all’interno della casa medici e infermieri operavano in condizioni pressoché impossibili.
Per tutta la notte, alla tenue luce delle candele, Angelino, Ferruccio, Renato, aiutati da Romeo, Marani, Toni, Laura, Sergio, Anna e Angelina avevano cucito, tamponato, fasciato senza fiale antitetaniche, senza alcool, utilizzando strisce di lenzuolo per bende e acqua bollita e sale per disinfettante, in un ambiente proibitivo anche per il più innocuo degli interventi.
Ed ora i tedeschi non la smettevano più di scagliare proiettili da quei loro infernali mortai, facendo sobbalzare uomini e cose in quella povera catapecchia, con i lamenti dei feriti che sembravano salire dalle viscere della montagna.
Durante il bombardamento i tedeschi avevano superato il rio e si erano attestati nella macchia sotto la casa.
Poi, alle dieci in punto, cominciarono a salire in ordine sparso, spavaldamente allo scoperto. Le prime fucilate li colsero quasi di sorpresa e li inchiodarono alle rocce, poi un Bren setacciò il resto della colonna e quando alcune bombe a mano esplosero tra i soldati, l’attacco ebbe fine. Il reparto si scompigliò e i soldati arretrarono verso Poggio Termine di Sotto alla ricerca di un riparo.
Ma il comando tedesco aveva lanciato, contemporaneamente, altre due colonne all’attacco dell’infermeria. La prima, manovrando indisturbata dal rio, aveva superato le trincee avanzate e raggiunse l’aia risalendo un fosso incassato. Neo, dalle finestre, vide i tedeschi aggirarsi dietro i pagliai e diede l’allarme, ma non c’era il tempo per organizzare un contrattacco e Bob uscì come un fulmine sull’aia con un Bren tra le mani; scaricò un intero caricatore in direzione dei pagliai, con una sola rabbiosa, lunghissima raffica, mentre Bruno chiamava a gran voce Amato e Dino che, dall’altra parte dell’aia, stavano osservando lo svolgersi del combattimento a Poggio Termine di Sotto. Accorsero in molti e tedeschi vennero ricacciati nel dirupo; poi Giulio, con la Breda, sparò sui soldati finché li vide ritirarsi a grandi balzi e sparire in fondo, nella boscaglia del greto.
L’altra colonna scese da Cà di Malanca. I soldati avanzarono lungo il crinale preceduti da una pattuglia di cinque, sei uomini, poi deviarono a destra, per il sentiero di mezzacosta, camminando senza troppe precauzioni fumando e chiacchierando. Dall’alto del Poggio della Scamigna, dove aveva piazzato un mitragliatore, la squadra della compagnia di Ribelle che era di turno alla guardia del crinale li vide sciamare per il prato scosceso: una breve, precisa raffica di Cowboi si abbattè sui primi tedeschi; alcuni cadero sull’erba e vi restarono immobili, gli altri ripiegarono prontamente e si rifugiarono al di là del costone, scaricando sulla postazione partigiana alcune raffiche di Spandau.
Di là però non si mossero più.
Ancora una volta i partigiani erano stati all’altezza della situazione e i tedeschi, con quei loro assalti frontali, non avevano cavato un ragno dal buco. A Poggio Termine di Sopra regnava una certa euforia anche se, oltre a dover fare i conti con le munizioni, che attacco dopo attacco stavano rapidamente esaurendosi, i partigiani erano affamati ed intirizziti dal freddo. Alcuni, poi, sopraffatti dalla paura, erano ridotti ad una sorta di passiva rassegnazione.
Gli effetti negativi di ciò che era accaduto durante quei tre giorni di lotta dura e feroce non si potevano cancellare così, di punto in bianco, solo perché il nemico era stato battuto per l’ennesima volta; ai partigiani restava la perplessità di ciò che poteva ancora accadere, l’incertezza, cioè, dell’immediato futuro. Tra le file della brigata insomma, si stava diffondendo quel nervosismo che avvilisce anche i più coraggiosi.
Nella guerra partigiana, la paura e il coraggio, la calma e l’ansia non si ignorano e possono scatenare reazioni impensabili quando la posta in gioco è la vita; ecco perché diversi partigiani che il giorno prima avevano combattuto con entusiasmo e coraggio, ora avevano voglia di cedere, come se qualcosa dentro di loro si fosse spezzato.
A rendere ancora una volta più critica la situazione fu, puntualmente, l’artiglieria alleata, quando cominciò a bombardare le posizioni partigiane sul Calamello. Prima i proiettili traccianti delle mitragliatrici tedesche avevano colpito la casa per oltre mezz’ora esplodendo in una nuvolaglia di polvere, ora gli obici vi passavano sopra sibilando sordamente e si abbattevano sulle alte giogaie che vennero sconvolte. Per i partigiani furono momenti veramente terribili. I proiettili scoppiavano con una continuità che spezzava i nervi, frantumandosi in mille schegge che frullavano nell’aria e cadevano sulle rocce risuonando sinistramente. I partigiani si appiattirono, disperati, dietro ogni piega del terreno o l’inconsistente riparo offerto dai cespugli; molti abbandonarono le posizioni.
Preoccupato da questo stato di cose Bob, appena buio, convocò all’infermeria tutti i responsabili delle compagnie perché voleva sentire dalla loro voce se credevano ancora possibile resistere. Tutti furono contrari perché sapevano che se l’indomani i tedeschi avessero lanciato altri assalti, avessero picchiato ancora con i mortai, i partigiani non sarebbero riusciti a fermarli e allora sarebbe stata veramente la fine della Brigata; e coloro che durante quelle tre giornate di sangue e di gloria avevano perduto la vita sarebbero morti invano.
È una regola della guerriglia sapere fare il vuoto quando le forze del nemico sono preponderanti. La valle, perciò, doveva essere abbandonata. Ma da est, da sud e da ovest era impossibile, i tedeschi erano dappertutto. Non restava che tentare a nord, per il crinale del Calamello, libero fino alla Serra. La via della salvezza era quella.
Perché poi i tedeschi, concertando un attacco simultaneo da sud e da est, non manovrarono anche da nord resterà un mistero. A meno che le intenzioni del loro comando fossero semplicemente quelle di condurre una battaglia d’attrito, di logoramento tendente, se non a distruggere la brigata, a sloggiarla dalla valle con il minor numero di perdite possibile per i tedeschi; i quali, avendo saggiato la consistenza della forza partigiana, e ci si erano rotte le corna, ora lasciavano aperta quella porta. Una tattica del resto non nuova, i partigiani l’avevano già sperimentata in agosto sulla Bastia.
A notte inoltrata, una notte enorme, chiarissima, che dava quel senso di vuoto dentro che toglie il sonno, i due battaglioni iniziarono la marcia di trasferimento. Le figure, le cose attorno avevano assunto i contorni nitidi di un quadro che è rimasto incancellabile nella memoria dei sopravvissuti. E al di là del crinale saliva, da uno scenario ignoto, misterioso, il ronzio lacerante ed ossessivo del fronte che si distendeva lungo la valle del Senio. Una fetta di luna brillava come un faro e inondava il paesaggio di liquido argento facendo più alta e spettrale la lingua di pietra del rudere del Calamello.
Fu una lenta processione, davanti e dietro alle barelle improvvisate sulle quali erano adagiati i feriti e gli ammalati: e se per i compagni che li trasportavano lungo quegli impervi sentieri era oltremodo faticoso, per loro fu uno strazio senza fine. Deliano morì infatti, poco prima di Cà di Vigo. Aveva una lesione che, se anche grave, in momenti normali avrebbe richiesto solo giorni di degenza in ospedale. Ora era diventata mortale. All’infermeria rimase solo Mao, intrasportabile senza un intervento chirurgico, cosa impossibile in quel momento e in quelle condizioni. Purocielo ritrovò così il suo antico silenzio, che ora pareva fosse diventato ancor più grande con tutti quei morti disseminati tra le gagge, nelle crepe, sui prati.
Nella conca di Cavina, la mattina del 13 ottobre, c’era una calma, un silenzio che i partigiani stentavano a credere veri. Anche la battaglia tra alleati e tedeschi, che il giorno prima aveva infuriato al di là del Sintria, si era assopita. Solo una Spandau, lontana, sparava raffiche svogliate, mentre un fantasma di sole tagliava l’aria di neve avvolgendo di ovattata sonnolenza il paesaggio. L’atmosfera era, comunque, tesa.
I partigiani, giunti nella borgata durante la notte, avevano affollato i fienili, buttandosi sulla paglia sfiniti. Molti di loro, per la tensione e la stanchezza erano febbricitanti, e la fame impediva di prendere sonno.
Il comando di brigata si stabilì in un capanno di fianco alla chiesa, che i contadini chiamavano scuola, e qui Bob vi riunì, prima dell’alba, i responsabili dei battaglioni e delle compagnie. Fu una riunione pacata, durante la quale nessuno fece drammi. Ognuno dei presenti disse la sua con poche, scarne parole: due compagnie decimate, una dissolta nel nulla, altre ridotte negli effettivi. Tanti, troppi morti, feriti e dispersi, ingoiati nella fornace della battaglia. Eppure erano convinti che non tutto era andato storto, se era vero che la brigata esisteva ancora. Ma sapevano che i tedeschi, dopo avere perso tempo come al solito per organizzare una nuova offensiva, sarebbero tornati alla carica. I partigiani dovevano quindi approfittare di quelle poche ore che gli venivano regalate. La decisione, unanime, fu quella di dedicare l’intera giornata alla cura dei feriti e degli ammalati e assicurare a tutti gli altri il necessario riposo. I feriti erano stati ricoverati nella canonica, in due stanze del piano terreno, dove il parroco aveva sistemato pagliericci e materassi, ed ora si dava da fare ad organizzare in qualche modo un ospedaletto mentre la zia Angiola, in cucina, preparava qualche cosa da mangiare aiutata dalle ragazze del comando. Don Giuseppe, prete povero tra contadini poveri, non era nuovo a queste imprese. Aveva collaborato con la brigata fin dall’estate, e da quindici giorni ospitava Gnaf e Tigre, i feriti nello scontro sulla strada della Valletta. Per lui la Resistenza non era soltanto la difesa del campanile.
Poco dopo mezzogiorno Bob inviò Lina, una staffetta del comando, da Pali perché gli fornisse, conoscendo i luoghi, un servizio di guida. Poi, per facilitare il compito dei medici, ordinò che i partigiani feriti in grado di reggersi in piedi o a cavallo rientrassero alle rispettive compagnie. Nella canonica, distesi uno vicino all’altro, rimasero Tigre, Gnaf, Napoli, Attilio, Gianni e Fonso perché i medici dicevano che non avrebbero sopportato un ulteriore trasferimento. E loro, ai compagni di reparto che si recavano a salutarli, domandavano come sarebbe andata, se era meglio restare o andarsene. Alcuni pensavano che, nell’uno e nell’altro caso, finiva male; solo Gnaf ci scherzò, sopra quel suo piede malandato che lo toglieva per sempre dalle preoccupazioni, mentre Renato ripeteva che se la sarebbero cavata, non aveva dubbi, ma era come se lo dicesse a sé stesso, per convincersi.
Durante la giornata parecchi degli sbandati avevano raggiunto Cavina così alcune compagnie potevano ricostituire i quadri; e quando a metà pomeriggio arrivò una staffetta con le disposizioni di Pali, Bob ordinò l’adunata generale.
Erano le cinque e le compagnie, lasciati i casolari dove erano acquartierate, affollarono l’ampio prato scosceso dietro il cimitero: lo spettacolo di quei seicento uomini dalle barbe incolte, i capelli arruffati, gli occhi arrossati dal sonno e dalla febbre, coperti da laceri cenci infangati, con le scarpe a pezzi, non era certo dei più confortanti. La brigata mostrava tutte le sue cicatrici e i contadini osservavano, dalle case, quella moltitudine di straccioni dal volto indurito, amaro, senza quasi più traccia dell’antica spavalderia.
Parlarono Bruno, Corrado e Bob. «Compagni» disse il comandante, «ci è andata male. Ora dobbiamo partire di qui. Avremo ancora molto da camminare e, forse, anche da combattere prima di salvarci. Dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo stare tutti su con il morale, perché il minimo sbandamento può costare caro a tutti. Chi non se la sente può andare via, nessuno gli dirà niente. Voglio che ognuno decida liberamente. Si capisce che chi se ne va lascia qui le armi».
Qualcuno, a testa bassa, si sfilò il moschetto, lo posò a terra e si allontanò, in silenzio. Non furono molti, una trentina. Nessuno parlò. Certo che quei tre giorni di battaglia avevano fatto cadere molte delle eroiche decisioni prese nello slancio di un facile entusiasmo ed ora, sotto il peso dello sconforto e della paura, qualcuno non aveva retto. Più tardi i commenti dei rimasti furono salaci: se quelli tornano a casa, era il concetto, vuol dire che sono conigli, quindi meglio farne senza. Ma il giudizio corrisponde solo in parte alla realtà, perché molti di quei partigiani che avevano abbandonato la Brigata erano quelli che, pur con tutta la loro buona volontà, non erano mai riusciti ad inserirsi completamente nella spietatezza della guerriglia, avendola evidentemente accettata soltanto come ancora di salvezza.
Prima di sciogliere il raduno Bob diede le disposizioni per la partenza, consigliando i partigiani di portare con sé solo lo stretto necessario e, ovviamente, le armi. Comunicò pure che i feriti più gravi sarebbero rimasti a Cavina, e con loro Terzi, Renato, Sergio e Laura. Restava anche Willi, il tenente medico austriaco il quale, benché prigioniero, aveva collaborato con i partigiani durante quei duri giorni di ottobre.
Intanto nuvole scure avevano coperto il sole malaticcio e la luce era diventata grigia; veli di nebbia si stendevano sopra e il Monte della Vecchia, al di là del Sintria, e l’umidore dei prati penetrava attraverso i vestiti rendendo avvertibile anche fisicamente il malessere dell’attesa. Ogni partigiano si era messo addosso quello che aveva, e non era molto; alcuni erano riusciti a racimolare dai contadini qualche indumento sporco, logoro o rattoppato. Partirono con due pezzi di pane e una manciata di castagne lessate in tasca, e l’ordine di camminare nel più assoluto silenzio. Davanti, con la staffetta di Pali, che avrebbe fatto strada fino a Fognano, c’erano Bob e Paolo con i suoi uomini.
La marcia fu dura. I partigiani camminavano come se fossero svotati di ogni energia, molti erano costretti ad uno sforzo continuo per tenere il passo dei compagni più agili; il sentiero, invisibile e sdrucciolevole, accentuava la fatica. Si lasciavano alle spalle tre giorni fatti di terribili esperienze, e quel marciare verso l’ignoto era triste come la pena che si portavano dentro da quando avevano salutato i compagni rimasti a Cavina che, ne erano convinti, mai più avrebbero rivisto.
Alla Torre di Fognano li aspettava Pali coi suoi gappisti. Una sosta, breve, per definire l’itinerario, poi subito al Mulino, dove i partigiani, per guadare il Lamone, furono costretti a spogliarsi perché l’acqua giungeva alla cintola.
E finalmente, alla luce di un’alba lattiginosa, sostarono nelle casupole disperse lungo il torrente Ebòia, ai piedi del Monte del Tesoro. La sera, appena buio, la marcia riprese, con meta la chiesa di Santa Caterina, sotto il Monte Melandro, e poi giù, sulla strada di Modigliana.
E qui successe un tragico incidente. Le compagnie stavano attraversando ordinatamente la rotabile quando la pattuglia partigiana al posto di blocco di Fiumana si scontrò con alcuni tedeschi che transitavano in bicicletta; poche raffiche liquidarono i soldati, ma da una casa della borgata una mitragliatrice cominciò a sparare, forando col lunghe fiammate la nebbia, che in quella gola, in quel momento, era densissima. Le raffiche seminarono il panico e fu un disastro. Alle urla, alle imprecazioni, si sovrapposero gli ordini di abbandonare la strada subito, svelti, in una grande confusione. Le compagnie che avevano già attraversato si affrettarono a guadare il torrente ma le altre, quelle che dovevano ancora giungere sulla strada, tornarono sui loro passi per attestarsi in alto, su posizioni difendibili. Quei partigiani che al momento della sparatoria si trovavano sulla rotabile e il caso volle che appartenessero quasi tutti al Comando di Brigata, abbandonarono armi e bagagli e corsero direttamente verso il torrente, che in quel punto scorre sotto uno strapiombo di una ventina di metri. Nell’oscurità e con la nebbia molti non se ne avvidero e precipitarono nel burrone: Consiglia, Lia, Corrado, Sirro, Angelino, contusi abbastanza seriamente, poterono raggiungere la sponda opposta aiutati dai compagni accorsi alle loro grida, ma tre rimasero esanimi sui sassi dell’Acerreta: erano Bruno, che aveva battuto la testa ed era morto sul colpo, Angiolina e Stefano. Prima di morire la ragazza si trascinò per qualche metro e la sua agonia fu atroce; lo slovacco, con una gamba spezzata, riuscì a nascondersi nella macchia del greto, poi, fattosi giorno cercò aiuto dai contadini ma fu catturato, condotto alla Pieve di Tussino e fucilato il giorno stesso.
Dalla riva opposta i partigiani intanto sparavano contro la mitragliatrice che dopo alcuni minuti tacque; ma l’allarme ormai era stato dato e quando giunsero da Modigliana le camionette tedesche, le compagnie del Biondo, Ribelle, Pino, Piri, Dino e parte di quella di Amato furono costrette a risalire la montagna attestandosi a Santa Caterina.
Il resto della brigata, dopo avere superato l’Acerreta, raggiunse il Monte San Bartolo a mezzanotte e proseguì per Fregiolo, sul torrente Tramazzo. Giunse a Cà Valle, sul torrente Ibòla, all’alba del 14 ottobre. Pressapoco alla stessa ora, annusando l’aria come lupi in cerca di preda, i tedeschi erano a Cavina. Don Giuseppe, che in quel momento stava dirigendosi a Montegiorno per assistere un moribondo, vide la colonna scendere il sentiero di Cà Bago, ma anche i soldati lo videro e gli spararono, e continuarono finché il prete scomparve oltre il crinale.
La truppa accerchiò la borgata, alcune squadre entrarono nelle case buttando tutto all’aria; tra le donne che urlavano e i bambini che piangevano, lo spavento di quei poveri contadini fu grande. Nella canonica trovarono ciò che cercavano. Vi entrarono vociando e fecero uscire medici, infermieri e feriti. Fuori, in piedi, addossati al muro dell’edificio, c’erano Leo, Carlino e Delmo malconci e sanguinanti: Mao, moribondo, era poco lontano, disteso su una scala. Poi un contadino, scortato da alcuni soldati col fucile spianato, giunse con un carro trainato da una coppia di buoi; i tedeschi vi caricarono i feriti mentre l’Angiola e Willi tentavano di persuadere il comandante a lasciarli nella canonica. L’ufficiale scacciò malamente la vecchietta e percosse l’austriaco, ringhiandogli in faccia dure parole.
Verso mezzogiorno i tedeschi se ne andarono per il sentiero delle Torri: il carro in mezzo alla colonna, subito dietro i prigionieri, a piedi. L’ululato di un cane accompagnava la triste processione e sembrava il lamento di tutta la terra. Al tramonto il carro era fermo davanti all’ospedale di Brisighella. In uno slancio umanitario, tanto inconsueto quanto generoso, il comando tedesco aveva acconsentito a ricoverare i feriti in un capanno che si trovava nel cortile dell’ospedale, e lasciarono la responsabilità delle cure ai medici e agli infermieri partigiani. Con loro non c’era più Willi, che a Santo Stefano aveva tentato la fuga ed era stato crivellato di proiettili davanti al cimitero.
Ma la tragedia doveva ancora compiersi. A Brisighella, la notte tra il 16 ed il 17 ottobre, giunsero da Faenza i militi della brigata nera. Avevano i camion, sui quali caricarono tutti i partigiani, feriti e illesi, e ripartirono per Faenza. A Villa San Prospero, sede del comando fascista, i prigionieri vennero bastonati, torturati, ridotti in fin di vita. Il loro tormento ebbe fine il 18 ottobre quando Gnaf, Tigre, Attilio, Mao, Napoli, Bill, Gianni, Leo, Carlino, Delmo, Terzi, Renato, Sergio e Fonso furono condotti a Bologna e fucilati al Poligono di Tiro. Laura venne invece internata nel campo di prigionia di Fossoli ma vi morì di stenti il 23 novembre.
Lo stesso giorno, quasi alla stessa ora, Chicone, della compagnia di Biondo, veniva ucciso dai tedeschi presso il Casetto di Vespignano, vicino a Zattaglia e Dino e Gianni, della compagnia di Ettore, catturati da una squadra di militi della brigata nera nei pressi di Imola, furono fucilati in un campo di via Lasie, a sud della città.
E questo fu l’ultimo atto della battaglia di Purocielo, il più brutale. Ma la guerriglia è una vicenda drammatica e questo tragico epilogo, esaltandola, avverte che la Resistenza non è stata una semplice guerra, men che meno una guerra civile, ma la sanguinosa gestazione di un’Italia diversa, nuova.
L’Italia della Resistenza
Ferruccio Montevecchi, La battaglia di Purocielo, Grafiche Galeati, Imola, 1980, scritto qui ripreso da Storia e Memoria di Bologna