

Dopo l’ordine di Mussolini a Goriza del 31 luglio 1942, secondo cui bisognava «ammazzare tutti i maschi slavi», il II Corpo d’Armata pubblicò, in forma riservata, un documento volto stroncare il movimento di resistenza sloveno, e cioè la Circolare 3 C, contenente le direttive per la repressione sia del movimento armato che dei civili in Slovenia. La circolare fu firmata dal generale Mario Roatta, militare di professione, nato a Modena nel 1887 e comandante dal gennaio del 1942 della II armata, quella che controllava la Dalmazia, la costa croata e le zone montane della Provincia di Lubiana. Nel 1944 Roatta fu condannato dagli alleati all’ergastolo in contumacia <4.
Fu in base ai suoi ordini che l’esercito italiano effettuò una serie di massicci rastrellamenti contro la popolazione civile, che si protrassero dall’estate 1942 fino all’autunno dello stesso anno. Ben 70.000 soldati italiani dislocati sul fronte balcanico passarono al settaccio un terreno di 3.000 chilometri quadrati a sud di Lubiana, dove vennero rasi al suolo centinaia di paesi, effettuati massacri indiscriminati di ostaggi e da dove vennero mandati in internamento nei cosiddetti «campi del Duce» circa 30.000 persone, in gran parte donne, vecchi e bambini.
Due di questi campi di concentramento per civili furono istituiti a ridosso del fronte SLO-DA verso i partigiani, uno sull’isola di Rab-Arbe e l’altro sull’isola di Olib, altri ancora furono eretti a ridosso del vecchio confine italo-austriaco in Friuli e nel Veneto nelle località tristemente note di Gonars, di Visco, di Monigo presso Treviso e di Renicci presso Padova <5.
A soffrire di più in questi campi furono senz’altro i bambini. Sembra che fino ad ora, né la storiografia, né le testimonianze orali siano riuscite a tracciare una quadro esauriente del vissuto dei bambini, l’anello piu’ debole nella catena di coloro che nel corso del conflitto subirono violenza. Il bambino rimane ancora sempre fatalmente legato al mondo degli adulti, soprattutto nelle condizioni estreme portate dalla Guerra e dall’internamento. In riferimento ai bambini che hanno subito la violenza di un campo di concentramento, si parla generalmente di «infanzia violata», di una sindrome, dunque, indelebilmente impressa nella loro memoria. Come ebbe a dire nel corso di un’intervista Herman Janež, uno dei bambini sopravissuti sia al campo di Rab che a quello di Gonars: «dal 1952 sono ritornato a Rab per ben 52 volte per ricordare i miei parenti e tutti quelli che sono morti lì, ma anche per ritrovare un pezzo di me stesso. La mia infanzia è rimasta per sempre lì» <6.
Nell’aggressione italiana alla Slovenia, anche i bambini, al pari delle generazioni adulte, pagarono il loro prezzo in termini di violenza e terrore.
Conobbero fatalmente anche i rastrellamenti, gli incendi, la morte, lo stigma razziale e nazionale, la snazionalizzazione forzata e la deportazione nei campi di concentramento dove andarono incontro all’eliminazione fisica nella forma più brutale. Quando la guerra nella provincia di Lubiana divenne totale, gli adolescenti, assieme ai loro genitori, si ritrovarono in una condizione di disorientamento e smarrirono la propria gioventù. Qualcuno li aveva spinti in un mondo che non era il loro mondo e questo qualcuno aveva progettato per loro la deportazione nei campi e l’incontro quotidiano con la morte.
Indagando le motivazioni di questo terrore generalizzato, ho incontrato presso l’Archivio di Stato sloveno una serie di scritti e di disegni infantili, che parlano proprio delle condizioni di vita dei bambini sopravissuti ai campi del Duce.
L’impulso a redigere questi scritti fu dato a questi giovani diseredati dalle autorità scolastiche partigiane nei territori liberi già negli anni 1944-45, per salvaguardare in questo modo la memoria e la personalità di queste piccole vittime della guerra.
In una dichiarazione scritta da Drago Kalicic di dieci anni si può leggere: “Io sono senza padre. È stato fucilato dagli Italiani. Un giorno sono entrati nel mio paese. Ci hanno fatto uscire dalla casa. Tutti piangevamo disperati ma mia mamma era quella che forse piangeva di più. Hanno preso e rinchiuso mio padre. Con lui hanno portato via tanti altri uomini. Poi ci hanno fatti andare in fila verso il paese di Zamost dove hanno fucilato dodici uomini. Tra questi c’era anche mio padre. Quando lo abbiamo saputo abbiamo pianto tanto. Poi hanno bruciato la nostra casa e ci hanno portati verso l’internamento” <7.
I deportati, e soprattutto i bambini, conobbero una nuova drammatica realtà, quella di dover sopravvivere nei campi di concentramento, praticamente senza cibo, con poca, pochissima acqua e in condizioni igieniche e sanitarie inumane. A causa di queste condizioni morirono nel breve, ma anche nel lungo periodo, numerosissimi adulti persero la vita e anche tanti bambini.
La prima vittima del campo di Rab-Arbe fu proprio un bambino, Malnar Vilijem, nato a Žurge presso Cabar il 22 maggio 1942. Così scrisse nella cronaca del monastero francescano di Sant’Eufemia di Rab, il frate Odoriko Badurina: «Ieri, 5 agosto 1942, abbiamo seppellito nel locale cimitero un piccolo angelo di due mesi, Vilijem Malnar, la prima vittima tra questi internati» <8.
La condizione degli internati variava da campo a campo. Se per il campo di concentramento per civili di Gonars in Friuli, gestito dal Ministero degli Interni, si può affermare che rispondesse a requisiti minimi di vivibilità (pacchi, posta, biancheria personale ecc.), la situazione nei campi di internamento parallelo, come li definì Carlo Spartaco Capogreco, era completamente diversa. Qui, gli internati, donne, vecchi e bambini, erano costretti ad una disperata lotta per la sopravvivenza, nascosti al mondo ed anche agli occhi indiscreti della Croce Rossa internazionale. L’esercito italiano, che gestiva questi campi (Rab, Olib), aveva già alle spalle una certa esperienza nella realizzazione di campi di concentramento; basti pensare a quelli eretti in Libia dal generale Graziani in cui trovarono la morte migliaia di internati. Il campo di concentramento di Rab-Arbe rispondeva proprio al modello dei campi creati da Graziani in Africa e non fu per caso che a Rab-Arbe e negli altri campi gestiti dall’esercito morirono di fame, di sete, di freddo edi stenti migliaia di civili <9.
Il sistema concentrazionario realizzato dall’esercito italiano nei territori occupati della Slovenia, per il numero dei deportati e delle vittime e per i metodi di gestione realizzati a Rab-Arbe, ricordava più i peggiori campi di concentramento africani, che non le forme di internamento degli oppositori del regime. La stessa presenza di vecchi, donne e bambini nei campi è illuminante a proposito.
Tutti i campi realizzati dall’esercito nel corso della seconda guerra mondiale furono definiti ufficialmente «campi di concentramento». Carlo Spartaco Capogreco ha definito giustamente illegale o meglio «fuori legge» l’internamento dei civili sloveni praticato dal regime fascista dopo l’invasione della Jugoslavia. Invasione, che peraltro avvenne al di fuori di ogni legge di guerra con il bombardamento improvviso di Belgrado e, in seguito, con l’annessione della Slovenia all’Italia già nel corso della guerra.
Occorre anche distinguere, e in questo ci aiuta molto l’analisi di Tone Ferenc, tra la violenza espressa in queste zone dall’esercito italiano nel 1941, violenza mirata ad obiettivi politici e militari ben definiti, e quanto avvenne a partire dal 1942, quando fu decisa e attuata una vera e propria strategia del terrore verso la popolazione civile.
Le nuove direttive proposte da Roatta e dagli alti comandi, in un quadro ideologico marcatamente razzista, prevedevano l’utilizzo contro i civili degli stessi metodi applicati dai nazisti sul fronte orientale: dall’incendio dei villaggi, alla fucilazione degli ostaggi, alla deportazione in massa in campi di concentramento per creare il vuoto attorno alle forze partigiane.
In questo quadro non dovrebbe sorprendere che il tasso di mortalità registrato nel campo di concentramento di Rab-Arbe, a causa della fame, del freddo e delle spaventose condizioni igienico-sanitarie, sia stato per lunghi periodi superiore a quello dei peggiori campi di concentramento nazisti, se si escludono quelli di sterminio. La differenza consiste solo nell’assenza di camere a gas e di crematori, sostituiti però da condizioni di vita insopportabili, di cui, ovviamente, furono i bambini le vittime principali. Si tratta in ogni caso di morti che non possono essere attribuite a fattori casuali e non previsti, come potrebbero esserlo le epidemie in conseguenza del sovraffollamento. L’alto numero dei decessi è il risultato di decisioni prese a tavolino, nel momento in cui si programmava, ad esempio, un vitto del tutto insufficiente. Ciò avveniva, sia per non sottrarre risorse all’esercito, sia per rendere i prigionieri più deboli e quindi più controllabili con il minor impiego di truppe.
Non si condanna a morte, quindi, ma si lascia morire, e questo non solo nell’inferno di Rab-Arbe.
A morire per primi furono i bambini, sia quelli giunti con le tradotte, che quelli nati nei campi. L’internamento e la morte dei neonati venivano considerati dai vertici dell’esercito un collateral damage, da non prendersi seriamente.
Le rubriche ufficiali del campo di Rab-Arbe distinguono i decessi unicamente secondo il genere. Se non fosse per i documenti d’archivio e per le testimonianze dei soppravvissuti, non saremmo mai riusciti a sapere che le vittime più numerose del campo di Rab-Arbe furono proprio i bambini.
Questi arrivavano al campo con i genitori o, se orfani, con parenti o conoscenti. Così Herman Janež, che nel 1942 aveva 7 anni, ricorda l’arrivo a Rab-Arbe: “Dalle nostre montagne ci hanno trasportato fino a Bakar, un’insenatura a sud di Fiume, dove abbiamo dormito all’addiaccio. Mio nonno stette tutta la notte a ripetere che ci avrebbero buttati in mare. Il giorno seguente partimmo senza sapere dove ci portassero. Giungemmo a Rab, dove ci divisero per sesso e per età. Praticamente ci avevano diviso definitivamente. Io che ero senza madre dovetti lasciare mio padre e mio nonno per andare nella parte del campo riservato alle donne e ai bambini. La paura di restare solo mi fece urlare e piansi così fino al giorno successivo, quando mi trasferirono in un campo intermedio. Mio padre non l’ho più avuto vicino e soltanto a Gonars mi riferirono, alcuni mesi più tardi, che era morto. Dormivamo in tende vecchie e logore che facevano passare l’acqua e dove si entrava a carponi. La latrina era molto lontana e di notte facevamo fatica a raggiungerla. Nel caldo torrido dell’estate non si poteva trovare alcuna ombra. Pativamo la sete, la fame e l’attacco di una moltitudine indicibile di pidocchi. Il ruscello che scendeva dal campo maschile e attraversava il nostro campo era pieno di pidocchi e non ci si poteva lavare. Quando arrivava la cisterna dell’acqua le guardie si scostavano e noi ci buttavamo come pazzi su quel fievole rivolo d’acqua. Quando pioveva il campo diventava una distesa di fango impercorribile. La sporcizia ci faceva impazzire” <10.
Quando nella notte dal 28 al 29 settembre 1942 un nubifragio travolse il campo femminile e l’acqua di mare salì fino alle tende, molti bambini morirono scomparendo nei flutti. Le autorità del campo non fecero niente per salvare gli internati, ma dopo un po’ incominciarono i trasferimenti nel campo superiore chiamato Bonifica e le tende vennero sostituite da baracche. Poiché la mortalità aumentava di giorno in giorno, le autorità militari, verso la fine del 1942, decisero di trasferire i bambini e le donne più provati in altri campi di concentramento, come quelli di Gonars e di Visco <11.
[…] Che i bambini fossero l’anello più debole della catena dei diseredati finiti nei campi di concentramento italiani, lo conferma l’«amnesia» della direzione dei campi stessi, che dimenticò di annotare, tra i 25.000 internati sloveni, il numero dei bambini che fecero il loro ingresso nel campo, il numero di quelli che vi nacquero e che vi persero la vita. Alcuni dati sporadici della fine di agosto del 1942 parlano, per il campo di Arbe, di 1000 bambini sotto i 16 anni, mentre per il campo di Monigo presso Treviso i dati a nostra disposizione per il 1943 parlano di 979 bambini su 3.188 internati.
Anche se sulle deportazioni e sull’occupazione italiana della provincia di Lubiana, esiste oggi in Slovenia una vasta documentazione, molti dati sui campi sono tuttora irreperibili, sia per la fretta con la quale le forze d’occupazione lasciarono la Slovenia, sia perché le autorità, nella loro ignominia, non badavano troppo alle cifre dei vivi o dei morti, degli arrivi e delle partenze, delle nascite e dei decessi nei campi. Per una riflessione su queste reclusioni forzate ci restano le testimonianze dei sopravvissuti e i componimenti dei bambini ai corsi scolastici organizzati nei territori liberi partigiani
[…] Negli scritti e nei disegni dei bambini internati conservati presso l’Archivio di Stato di Lubiana si può intravvedere questo trauma della fame e dell’inedia a cui si univa l’inclemenza della natura. I maestri che proponevano i temi e che poi di volta in volta annotavano i voti sui fogli, erano essi stessi dei sopravvissuti ai campi e qualcuno di loro aveva perduto in quell’inferno il proprio bambino o uno dei suoi cari. Erano dunque le persone più adatte per accogliere il dolore dei bambini passati nei campi e comprendere i loro traumi <16.
Essi sapevano che quelle tende, di volta in volta fradice e surriscaldate, non sarebbero mai scomparse dalla memoria dei bambini e che le esperienze narrate nello scritto di Ivan Štimec di 10 anni non si sarebbero mai cancellate: “Siamo stati deportati a Rab. Abbiamo vissuto in tende vicine al mare. Dormivamo sulla terra nuda. Una notte mentre dormivamo, il vento incominciò a soffiare ed incominciò a piovere. L’alta marea era cresciuta e l’acqua ci arrivò fino alle ginocchia. Abbiamo pianto e chiamato aiuto. Volevamo scappare, ma le guardie non ci lasciarono uscire dal recinto. Il mare continuò a crescere e molti bambini morirono annegati, mentre i nostri vestiti furono trascinati via dall’acqua. La mattina dopo la burrasca si calmò e uscì il sole asciugando e scaldando i nostri corpi, scossi dal freddo e dalla paura” <17.
La serie dagli scritti infantili continua con i ricordi delle delle cose belle e calde legati al tempo antecedente la distruzione dei paesi. I bambini rivedono le mucche lasciate sole a casa, o il viaggio verso l’isola di Rab-Arbe, o le cose di casa, il fuoco nel cammino o la casa stessa. Come scrisse Vera Cimprič di 9 anni: “Sono stata internata per 9 mesi. Pensavo spesso alla mia casa perduta. Ma quello che mi faceva piu’ male era il pensiero del nostro bestiame. Quelle che preferivo erano le mucche, perchè ci davano tanto latte. Si chiamavano Ruska e Breza. Quando dovevo pascolarle, pensavo che era difficile pascolare sempre le mucche. Ma durante l’internamento dove non avevamo né da mangiare né da lavorare, pensavo a quanto fosse bello essere sazi e pascolare. Dio, fa’ che possiamo avere ancora del bestiame” <18.
In tutti questi scritti la morte è onnipresente: si ricorda un coro che canta sulla fossa di una sorella morta o una scatola di cartone contenente il corpo di un amico ridotto ad uno scheletro. Come scrisse Mrle Slavka di 9 anni: “Tutti ci chiamano internati perché siamo stati internati. Siamo stati a Treviso. Avevamo tanta fame. A Treviso è morto mio fratello. Avevo ancora un fratello. Quando è ritornato dall’internamento è morto all’ospedale di Sušak. Quando lo abbiamo saputo abbiamo pianto molto” <19.
Accostando le storie dei bambini ai dati d’archivio si può intravedere una realtà agghiacciante. Come riferiva il generale Giuseppe Gianni, da luglio a novembre 1942, a Rab-Arbe morirono ben 104 bambini. Davanti a questi fatti le autorità italiane d’occupazione presero due decisioni: la prima ordinava l’evacuazione di donne e bambini da Rab-Arbe verso il campo di Gonars, la seconda ordinava ad una squadra di fotografi di documentare le condizioni di vita nel campo. Da Rab-Arbe a Gonars furono trasferiti tra il 21 novembre e il 5 dicembre 1942 ben 1.163 donne, 1.367 bambini e 61 uomini adulti <20.
L’8 settembre 1943 il regio esercito italiano si dissolse. Dalla Slovenia e dalla Jugoslavia lunghe colonne di militari disarmati presero la via dell’Italia e anche i campi di concentramento aprirono le loro porte. Come ricorda Marica Malnar di 10 anni: “Siamo stati internati a Treviso, avevamo fame e in inverno pativamo il freddo. Parlavamo sempre di come era bello a casa. Volevamo andare a casa. Un giorno i soldati entrarono nella nostra camerata e ci dissero che saremmo tornati a casa. Lo stesso giorno siamo partiti verso casa. Questo è stato per noi un giorno felice” <21.
Nelle colonne che partivano dai campi, i bambini orfani venivano accompagnati da parenti o gente comune, che davano loro una mano, un pezzo di pane o di rapa. Attraversando passo dopo passo il Friuli, qualcuno rivolgeva loro la parola e offriva un piatto di polenta. Al momento del ritorno a casa videro tanti edifici bruciati, le stalle distrutte e i fienili sfondati. Gli ex internati, malridotti e affamati, dovettero organizzarsi da soli. Un grande senso di solidarietà permise a questa gente di sopravvivere, ma alla fine dovettero rivolgersi ai comandi partigiani, che erano però impegnati a fronteggiare una pesante offensiva tedesca.
Soltanto più tardi i reduci dei campi ebbero un aiuto concreto dalle organizzazioni civili della resistenza che si erano organizzate nelle zone libere. Si provvide prima di tutto ai bambini orfani e a quelli che erano rimasti senza casa, senza parenti o senza altre possibilità. A molti di questi bambini l’organizzazione delle donne antifasciste (AFŽ) e l’organizzazione della gioventù socialista permisero di raggiungere regioni non devastate dalla guerra e in cui si era istituito un servizio scolastico <22.
[…]
[NOTE]
3 Metod Mikuž, Pregled zgodovine NOB. 1. knjiga, pp. 215-230, Ljubljana, 1960.
4 Boris M. Gombač, Dario Mattiussi (a cura di), La deportazione dei civili sloveni e croati nei campi
di concentramneto italiani: 1942-43. I campi del confine orientale, Gorizia, Centro Gasparini, 2004,
pp. 115-123.
5 Herman Janež, Koncentracijsko taborišče Kampor – Rab, Ljubljana, 1996, pp. 2-10.
6 Boris M. Gombač, Intervista a Herman Janež, sopravissuto ai campi di concentramento di Rab-
Arbe e Gonars, in Boris M. Gombač – Dario Mattiussi (a cura di), La deportazione dei civili sloveni e
croati, cit., pp. 41-48.
7 AS 1769, Zbirka okupatorjevi zapori in taborišca, šk. 1.
8 Bozidar Jezernik, Italijanska koncentracijska taborišca za Slovence med drugo svetovno vojno.
Ljubljana, 1997, pp. 288 – 289.
9 Dario Mattiussi, Una tragedia dietro al cortile di casa. La deportazione nei campi di
concentramneto italiani del confine orientale (1942-43), in Metka e Boris M. Gombac – Dario
Mattiussi, Quando morì mio padre. Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento
del confine orientale, Gorizia, Centro Gasparini, 2004, p. 47.
10 Boris M. Gombač, Intervista a Herman Janež, cit. , pp. 43-45.
11 Tone Ferenc, Rab- Arbe, Arbissima, Ljubljana, 2000, pp. 20-21.
16 Kumar Stane, Risal sem otroke v koncentracijskem taborišču, Otroštvo v senci vojnih dni, Ljubljana, 1980, pp. 144-148.
21 AS 1769, Zbirka okupatorjevi zapori in taborišča, šk. 1.
22 Tone Ferenc, Rab-Arbe-Arbissima, cit., pp. 33-34.
Metka Gombac, I bambini sloveni nei campi di concentramento italiani (1942-1943), DEP (Deportate, esuli, profughe: rivista telematica di studi sulla memoria femminile), n.3/2005
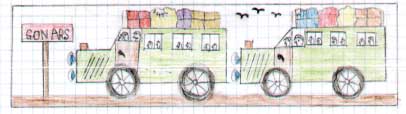

Il sistema concentrazionario creato dal regime fascista è uscito dall’oblio grazie ai lavori di storici come Carlo Spartaco Capogreco, Bozidar Jezernik e Tone Ferenc che ci hanno consentito di avere una conoscenza complessiva del fenomeno e delle sue dimensioni. L’indagine storiografica rischia però di rimanere fine a se stessa se non è accompagnata da una divulgazione scientifica, capace di rendere l’opinione pubblica consapevole anche delle pagine più buie della nostra storia. Parliamo ovviamente di un processo lungo, ostacolato anche dal silenzio sui campi di concentramento italiani nella manualistica scolastica.
Soprattutto nelle nostre province di confine, sarebbe opportuno che se ne parlasse di più, anche perché i campi di concentramento italiani, I campi del Duce, come li ha definiti Capogreco, non raccolsero solo anziani, donne e bambini deportati dalle zone d’occupazione militare o di nuova annessione istituite dopo l’aggressione alla Jugoslavia. Un numero consistente di deportati era costituito da cittadini italiani delle province orientali di nazionalità slovena e croata. Persone a cui finora è stata negata, di fatto, anche la memoria delle sofferenze patite. L’Italia non è l’unico Paese in Europa ad aver cercato di rimuovere l’esistenza di un proprio sistema concentrazionario. Anche la Francia, ad esempio, ha atteso molti anni prima di avviare un dibattito storiografico sui campi di concentramento realizzati ai piedi dei Pirenei all’inizio del secondo conflitto mondiale, campi in cui furono detenuti anche molti reduci dalla guerra di Spagna, italiani e sloveni, originari delle nostre province. Non dobbiamo però cadere in facili generalizzazioni, cercando analogie tra i campi di concentramento italiani presi nel loro insieme e i lager o peggio i campi di sterminio nazisti. Inevitabilmente il confronto non farebbe altro che relativizzare l’orrore dei campi fascisti. È necessario invece tener conto delle diverse realtà e tipologie della deportazione. Molti dei campi di concentramento “regolamentari”, gestiti cioè dal ministero degli Interni, rispondevano a requisiti minimi di vivibilità, erano visitabili dalla Croce Rossa e vi era la possibilità per gli internati di ricevere viveri dall’esterno e poter così migliorare le proprie condizioni di vita. Diversa era invece la situazione nei campi destinati agli internati jugoslavi, i “campi dell’internamento parallelo” come li definisce Capogreco. Qui i prigionieri, per lo più donne, anziani e bambini, erano costretti a una disperata lotta per la sopravvivenza, completamente nascosti al mondo e impossibilitati a ricevere aiuti dall’esterno. L’esercito italiano aveva già alle spalle una certa esperienza nella costruzione di campi di concentramento, basti pensare ai campi realizzati in Libia dal generale Graziani in cui trovarono la morte migliaia di civili. Si tratta di eventi ugualmente rimossi dalla nostra storia e praticamente sconosciuti all’opinione pubblica nazionale. A favorire questa rimozione fu certamente lo stereotipo culturale, tanto superficiale quanto diffuso, degli italiani “brava gente”, del soldato italiano “buono”, sempre diverso nei comportamenti verso la popolazione civile dall’alleato nazista. Contribuì poi, a guerra finita, anche la volontà degli alleati di condonare i crimini di guerra italiani in nome di un superiore interesse strategico. A livello politico inoltre nessun partito aveva interesse allora a rimettere in discussione l’immagine del nostro esercito in un dopoguerra che l’Italia affrontava da paese aggressore sconfitto, aggrappato alla Resistenza come simbolo di un riscatto morale completo e definitivo della nazione. Tutti i campi realizzati dall’esercito durante la seconda guerra mondiale furono definiti ufficialmente “campi di concentramento”, ma la definizione non rende conto delle diverse modalità con cui avveniva l’internamento. Capogreco ha definito illegale o meglio “fuori legge” l’internamento dei civili sloveni e croati praticato dal regime fascista dopo l’invasione della Jugoslavia. Invasione che per altro avvenne da subito al di fuori di ogni legge di guerra con il bombardamento improvviso di Belgrado e poi con la trasformazione dei territori sloveni occupati nella Provincia di Lubiana. Occorre però distinguere tra la violenza espressa in queste zone dall’esercito italiano nel 1941, mirata a obiettivi politici e militari ben definiti e quanto avviene a partire dal 1942, quando viene decisa e attuata una vera e propria strategia del terrore verso la popolazione civile. Le nuove direttive impartite dagli alti comandi, in un quadro ideologico marcatamente razzista, prevedono l’utilizzo contro la popolazione civile degli stessi metodi applicati dai nazisti sul fronte orientale: dall’incendio dei villaggi alla fucilazione di ostaggi, alla deportazione in massa dei civili in campi di concentramento per creare il vuoto attorno al movimento partigiano. In questo quadro non dovrebbe sorprendere che il tasso di mortalità registrato nel campo di concentramento di Arbe – Rab, dovuto alla fame, al freddo e alle condizioni igienico- sanitarie, sia stato per lunghi periodi superiore a quello dei peggiori campi di concentramento nazisti, esclusi quelli di sterminio. La differenza consiste solo nella mancanza di un’efficiente “macchina della morte”, sostituita da condizioni di vita insopportabili di cui ovviamente sono i bambini a pagare il prezzo più alto. Si tratta in ogni modo di morti che non possono essere attribuite al caso. Sono invece il risultato di decisioni prese a tavolino con cui si programmava, ad esempio, un vitto del tutto insufficiente. Questo sia per non sottrarre risorse all’esercito, sia per rendere i prigionieri più deboli e quindi controllabili con il minor impiego di truppe. Non si condanna a morte quindi ma si lascia morire e questo non solo nell’inferno di Arbe. La posizione al di fuori della legge di molti campi ebbe ripercussioni pesantissime per tutti i civili internati, definiti cittadini italiani “per diritto di annessione” e quindi privati anche dello status di sudditi nemici che avrebbe consentito almeno l’invio di viveri e vestiario pesante da parte delle organizzazioni internazionali. Soltanto nell’agosto del 1943 il ministero degli Affari Esteri permise alla Croce Rossa di assistere i civili croati e sloveni internati in Italia, a condizione che ciò non modificasse la loro posizione giuridica e che ci si limitasse a semplici azioni di carattere umanitario. Esiste quindi anche un problema di continuità tra regime fascista e governo Badoglio che deve essere affrontato. I campi non vengono chiusi dopo il 25 luglio ma abbandonati solo dopo l’8 settembre, spesso a causa della fuga degli addetti alla sorveglianza. In alcuni casi con un ritardo tale da permettere la cattura degli internati da parte dei nazisti. Certo non mancano le eccezioni. Gruppi di internati furono rilasciati dopo pressioni della Chiesa o per decisione dei comandi militari. Non si trattò tuttavia di una liberazione generale, a testimonianza del fatto che le responsabilità italiane non cessarono con la destituzione di Mussolini e la caduta del regime fascista. Si muore nella desolazione dell’isola di Arbe – Rab, come a Gonars in provincia di Udine e se il trasferimento di donne e bambini stremati da Arbe – Rab incide anche sui tassi di mortalità degli altri campi, questo non indica cambiamenti significativi nella filosofia dell’internamento. Abbiamo già detto che le autorità militari italiane fecero proprie le direttive emanate dai comandi tedeschi per combattere la resistenza lungo il fronte orientale. Questo spiega le fucilazioni di ostaggi e l’incendio dei paesi situati vicino a luoghi in cui si erano avuti combattimenti con le forze partigiane o da cui risultavano mancare uomini presumibilmente arruolati nelle formazioni partigiane. La deportazione di donne e bambini come ostaggi rientra sicuramente in questa strategia. I numeri della deportazione sono però troppo alti per trovare una spiegazione esauriente in queste direttive; sono anzi così alti da sconvolgere anche le strutture predisposte per l’internamento dai comandi militari tanto da trasformarle rapidamente da luoghi di segregazione in luoghi di morte. I motivi del degenerare della deportazione e della crescita esponenziale dei numeri sono probabilmente risposte alla stessa situazione sul campo. Da una parte, la crescita della resistenza armata, e il suo riorganizzarsi dopo ogni offensiva condotta dall’esercito, sono la dimostrazione che l’uso indiscriminato della violenza avvicinava la popolazione alla resistenza anziché allontanarla, vanificando anche i successi militari ottenuti dall’esercito grazie all’utilizzo di milizie di collaborazionisti, infiltrati e delatori; dall’altra, l’inefficacia di questa strategia spinge i comandi italiani a ordinare misure repressive sempre più drastiche, fino a pianificare la distruzione e lo spopolamento attraverso la deportazione in massa dei civili di una vasta zona al confine tra Slovenia e Croazia lunga alcune centinaia di chilometri e larga più di una decina. Si innescava così una spirale di violenza in cui gli stessi obiettivi militari finivano con l’essere stravolti. La ritorsione sui civili veniva giustificata come una vendetta per le perdite subite durante i rastrellamenti ma la stessa spingeva anche gli incerti alla scelta della lotta armata. In questa tragedia la guerra finiva col perdere ogni traccia di umanità, se mai l’aveva avuta. La deportazione e la morte dei bambini potevano essere considerate un effetto secondario cui non dare troppo peso e forse senza i documenti degli archivi militari e civili e soprattutto senza le testimonianze, i disegni e gli scritti dei sopravvissuti, potremmo davvero fingere che nulla sia accaduto, o che la responsabilità sia da addebitare esclusivamente a un ristretto gruppo di criminali di guerra.
Per saperne di più
Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce. L’internamento civile dell’Italia fascista (1940-1943) Torino, Einaudi, 2004;
Tone Ferenc, Rab-Arbe-Arbissima. Confinamenti-rastrellamenti-internamenti nella provincia di Lubiana 1941-1943, Lubiana, 2000;
Alessandra Kersevan, Un campo di concentramento fascista. Gonars 1942-1943, Udine, KappaVu, 2003
Bozidar Jezernik, Boj za obstanek, Lubiana, 1983;
Boris M. Gombac e Dario Mattiussi (a cura di), La deportazione dei civili sloveni e croati nei campi di concentramento italiani: 1942-1943. I campi del confine orientale, Gorizia, Centro “L. Gasparini”, 2004
Metka Gombac, Boris M. Gombac, Dario Mattiussi, Quando morì mio padre. Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale: 1942-1943, Gorizia, Centro “L. Gasparini”, 2004.
Dario Mattiussi (Curatore della mostra)
La mostra Quando morì mio padre. Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale: 1942-1943, curata da Metka Gombac, Boris M. Gombac, Dario Mattiussi, raccoglie in 26 grandi pannelli a colori disegni e testimonianze di bambini sloveni, fra i 6 e gli 11 anni, sopravvissuti ai campi di concentramento italiani. La mostra, realizzata dal Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini”, è stata allestita con successo a Gorizia, Venezia, Capodistria, Maribor ed è attualmente esposta presso la Risiera di San Sabba, Monumento Nazionale, a Trieste dove può essere visitata tutti i giorni fino al 28 gennaio 2007. L’ingresso è libero; sono a disposizione guide per gruppi e scolaresche.
La memoria recuperata in una mostra
I materiali riprodotti nella mostra, messi a disposizione per la prima volta dall’Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia e dal Museo nazionale sloveno di Storia contemporanea di Lubiana, costituiscono un’accusa che non lascia spazio a giustificazioni. Tanto i disegni quanto i brevi scritti furono realizzati, dopo la liberazione dai campi, in zone libere della Slovenia in strutture mediche partigiane, nel tentativo di far rielaborare ai piccoli sopravvissuti, in gran parte orfani, l’esperienza subita. Collaborarono anche maestri elementari, anche loro ex deportati, certamente le persone più adatte a relazionarsi con i giovani orfani appena rientrati dai campi. Recuperare questa memoria e renderne consapevole l’opinione pubblica nazionale e soprattutto le generazioni più giovani è anche un dovere civile. Non solo un riconoscimento alle vittime di allora ma un impegno morale che ci coinvolge tutti e che può dare la misura del cammino verso la democrazia che questo Paese ha saputo compiere in questi anni, senza distinzioni di appartenenza politica.
Redazione, Il lager del fascismo. Una tragedia dietro il cortile di casa, Triangolo Rosso, dicembre 2006, articolo qui ripreso da Francesco Coluccio