
Secondo fonti britanniche, «la politica italiana era di trasferire in Italia il prima possibile gli ufficiali e il personale tecnico. Sebbene la maggior parte [fosse] stata trasportata in aereo, una minoranza viaggiò in sottomarino». <86 Queste erano, però, appunto, minoranze privilegiate: la gran parte dei soldati alleati viaggiò dall’Africa all’Italia in nave, in condizioni estremamente disagevoli quando non disastrose, in un mare estremamente pericoloso.
All’inizio, l’Italia non prevedeva il trasferimento immediato in territorio metropolitano di tutti i prigionieri, anzi. Nell’agosto 1940, l’ufficio servizi dello SMRE stabiliva infatti che «i prigionieri di guerra catturati in A[frica] S[ettentrionale] ed Egeo – salvo non ven[isse] disposto diversamente – [sarebbero] rest[ati] nei territori sopra indicati e in quei campi che i comandi interessati [avessero voluto] costituire». <87 Poi, come è noto, la guerra si sviluppò in modi del tutto inaspettati per gli italiani, sia in Africa sia, soprattutto, nei Balcani.
Uno dei principali pericoli ai quali un prigioniero di guerra si trovava esposto era rappresentato, senza dubbio, dai viaggi di trasferimento dal luogo di detenzione provvisoria a quello definitivo. Era un viaggio lungo, fatto di numerose tappe intermedie – altri campi di transito – e rischioso: i prigionieri viaggiavano infatti su navi del detentore che attraversavano mari e oceani, vera e propria prima linea, senza alcuna tutela dagli attacchi nemici, cioè da parte dei propri connazionali o alleati. Le navi che trasportavano i prigionieri non godevano, infatti, di alcun tipo di protezione simile a quella vigente per le navi ospedale, e difficilmente i governi si accordavano in merito, in quanto su quelle imbarcazioni non sempre c’erano solo soldati nemici catturati (del resto, non si aveva alcun modo per controllare che ciò avvenisse <88). Il trasferimento rendeva quindi le forze armate di appartenenza il principale ostacolo all’arrivo in un luogo che, per quanto nemico, finiva inevitabilmente con il venire considerato più sicuro dell’infernale mare aperto.
Per il trasferimento dei prigionieri nemici nella penisola, gli italiani utilizzavano spesso delle navi cargo totalmente inadatte al trasporto di uomini, in base al sistema descritto, nel dopoguerra, da Crisippo Pagliocchini, comandante dell’intendenza di Tripoli tra l’aprile del 1942 e il gennaio del 1943, che venne ascoltato nell’ambito dell’inchiesta relativa all’affondamento della “Scillin”:
“Quando una nave mercantile arrivava a Tripoli, veniva scaricata <89. La capitaneria di porto mi riferiva se in porto vi era una nave vuota. Se non c’erano rifornimenti da caricarvi per il viaggio di ritorno in Italia, io informavo un certo maggiore Cozzolino, un ufficiale di artiglieria dell’esercito italiano […]. Il maggiore Cozzolino era il capo dell’Ufficio Tappa, e dirigeva il trasferimento dei prigionieri di guerra. A quel punto, lui ordinava che un certo numero di prigionieri fosse portato, da un campo di concentramento, al porto di Tripoli. Insieme al comandante della nave, alla capitaneria di porto e all’ufficio imbarchi, gestivano il caricamento dei prigionieri sulla nave. Era una loro responsabilità”. <90
Da queste traversate non erano solitamente esentati neanche i feriti gravi che, invece, se non in condizioni di muoversi, avrebbero dovuto essere trattenuti, per essere curati, in campi e ospedali situati nei pressi dei luoghi della cattura. La conseguenza era che tali feriti, trasportati in Italia, finivano per morire negli ospedali – in particolare, quello di Caserta – per le ferite riportate in combattimento. <91
Ken De Souza descrive il viaggio come una vera e propria «disces[a] all’inferno»:
“L’inferno era una prigione sotterranea fatta d’acciaio, che ribolliva di dannati, piena di gemiti e grida di angoscia improvvisa e che puzzava progressivamente nel caldo senza aria. Gradualmente, con la luce che a stento filtrava attraverso le fessure del fasciame metallico del ponte, il primo terribile buio si attenuò. l’oscurità che lo rimpiazzò era ancora più raccapricciante, poiché attraverso essa fummo maggiormente in grado di vedere le sofferenze intorno a noi: il tossire ed i conati di vomito degli ammalati, le contorsioni di dolore dei feriti, la debolezza scheletrica degli affamati, la processione miserevole di uomini che scavalcavano vacillando i corpi dei compagni per andare verso i secchi usati come latrine. […] Per me quell’orrore non avrebbe mai potuto essere allontanato, né mai in seguito rimosso. […] Stavo sdraiato, immobile, con gli occhi serrati e pregavo. Ogni qualvolta, come accadeva di frequente, la gente incespicava su di me non dicevo nulla, rimanendo completamente inerte. Con l’infittirsi delle tenebre, la puzza proveniente dai fusti-latrine già traboccanti divenne ancor più nauseabonda ed a causa del pauroso sovraffollamento ogni respiro era uno sforzo. […] A due prigionieri di guerra venne ordinato di issare i fusti-latrina. Proprio mentre facevano forza sui cavi la nave cominciò a rollare. Il primo dei fusti salì a scosse, dondolando in cerchio e versandosi. Alla fine fu portato a mano attraverso l’apertura del boccaporto […]. Poi il secondo fusto fu sollevato e vuotato nello stesso modo. Infine i fusti furono calati di nuovo giù e rimessi a posto. La degradazione, per cui esseri umani venivano trattati peggio del bestiame, doveva continuare per tutta la fetida, calda giornata. Ancora una volta i boccaporti furono chiusi ed inchiavardati; e, poiché all’esterno il sole bruciava, la nostra gabbia d’acciaio divenne un forno senz’aria. Prima che la tortura di quel giorno terminasse, la vita era diventata quasi insopportabile. Il morale era a terra: la morte o il continuare a vivere sembravano idee ugualmente possibili. La lenta agonia o il veloce siluro, eravamo troppo immersi nella sofferenza per fregarcene”. <92
Le condizioni del viaggio erano di solito queste, in una scala qualitativa che, come scrive Gilbert, andava «da scarso ad abominevole». <93 Durante la traversata, non si poteva far affidamento sulle guardie che – come ogni prigioniero sapeva benissimo – nel caso di un attacco alla nave, si sarebbero preoccupate in primo luogo della propria incolumità, piuttosto che di mettere in salvo i soldati che trasportavano. In sintesi, il viaggio verso la prigionia definitiva rendeva nemici tutti, alleati o detentori che fossero, mentre rappresentava un’esperienza accomunante per ogni prigioniero. Infatti, se il britannico Cheetham ricordava nelle sue memorie «la stiva nera della nave dove eravamo stati ammucchiati a mo’ di zavorra, e pregavo che i nostri sottomarini non fossero nei paraggi», <94 un prigioniero italiano ricordava la stiva del “Laconia” – transatlantico britannico carico di prigionieri italiani affondato da un sottomarino tedesco nel settembre 1942 – come una «bara che non dava nessuna possibilità di scampo» <95 se fosse stata colpita, come effettivamente accadde, dai siluri di un U-boot.
Le vittime dei viaggi di trasferimento, da una parte e dall’altra, furono numerose: il primo naufragio si ebbe nel dicembre del 1941, quando un sommergibile tedesco affondò il piroscafo britannico “Shuntien”, che trasportava prigionieri italiani e tedeschi dalla Cirenaica all’Egitto. Le vittime italiane furono 825.96 Qualche tempo dopo, nel settembre 1942, persero la vita quasi tutti i 1.800 prigionieri italiani imbarcati sul “Laconia”; <97 nel novembre successivo l’affondamento del “Nova Scotia” provocò altre 649 vittime; <98 nel marzo 1943 fu la volta dell’”Empress of Canada” e di altre 255 vittime tra i prigionieri italiani. <99 I prigionieri alleati, invece, morirono nelle tragedie della motonave “Sebastiano Venier” <100 – colpita nel dicembre 1941 da un siluro britannico al largo del Peloponneso e colata a picco trascinando con sé circa un terzo dei 2.100 uomini a bordo <101 – e in quella del piroscafo “Tembien”, che nel febbraio 1942 fu affondato da un’unità della Royal Navy a largo di Tripoli, mentre trasportava in Italia i prigionieri del Commonwealth catturati durante l’operazione Crusader. Le vittime furono centinaia. <102 In quello stesso mese di febbraio 1942, un altro piroscafo, l’”Ariosto”, che viaggiava da Tripoli a Palermo, fu affondato da un sommergibile britannico, trascinando a fondo con sé 138 prigionieri (circa la metà degli imbarcati) e 20 italiani. <103 Nell’affondamento della “Nino Bixio”, colpita, nell’agosto 1942, da un siluro “amico” dei prigionieri, persero la vita 432 uomini. <104 Nello stesso periodo veniva colpita anche l’”Ogaden”, tomba di altri 200 prigionieri alleati. <105 Ancora, nell’ottobre 1942, fu silurato, nei pressi di Isola delle Femmine, quindi a largo della Sicilia, il piroscafo “Loreto”,che trasportava prigionieri indiani provenienti da Tripoli. Morirono circa 130 persone. <106 Infine, la menzionata tragedia della nave “Scillin”, affondata nel novembre 1942, durante la quale morirono (almeno) altre 776 persone. <107
Fu solo dopo eventi del genere, nel maggio 1943, che l’Italia propose di stipulare un accordo con la Gran Bretagna perché le navi trasportanti prigionieri fossero opportunamente segnalate e contraddistinte in modo che non fossero attaccate da fuoco amico. <108 La storia dell’affondamento della nave cargo SS “Scillin”, emblematica di questo tipo di esperienza, ha a lungo conservato un’aura di mistero e di silenzio nella stessa Gran Bretagna. Di scarse 1.600 tonnellate e con spazio per sole 300 persone, <109 la nave partì da Tripoli nella metà del novembre 1942. Avrebbe dovuto imbarcare 1.010 prigionieri britannici, ma le vibranti proteste del capitano medico Theodore Gilbert riuscirono a ottenere che gli italiani vi stipassero “solo” 810 prigionieri, comunque quasi il triplo di quelli che l’imbarcazione poteva contenere. Il viaggio, come tutti quelli che avvennero in quei frangenti, si svolse in condizioni disastrose per il sovraffollamento e la conseguente carenza di attrezzature e di cibo. I prigionieri imbarcati sulla “Scillin” erano quasi tutti affetti da dissenteria, e molti addirittura troppo deboli per raggiungere le latrine, alle quali potevano accedere solo in pochi alla volta, dopo file estenuanti. A bordo della nave non vi erano giubbotti di salvataggio per i prigionieri, né scialuppe o salvagenti sufficienti. Il viaggio, però, durò poco: partita da Tripoli nella serata del 13 novembre, alle 20.30 del 14 la “Scillin” fu colpita dai siluri di un sottomarino britannico. <110 Dei prigionieri alleati si salvarono solo coloro che, per le disastrose condizioni fisiche in cui versavano, erano stati ammessi sul ponte, dopo le ripetute insistenze dello stesso capt. Gilbert. Alcuni morirono a causa delle esplosioni provocate dai siluri, ma la gran parte annegò, non essendovi per loro alcuna possibilità di lasciare la stiva della nave. I superstiti, tra i prigionieri, furono presumibilmente solo 27, gli italiani 36. Furono tutti messi in salvo dallo stesso sottomarino che li aveva silurati. <111 Secondo alcuni dei sopravvissuti, la nave non aveva contrassegni né bandiere; inoltre, a quanto pare le sentinelle italiane avevano impedito ai prigionieri di lasciare le stive. <112
Solo in anni relativamente recenti la tragedia della “Scillin” è divenuta nota a livello nazionale, ma solo in Gran Bretagna (in Italia non lo è affatto, come non lo sono, del resto, quelle che coinvolsero prigionieri italiani). Il fatto che il siluro che affondò la nave provenisse da un sottomarino britannico ha pesato molto sulla “resa pubblica” della vicenda, i cui documenti, peraltro, sono stati tenuti segretati fino alla metà degli anni Novanta del secolo scorso. Ciò ha dato adito a varie teorie complottiste che fanno riferimento, soprattutto, al fatto che grazie alla macchina “Ultra” i britannici conoscessero alla perfezione i movimenti della “Scillin” e sapessero che a bordo vi erano prigionieri, e ciononostante affondarono ugualmente la nave proprio per non far comprendere al nemico la qualità, se non l’esistenza stessa delle loro intercettazioni. <113 In realtà, queste teorie potrebbero valere per tutti gli affondamenti che si verificarono durante il conflitto e coinvolsero prigionieri di guerra, la cui morte, tuttavia, va maggiormente (e concretamente) ascritta ai detentori – e ciò vale anche per gli Alleati, ovviamente – che imbarcarono i prigionieri su navi inadatte, non adeguatamente segnalate, non dotate di scialuppe o giubbotti salvagenti in numero sufficiente, e così via.
La Croce Rossa Internazionale, prima ancora che avvenissero i grandi affondamenti dell’autunno-inverno 1942-43, aveva denunciato la pericolosità dei trasferimenti e invitato le potenze belligeranti a trovare un accordo sulle modalità di questi ultimi.
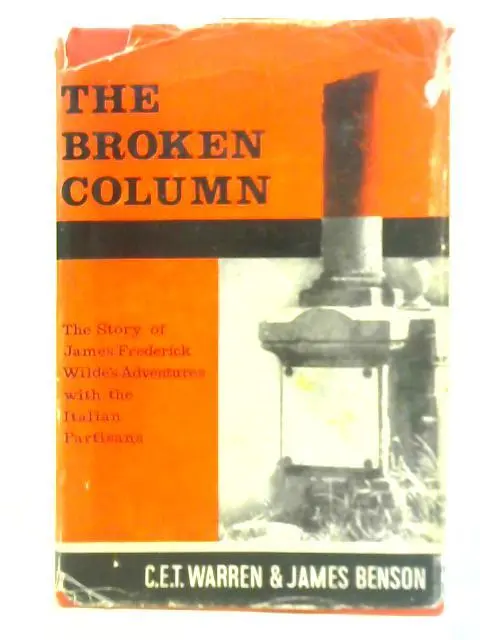
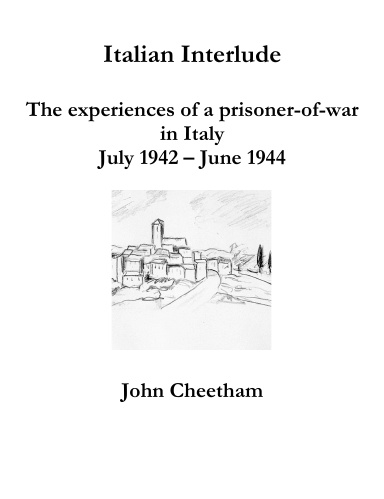
[NOTE]
86 TNA, TS 26/95, «War Crimes. Additional information on incidents reported in PW Camps in Italy», rapporto del WO al TS e al Jag, 21 giugno 1945, p. 15; TNA, WO 311/316, Affidavit del capt. W.P. Bulmer, 25 maggio 1945.
87 AUSSME, M7, b. 3131, f. 1, SMRE, Ufficio servizi, «Norme riguardanti i prigionieri di guerra», 7 agosto 1940. La stessa cosa valeva per i soldati nemici eventualmente catturati in Albania.
88 Questo lo sapeva benissimo, e lo faceva notare prima di chiunque altro, la Croce Rossa Internazionale: ACICR, BG-003-38-5, Missione in Italia di Cheneviere e C. Pilloud (ICRC), «Note», 20 maggio 1941. Del resto, vi sono testimonianze che alludono alla presenza di truppe italiane trasportate illecitamente sulle stesse navi ospedale, sulle quali erano caricate anche armi e munizioni: cfr. ad es. TNA, TS 26/136, «Statements by non-European personnel who were prisoners of war in enemy hands at Tobruk, Mersa Matruh, Derna and Benghazi», 27 novembre 1942, passim.
89 Tra i tanti viaggi terribili, Horn ce ne ricorda uno – sulla base della testimonianza di M. de Lisle – tutt’altro che traumatico: i prigionieri furono imbarcati a Bengasi su una nave che doveva fare tappa a Tripoli, dove sarebbero stati scaricati i pacchi natalizi destinati alle truppe italiane. Rinchiusi nelle stive come al solito, i soldati scoprirono i pacchi e fecero man bassa di tutto ciò che era commestibile, con il risultato che, arrivati a Tripoli, i prigionieri erano strafatti di zucchero e i pacchi erano inesorabilmente vuoti, come confermavano le urla degli italiani, che minacciavano tremende rappresaglie: Horn, In enemy hands, cap. 3.
90 TNA, WO 311/304, Traduzione della dichiarazione di C. Pagliocchini, 2 settembre 1946. La dichiarazione di L. Cozzolino, già tenente colonnello, s.d., è conservata nello stesso faldone. Costui negò qualsiasi responsabilità relativamente al numero degli imbarcati, pur constatando che, effettivamente, le condizioni di salute di questi ultimi fossero, in alcuni casi, «deplorevoli». Il faldone contiene anche la dichiarazione di Renato Parigi (19 gennaio 1946), comandante della “Scillin”, che sostenne di aver personalmente limitato il numero degli imbarcati, le cui sistemazione a bordo era, a suo dire, soddisfacente: i prigionieri non erano rinchiusi ma anzi erano liberi di muoversi sulla nave e sui suoi ponti. Non avevano giubbotti, perché a Tripoli non ce n’erano, ma le scialuppe erano sufficienti per tutti.
91 È ciò che accadde, ad esempio, al marinaio A.W. Scott che, arrivò a Caserta dal fronte africano il 19 ottobre 1942, fu ricoverato in condizioni molto gravi e morì per fratture e paralisi cardiaca il 13 novembre successivo: AAV, Inter Arma Caritas (d’ora in avanti IAC), Ufficio Informazioni Vaticano (d’ora in poi UIV) per i prigionieri di guerra, Sezione prigionieri di lingua inglese (d’ora in poi Sez. prig. ingl.), b. 445, e https://www.cwgc.org/find-wardead/casualty/2067564/scott,-anthony-walter/. La busta 445 citata conserva l’elenco di prigionieri o combattenti nemici deceduti in mani italiane, redatto sulla base di liste periodiche inviate dalla Croce Rossa Italiana agli uffici vaticani. Tali liste risalgono al periodo compreso tra il marzo e l’ottobre 1943.
92 De Souza, Fuga dalle Marche, pp. 101-103.
93 Gilbert, POW, p. 51.
94 Cheetham, Italian Interlude, p. 9.
95 Testimonianza del maresciallo maggiore B. Beltrami, Nelle stive si scatenò di colpo l’inferno, in Prigionia: c’ero anch’io, a cura di G. Bedeschi, Milano, Mursia, 2002, vol. II, p. 44.
96 ACS, MI, DGPS, A5G, II GM, b. 116, f. 59, MG, CIPG, «Notiziario n. 22», 30 giugno 1942-XX, p. 15.
97 Sul Laconia erano imbarcati 1.800 italiani. Non è chiaro quanti sopravvissero alla tragedia: Sponza, in base ad alcune fonti britanniche, scrive nessuno (Sponza, Divided Loyalties, p. 189), ma non può essere così data la presenza di testimonianze di superstiti.
98 Ivi, p. 190.
99 Ibidem. L’Empress of Canada fu affondata dal sottomarino italiano Da Vinci.
100 La motonave, costruita in Italia e destinata alla vendita in Olanda con il nome di Jason, dopo l’invasione del paese fiammingo rimase in Italia con il nome di Sebastiano Venier: http://www.archeologiaindustriale.it/sez_produzione_it.php?form_search__special__command=clear&content_type=na ve&goto_id=844. Secondo Sadkovich, il sistema Ultra riferì di prigionieri a bordo della Sebastiano Venier solo dopo l’affondamento: J.J. Sadkovich, La Marina italiana nella seconda guerra mondiale, Milano, Feltrinelli, 2014, cap. IX n. 70 (kindle ed.).
101 A quanto scrive Gilbert, l’equipaggio italiano abbandonò subito la nave, che fu presa in carico da un ingegnere tedesco il quale, aiutato dai prigionieri, riuscì a salvare gli altri. La Venier affondò presso l’isola greca di Pylos: Gilbert, POW, p. 49. Secondo un primo rapporto del delegato dell’ICRC in Italia, i superstiti britannici furono almeno 1.800 sui 2.000 imbarcati: ACICR, BG-003-24-1, Pilloud, «Telephone de M. Lambert de Rome a M. Pilloud le 15 décembre 1941 a 10 heures». Secondo Horn, invece, i morti furono tra i 350 e i 450: Horn, Changing Attitudes among South African Prisoners of War, p. 210, che si basa nuovamente su Leigh, Captives courageous, p. 39. Vedi però, soprattutto, Id., Horn, In enemy hands, cap. 3, che si sofferma su alcuni episodi di particolare insensibilità dimostrata, anche in quell’occasione, dagli italiani, che abbandonarono i prigionieri a se stessi o addirittura mercanteggiarono la consegna di alcuni salvagenti. Riguardo al numero delle vittime degli affondamenti, va notato che l’ufficio prigionieri dello SMRE ordinò alle autorità italiane in Africa settentrionale di compilare liste degli imbarcati fu solo nel giugno 1942, e in ogni caso ciò continuò a non essere fatto con regolarità: AUSSME, N1-11, b. 740, DS dello SMRE-UPG-Segr., mesi di giugno-luglio 1942, all. 10, SMRE-UPG, Col. E. Pallotta, «Elenco pg. in caso di trasferimento via mare o aereo», 7 giugno 1942.
102 ACS, MI, DGPS, A5G, II GM, b. 116, f. 59, MG, CIPG, «Notiziario n. 22», 30 giugno 1942-XX, p. 16; https://www.wrecksite.eu/casualty-list.aspx?BmujHWcq4QXPqBHhiFoPLUS1A==#149126; AUSSME, N1-11, b. 667, DS dello SMRE-UPG-Segr., mesi di febbraio-marzo 1942, all. 2, SMRE-UPG, «Trattamento pg. Misure di sicurezza», circolare ai comandi di corpo d’armata e ad altri, 21 febbraio 1942. Secondo Sadkovich, le vittime del Tembien furono 419: La Marina italiana nella seconda guerra mondiale, cap. VII.
103 I dati numerici sono tratti da AUSSME, N1-11, b. 667, DS dello SMRE-UPG-Segr., mesi di febbraio-marzo 1942, 20 febbraio 1942, e dalla pagina http://www.betasom.it/forum/index.php?/topic/41914-prigionieri-britannici-sullogaden/. Sadkovich scrive che le vittime dell’Ariosto furono 135: La Marina italiana nella seconda guerra mondiale, cap. VII.
104 Gilbert, POW, p. 51; http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sooty/ninobixio.html. Si veda anche, TNA, WO 311/307, la testimonianza di un sopravvissuto al naufragio, il lt. R. Flores, rilasciata in data non precisata. Una stele in memoria delle 155 vittime australiane e neozelandesi della Nino Bixio è stata eretta nel luogo in cui un tempo sorgeva la chiesetta del campo di Grupignano: http://www.campo57.com/products.html.
105 https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?136935; Sadkovich, La Marina italiana nella seconda guerra mondiale, cap. IX n. 70.
106 https://wrecksite.eu/wreck.aspx?156598; http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/prod_editoriali/pubblicazioni_pdf/patrimonio%20ritrovato.pdf. Secondo Sadkovich, le vittime furono 400: La Marina italiana nella seconda guerra mondiale, cap. IX n. 70.
107 TNA WO 311/304, J.E. Kelly, «The sinking of the SS Scillon [sic]. Second World War Italian Prisoners-of-War Transport», 22 luglio 1996. A questa nota, compilata dal capo degli archivi del ministero della Difesa britannico, è allegata la lista dei nominativi dei prigionieri realizzata sulla base di approfondite ricerche, effettutate nella prima metà degli anni novanta del secolo scorso. I nominativi sono distinti tra quelli di coloro che vennero visti per l’ultima volta al campo 154 (Bengasi) e quindi presumibilmente morirono nell’affondamento; quelli di coloro che morirono secondo le testimonianze dei superstiti; quelli di coloro che sbarcarono prima della partenza (196); infine, quello di un prigioniero che morì prima della partenza. Le vittime note sono solo 260; i superstiti furono 27. In ogni caso, i dati numerici non possono considerarsi definitivi, nè mai lo saranno, come si sapeva già nell’immediato dopoguerra: «si sono verificati casi – scrivono Satow e See nel 1950 – in cui sia noi sia gli italiani abbiamo imbarcato prigionieri sulle navi senza tenere alcun tipo di registro così che, quando la nave è stata affondata, non avevamo idea di chi fosse annegato»: Satow e See, The work of the Prisoner of War Department during the II World War, p. 15. A detta di Sadkovich, le vittime della “Scillin” furono 830: La Marina italiana nella seconda guerra mondiale, cap. IX n. 70.
108 ACS, MI, DGPS, A5G, II GM, b. 116, f. 59, MG, CIPG, «Notiziario n. 33», 15 maggio 1943-XXI, p. 24. In precedenza, l’Italia si era opposta alla proposta dell’ICRC di utilizzare un particolare segno distintivo per le navi trasportanti prigionieri, sostenendo che tale distintivo «mentre non [avrebbe] forni[to] sufficiente garanzia alle navi che lo porta[va]no, [avrebbe] da[to] viceversa la possibilità al belligerante di servirsi abusivamente e senza possibilità di controllo di tale distintivo»: Ivi, «Notiziario n. 22», 30 giugno 1942-XX, p. 17.
109 Secondo il fascicolo d’inchiesta dell’UNWCC, il cargo aveva spazio sufficiente per non più di «300 prigionieri in normali condizioni di salute. [Invece] tutti i prigionieri destinati all’imbarco erano malati, perlopiù di dissenteria»: TNA, WO 311/304, UNWCC charge no. UK-I/B. 11. Gli accusati, ignoti, erano il comandante del campo di Tripoli dove erano stati alloggiati i prigionieri poi imbarcati, e l’ufficiale italiano che aveva gestito l’imbarco. Poi, se sopravvissuti, l’ufficiale italiano responsabile dei prigionieri a bordo della nave e il comandante di quest’ultima. Molti di costoro furono individuati successivamente e rilasciarono le proprie testimonianze, contenute nel faldone. Era difficile, tuttavia, ritenerli direttamente responsabili della morte dei prigionieri, avvenuta a causa del siluramento. Difatti il caso fu chiuso, con un nulla di fatto, tra fine 1946 e inizio 1947: Ivi, Jag-GHQ Central Mediterranean Forces (firma illeggibile), «Sinking of “Scillon” [sic]», 29 novembre 1946; Ivi, Brig. H. Shapcott, «Sinking of Italian prisoner-of-war transport S.S. Scillon [sic]», 12 dicembre 1946; Ivi, Jag-GHQ Central Mediterranean Forces (firma illeggibile), «Sinking of S.S. “Scillon” [sic]», 4 gennaio 1947. I nomi sono tutti reperibili nella documentazione contenuta nel faldone. Le condizioni del viaggio, con i prigionieri malati rinchiusi nelle stive, sono le stesse, tragiche, degli altri trasferimenti. Le fonti, in merito, sono numerosissime.
110 Si trattava del Sahib, che sarebbe stato affondato, a sua volta, nella primavera del 1943. L’equipaggio, interamente recuperato con l’eccezione di un uomo, fu portato in prigionia in Italia e internato, probabilmente a Poggio Mirteto (cfr. 3.1.), insieme al personale del sottomarino Splendid, anch’esso affondato in quel periodo: C.E.T. Warren e J. Benson, The Broken Column: the Story of James Frederick Wilde’s Adventures with the Italian Partisans, London, Harrap, 1966, pp. 18-19. Come i piloti, gli equipaggi dei sottomarini erano considerati importanti fonti d’intelligence, e venivano portati in campi speciali per essere interrogati.
111 TNA TS 26/95, «Appendix P. Reports of incidents during transport of PW», p. 1.
112 TNA, WO 310/26, AIO/11/5, estratti dagli interrogatori di superstiti della “Scillin”, 29 gennaio 1943, pp. 15-16. Cfr. anche TNA, WO 311/304, Affidavit del pte. R.G. Lloyd, 25 ottobre 1946; Ivi, Dichiarazione del pte. C. Jenkins, 25 ottobre 1946, e altri nello stesso faldone.
113 Cfr. ad esempio http://www.trentoincina.it/mostrapost.php?id=268 e https://web.archive.org/web/20110716053929/http://www.sheernessheritagecentre.com/page24hmsubsahib.htm, ma anche il citato http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/prod_editoriali/pubblicazioni_pdf/patrimonio%20ritrovato.pdf. Sul ruolo di Ultra e il fatto che la Gran Bretagna fosse a conoscenza della presenza dei prigionieri, almeno sulla “Scillin” e sul Loreto, cfr. anche A. Santoni, Il vero traditore. Il ruolo documentato di ULTRA nella guerra del Mediterraneo, Milano, Mursia, 1981 e 2005, passim.

Isabella Insolvibile, I prigionieri alleati in Italia. 1940-1943, Tesi di dottorato, Università degli Studi del Molise, Anno accademico 2019-2020