
[…] La domanda che adesso dobbiamo porci è come mai la letteratura, per lo meno in
Italia, di fronte alla persecuzione razziale con la stessa lucidità dimostrata in altre
circostanze non abbia saputo assolvere il compito che di solito in Italia ha sempre
saputo assolvere. E’ esistita una buona , anzi ottima memorialistica, ma è mancato il
coraggio della scrittura narrativa.
Il problema si pone adesso con drammaticità, di fronte all’estinguersi dell’era del
testimone. Nel momento in cui i superstiti del Lager, ad uno ad uno, ci lasciano il
richiamo della letteratura si fa incalzante. Come sempre è accaduto in passato la
letteratura si fa rivale della storia di fronte alla rappresentazione degli orrori e delle
atrocità. Si pensi al ruolo che ha avuto Manzoni, nella nostra tradizione letteraria, al
fine di tramandare e renderci coscienti di quell’altro unicum che fu la peste del
Seicento. Si rende necessaria una esortazione non alle istorie, ma alle lettere.
Ora il paradosso consiste nel fatto che la letteratura, per ciò che concerne la Shoah in
Italia, giunge al tramonto e non all’alba dell’esperienza testimoniale, come viene
confermato anche dalla lettura di Mengaldo nel suo ultimo libro.
1. Insipienter locutus sum
La cosa più bella dell’ultimo libro di Mengaldo è il finale. L’enormità dei fatti su cui
siamo chiamati a riflettere leggendo un libro come questo induce uno studioso di lunga
esperienza a scegliere la strada della modestia e dell’umiltà e a dire così nell’ultima
pagina, in una frase non per caso messa fra parentesi: “Ho parlato da stolto, sono cose
troppo alte e non le capisco”. Insipienter locutus sum. Et quae ultra modum excederent
scientiam meam ” (Giobbe 42, 3).
Il libro “fa perno” sull’opera di Primo Levi e per certi versi si può dire estenda
all’intera memorialistica sul Lager (e non soltanto) il metodo inconfondibile che tanto
avevamo apprezzato nei lavori maggiori sulla tradizione del Novecento. Mengaldo è
uno straordinario lavoratore di intarsio […] Mengaldo è agli antipodi di Giacomo
Debenedetti, non usa l’arma della seduzione. In questo libro anche la sua prosa risente
dello “stile spezzato” di cui parla in un capitolo cruciale: un riflesso condizionato, si
direbbe, quasi un contagio determinato dall’oggetto della propria analisi (questo
spiegherebbe pure il tono apodittico di certe note a piè di pagina e la curiosissima ars
citandi). L’intendimento scientifico-accademico è però sempre frenato dall’umiltà di
un critico che si rende conto di essersi addentrato in questioni nelle quali il giudizio
“non si potrà mai tagliare con l’accetta”.
Con l’opera di Levi i risultati raggiunti in passato erano stati mirabili. Ed anche in
questo libro le notazioni, soprattutto su Se questo è un uomo, sono sempre preziose.
Questo nuovo lavoro è però dichiaratamente sperimentale: una prova, o meglio una
sfida da parte di chi non si accontenta più dello stile di uno scrittore, ma si allarga a
esperienze fra loro poco sovrapponibili (come i quaderni dei prigionieri rinchiusi nelle
carceri fasciste o staliniane, le memorie dei reclusi, i diari, le corrispondenze private,
testi di natura diversa riuniti insieme da una mappa tematica ruotante intorno a
questioni assai controverse per gli storici e del tutto inesplorate da parte degli
italianisti). Qualche perplessità potrà suscitare la giustapposizione di testi composti in
periodi fra loro molto lontani, senza che si tengano nel giusto conto i tempi e le
modalità di una memoria come quella della Shoah, che, specie in Italia, ha avuto molte
e continue oscillazioni. E senza considerare che molti giudizi resi trenta o quarant’anni
fa dal testimone si sono modificati con il sopraggiungere di nuove conoscenze.
Mengaldo, per nostra fortuna, non cede alle sirene di nessuna lettura mitologica di
Levi, con il quale, in questo libro, instaura un intelligente dialogo a distanza, talora
anche severo. Per esempio Mengaldo contesta il concetto di “violenza inutile”,
centrale nel Sommersi e i salvati. E le sue osservazioni sono, in questo frangente, acute
e pertinenti. Qualche perplessità suscita invece l’adesione di Mengaldo alla distinzione
che Levi faceva tra il Lager e il Gulag. E qui verrebbe naturale chiedersi tutti quanti,
con molta sincerità e onestà intellettuale, se Levi, morto nel 1987, dunque prima della
caduta del muro di Berlino, avrebbe detto le stesse cose se avesse potuto leggere come
abbiamo potuto leggere noi i libri di Applebaum, per altro largamente utilizzato e
apprezzato dallo stesso Mengaldo. Le nostre attuali conoscenze del Gulag rendono
assai datato quel giudizio che tanto era dispiaciuto a Gustav Herling. Ci sarebbe
insomma da chiedersi se Levi scriverebbe ancora, come scriveva negli anni Settanta e
nei primi anni Ottanta, dei campi sovietici come di luoghi dove la morte “non veniva
espressamente ricercata”, ma “un incidente assai frequente, ma sostanzialmente non
voluto”.
Il grande merito di questo libro consiste nella rivendicazione della letteratura e delle
sue potenzialità.
[…]
Anche se oggi il fenomeno risulta più vistoso, nei tempi in cui la ricezione della
testimonianza era assai ristretta, la questione dei modi della narrazione testimoniale
aveva già impegnato le energie migliori del testimone-superstite. Nulla di più sbagliato
pensare che , fra genocidio e fiction romanesque vi sia un insanabile contrasto,
maliziosamente generato da chi vorrebbe delegittimare Auschwitz e “la cosa in sé”.
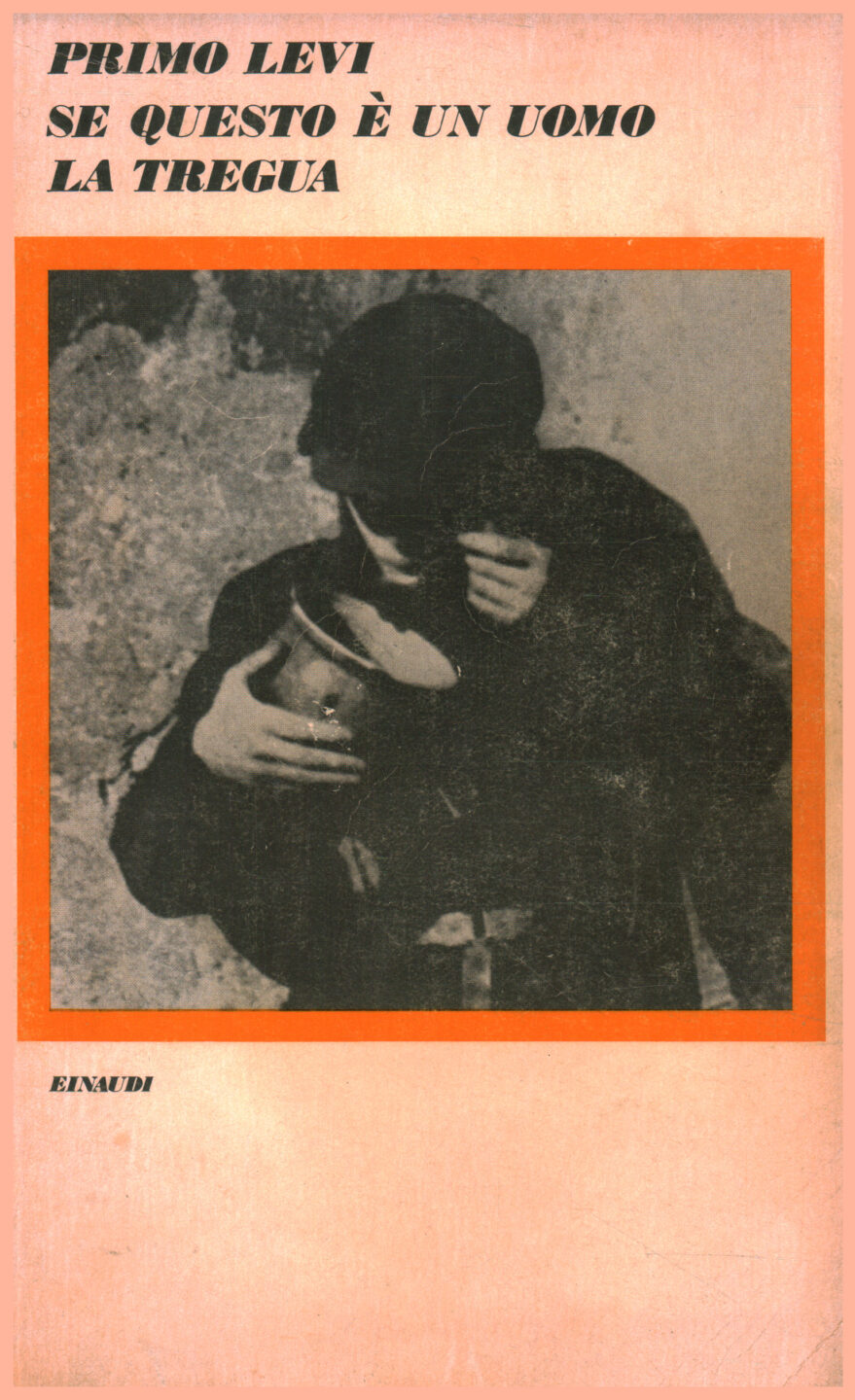 […]
[…]
Per arrivare a questa pacifica dialettica fra ricordo e racconto sono stati necessari
anni. Nello stesso Levi la frattura è molto evidente, quasi esemplare. Se questo è un
uomo è un libro colmo di letteratura, ma si è dovuto attendere il 1985 perché Levi
finalmente lo ammettesse, smentendo la leggenda della spontaneità. Dirà in
un’intervista, una delle ultime: “Le altre persone con le quali ho parlato hanno
accettato la leggenda. In realtà la scrittura non è mai spontanea. Ora che ci penso,
capisco che questo libro è colmo di letteratura, letteratura che ho assorbito attraverso la
pelle anche quando la rifiutavo e la disdegnavo”.
“La concordanza fra i referti della deportazione e la – diciamo – grande letteratura
può essere folgorante”: Mengaldo esordisce così, in apertura del capitolo più bello del
suo libro (il terzo, che s’intitola “Testimonianze e letteratura”, pp. 52 ss.). Pare
insomma evidente a Mengaldo che la scrittura del testimone-superstes non possa
ridursi a mera ricostruzione positivistica del passato. Carlo Ginzburg, in un suo saggio
assai famoso proprio a Levi dedicato, citava qualche tempo fa una pagina molto bella
di Renato Serra: “C’è della gente che s’immagina in buona fede che un documento
possa essere espressione della realtà. […] L’uomo che opera è un fatto. E l’uomo che
racconta è un altro fatto”. L’esperienza del Lager, sembra voler dire Mengaldo, prova
che non necessariamente il racconto “ridotto sotto il concetto generale dell’arte”
finisce preda dello scetticismo.
Proprio l’opera di Levi aumenta i nostri dubbi su una lettura unilaterale della
testimonianza. E’ molto difficile, quando non impossibile, trovare una definizione
univoca di Se questo è un uomo: innanzitutto per il modo come è nato il libro, per i
diversi progetti che lo compongono (il memoriale per la “Minerva Medica”, le
anticipazioni su giornali e riviste, un radiodramma, una versione teatrale, un’edizione
scolastica lievemente tagliata e munita di un auto-commento, una riedizione emendata,
una scia interminabile di glosse, postille, ingrandimenti). Forme altrettanto ibride non
mancano nemmeno in altri tradizioni letterarie: basti pensare al “teatro documentario”
di Peter Weiss e Rolf Hochnuth, alle storie chassidiche di Yaffa Eliah, all’apologo W
où le souvenir d’enfance di Georges Perec nella sua metà autobiografica, alle singolari
prose di Tadeusz Borowski, alle liriche di Paul Celan.
Indagare il lato artistico della testimonianza non ha però soltanto una valenza negativa,
non sfocia necessariamente nella Metahistory di Hayden White. Su questo aspetto del
racconto forse il passo di Mengaldo avrebbe potuto essere più coraggioso. La vera
vendetta, cui s’allude nel titolo, è la letteratura. Per rendere più vera “la cosa in sé”,
per dare autorevolezza al proprio racconto, fin dall’inizio Levi s’è appoggiato ad un
canone letterario composto di affetti sicuri e duraturi: Dante, la Scrittura della Bibbia,
Jack London (Il richiamo della foresta), Pantagruele (Rabelais, Gargantua, II, 9), il
Ricordo della casa dei morti di Dostoevskij, un libro fondamentale per la cultura
ebraico-italiana, in particolar modo a Torino, dove ebbe estimatori illustri (da Leone
Ginzburg a Luigi Pareyson) Ci sono voluti anni perché Levi riconoscesse che Se
questo è un uomo è un libro “colmo di letteratura”, ma questa ammissione è, per noi,
importante. Essa significa che, nella vita del superstite, la letteratura rappresenta la
sola tradizione che può assicurare al testimone un domani.
2. La scrittura come un two-way affair
Ormai sappiamo di essere diretti ad Auschwitz in Polonia. Questo nome non ci dice
nulla, ma noi già sappiamo di essere condannati. Gli altri no: hanno preso con sé
materassi, lenzuola, bauli, valigie, pellicce; hanno anche denari e gioielli, cuciti nei
risvolti dei cappotti, nascosti dappertutto: sono convinti che salveranno se stessi e la
loro roba. Vanda ed io non ci facciamo molte illusioni sul nostro destino; perciò
abbiamo indossato i nostri indumenti più caldi e abbiamo lasciato la maggior parte
del nostro bagaglio a Fossoli, a chi è ancora rimasto in Italia. Luciana Nissim Momigliano, Ricordi della casa dei morti.
Due persone che parlano in una stanza è il titolo del saggio più famoso di Luciana
Nissim Momigliano. Venne presentato al XXXIII Congresso di Psicanalisi di Madrid
(1983) e poi stampato sulla “Rivista di psicoanalisi”[3].
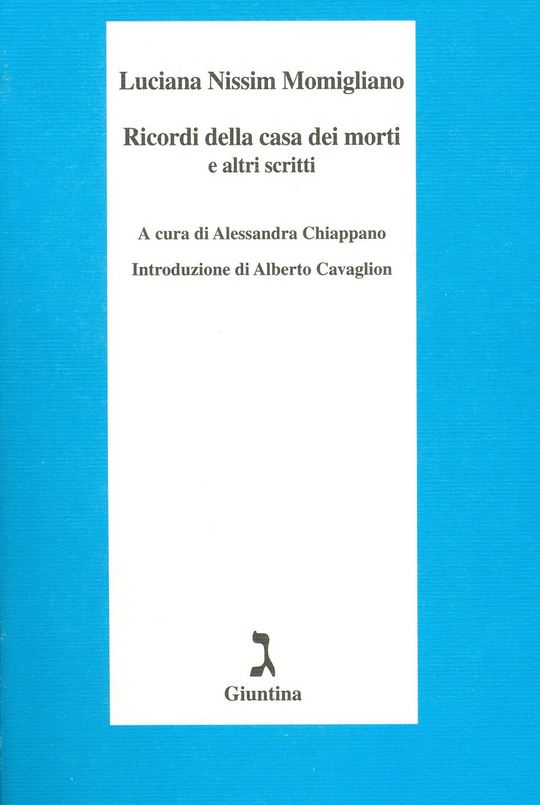
[…] Nient’affatto soggetto alla contingenza il titolo scelto dalla Nissim per una memoria, la
sua, che si guarda bene dal parlare di mostri: Ricordi della casa dei morti – una
sessantina di pagine in tutto – reca nel titolo una evidente allusione al titolo di un
classico libro di Dostoevskij. Questa memoria non ha conosciuto, purtroppo, la
diffusione che merita: oggi un editore coraggioso dovrebbe riprenderla, insieme ad
alcuni scritti sulla psicanalisi e alla bella intervista resa poco prima di morire a
Annamaria Guadagni[4]. Ne verrebbe fuori un interessante volumetto, che metterebbe
in chiaro le due velocità della scrittura della Nissim: precoce, nel caso della
deportazione; ponderata, tardiva, nel caso della psicanalisi.
Le memorie della Nissim in Lager precedono di un anno circa la prima edizione di Se
questo è un uomo di Primo Levi, ma a quel libro sono strettamente collegate, non
foss’altro per il fatto che Levi è un protagonista centrale dei Ricordi. A lui viene messa
in bocca la battuta che segna fin dall’incipit l’intera narrazione: “Questa Germania
deve essere una enorme prigione”.
Dello stesso libro di Dostoevskij, di cui la Nissim parafrasa il titolo, Primo Levi era
stato attento lettore: probabilmente era stata una lettura condivisa fra persone amiche
che parlavano in una stanza a Torino prima che la situazione precipitasse. Molto
probabilmente era stata una lettura comune per molti coetanei di Levi, per la Nissim,
per Wanda Maestro, poi “compagni di viaggio” da Fossoli ad Auschwitz (e non
soltanto per loro)[5].
Ricordi della casa dei morti descrive, nella sua prima parte, la permanenza a Fossoli e
la partenza su quel medesimo convoglio. Per molti versi, rispetto a Se questo è un
uomo, rappresenta la voce del suo deuteragonista femminile. Anche la memoria della
Nissim reca un’epigrafe, però diversa dalla “preghiera” Shemà. E’ la trascrizione di
una canzone tedesca sul campo: “O Auschwitz, ich kann dich nicht vergessen, weil du
mein Schicksal bist…”. O Auschwitz, non posso dimenticarti, perché tu sei il mio
destino.
[…] Però sul viaggio verso i campi e sui condizionamenti della passione, nel capitolo sul
viaggio, quello da Levi descritto nel primo capitolo del suo capolavoro, e nella
descrizione della doppia storia d’amore e di seduzione fra Luciana e Franco Sacerdoti,
da un lato, Primo e Vanda dall’altro, la Angier ha pagine di sicura efficacia, ben
documentate: un approfondimento notevole, per molti versi doloroso da accettare, ma
convincente[6].
[…]
L’intensità di questo rapporto biunivoco fin dalle prime righe richiama
subito il lettore attento e sposta l’attenzione sul coinvolgimento che aveva legati la
doppia coppia di viaggiatori verso la prigionia, Levi e Vanda, Luciana e Franco.
Riprendendo la lezione di Bion, Langs e Rosenfeld, la Nissim afferma che se l’unità
biologica è una coppia, “si può trarne la parafrasi che l’unità analitica è una coppia,
una catena lega strettamente la comunicazione dell’analista a quella del paziente”.
L’analisi si sviluppa come un campo bi-personale, e per questo assomiglia alla
testimonianza dal Lager, che nelle sue forme più alte è quasi sempre un two-way affair.
Tanta importanza ebbe quel saggio sull’analisi come del parlare di qualcosa che è tra
due, che pochi anni dopo, gli allievi migliori della Nissim decisero di intitolare una
miscellanea di studi in suo onore proprio così, alludendo a quell’”affare a due”: In due
dietro il lettino.[7]
Carlo Ginzburg, in un famoso saggio che non casualmente porta una dedica a Primo
Levi, ripercorrendo la storia di una tradizione giuridica, che affonda le radici nella
narrazione biblica, ripresa da Giuseppe Flavio, si è chiesto che cosa potrebbe accadere
se il criterio del doppio testimone venisse applicato alla ricerca storica[8]. Non ha
preso in considerazione l’ipotesi analitica, che, se bene applicata, viene a suffragare il
concetto giuridico.
La sopravvivenza di un individuo è un requisito necessario perché si dia
testimonianza, testimonianza e superstes posseggono la stessa radice semantica: ma
perché due testimoni?
Analogamente a quanto sostiene la Nissim parlando del suo lavoro con i pazienti in
analisi – il paziente è il miglior collega dell’analista, affermazione scandalosa nella sua
provocatorietà -, Ginzburg ritiene che la scelta “si spieghi con il ben noto rifiuto,
presente sia nella tradizione giuridica romana sia in quella ebraica, di riconoscere in
sede di giudizio la validità di un unico teste”. Nel Medioevo l’allusione a Deut. 19, 15
(“Non stabit testis unus contra aliquem”) diventò testis unus, testis nullus, principio
corrente nella letteratura legale.[9]
Quale che sia la spiegazione che si voglia dare alla questione – giuridica o analitica
poco importa – da un mero punto di vista stilistico rimane accertato che la forma
“duale”, in molte testimonianze del Lager, è una cifra ricorrente.
[…]
Il caso più evidente, ma tardivo, riguarda il dibattito sul ruolo dell’”intellettuale” nel
Lager, così come si è sviluppato fra Jean Améry e Primo Levi, da Intellettuale ad
Auschwitz (1966) a I sommersi e i salvati (1986). […]
Qualcuno, riflettendo su questa intertestualità ha proposto inoltre la categoria di
“campo discorsivo” (Lagerdiskurs)[10], che, bisognerebbe aggiungere adesso, si
configura sempre come partecipazione ad una “conversazione a due”, con prospettive
dinamiche.
In altre parole il discorso sul Lager del testimone si legittima, in ogni contesto
nazionale, a partire dal dialogo con l’autore che ha fondato il Lagerdiskurs. E’
accaduto così con Se questo è un uomo di Primo Levi, in Italia; con Nudo tra i lupi di
Bruno Apitz in Germania; con Da noi ad Auschwitz di Tadeusz Borowicz in Polonia;
con La specie umana di Robert Antelme in Francia. L’accento va spostato dunque
dall’autore al suo pubblico, tenendo presente questa congenita vocazione alla
corrispondenza biunivoca.
E’ stato più volte osservato che le testimonianze nascono come prosecuzione di una
narrazione orale. Non potendo essere il lettore comune, che si rifiuta di ascoltare, il
destinatario del racconto è al compagno di prigionia, quello con cui il testimone ha
condiviso il cammino, che viene indirizzata in primo luogo la narrazione. Jean Cayrol,
autore dei bellissimi testi di accompagnamento per Notte e nebbia di Resnais dichiarò
in un’intervista di aver taciuto “perché c’era il libro di Robert Antelme [La specie
umana]”[11]. Fino alla morte di Levi, avvenuta nel 1987, Luciana Nissim dichiarà che
non vi era bisogno di aggiungere nulla: Primo Levi aveva già detto tutto[12].
In Primo Levi la struttura duale del discorso si traduce, da un lato, in una strategia
narrativa, dall’altro in un discorso sulla legittimità della testimonianza, sul suo statuto,
sulla possibilità di avvicinarsi al vero, di attestare “la cosa in sé”.
[…] Il “vero” testimone è il sommerso. Ma il mussulmano, in quanto sommerso,
non può più testimoniare. Non consegue, come pessimisticamente e, quasi,
nichilisticamente, ha concluso Agamben, che nessuna testimonianza sia possibile, ma
certo la legittimazione del superstes esce indebolita da questa disperata confessione in
limine mortis[13].
Sono temi discussi che richiedono delicatezza d’indagine, ma che posseggono una
lunga tradizione fra gli storici della filosofia e dell’età antica e a quella tradizione di
pensiero bisognerà ritornare, per sottrarre ogni nostra “conversazione sul Lager” al
rischio dell’autoreferenzialità […] Proprio uno studioso ebreo piemontese come Levi, Arnaldo Momigliano, ha scritto, nel suo classico studio sullo sviluppo della biografia greca, che il marchio dell’autenticità della famosa VII epistola autobiografica di Platone consiste nel suo essere nonplatonica [14]. Di qui l’importanza e la sorpresa che spesso assumono i nostri pensieri
sui filosofi vecchi, sulla discontinuità dei loro ultimi discorsi, rispetto ai primi suoni di
una voce che avevamo conosciuto diversa. I sommersi e i salvati sono un libro leviano
proprio perché antitetico rispetto alla definizione di testimone-superstes che troviamo
in Se questo è un uomo.
In Se questo è un uomo, l’autorevolezza del testimone-superstes è data dalla pluralità
di voci che fungono da soggetto, non solo verbale[15]. In Se questo è un uomo si
alternano quattro spostamenti visuali:
1) la prima persona plurale di valore collettivo (“la Buna in cui soffrimmo e morimmo
innumerevoli”).
2) la seconda persona rivolta a “un se stesso generalizzato” (“piove e tira vento: ma sai
che stasera tocca a te il supplemento di zuppa”).
3) la terza persona descrittiva e apparentemente neutrale, che però può essere trapunta
sia da considerazioni morali, sia da appelli al lettore (“Ma consideri ognuno, quanto
valore, quanto significato è racchiuso”, “Si immagini ora un uomo a cui…”).
4) l’io giudicante (“e sarebbe assai stupito, l’innocente bruto Alex, se qualcuno gli
dicesse che alla stregua di questo suo atto io oggi lo giudico …”), “lo sguardo giudice”.
Ad un’analisi più minuziosa altri punti visuali, altrettanto cruciali, risultano presenti:
innanzitutto “la voce di Dio”, l’io che parla nella poesia in epigrafe; in modo
altrettanto chiaro è rilevante la forma duale, che è una reminiscenza grammaticale
classica. Il ricordo della lingua greca viene in soccorso nel momento in cui si esplora
la possibilità di una forma intermedia fra l’io, il noi e il “si” impersonale. Un diverso
soggetto può fungere da arbitro fra l’io giudice, il noi collettivo e l’asettica terza
persona.
Poiché Levi è pienamente consapevole che testis unus, testis nullus succede che nel
libro si faccia un uso assai frequente della forma duale. L’inserzione del secondo
testimone avviene, di norma, tramite la congiunzione “ed” (“ed io”), che serve a
ridimensionare ogni eccesso di soggettività: “Alberto ed io”. Il capitolo L’ultimo
inizia così: “Ormai Natale è vicino. Alberto ed io camminiamo spalla contro spalla
nella lunga schiera grigia, curvi in avanti per resistere meglio al vento”. E ancora, nel
paragrafo successivo: “Da quando io sono in Laboratorio, Alberto ed io lavoriamo
separati, e, nella marcia di ritorno, abbiamo sempre molte cose da dirci”. Poi il
capitolo si chiude così: “Alberto ed io siamo rientrati in baracca, e non abbiamo potuto
guardarci in viso”. Il duale fa la sua parte anche con personaggi minori e sempre con la
medesima immagine dello sguardo tacito: “Walter e io abbiamo evitato di guardarci e
siamo rimasti a lungo silenziosi”[16].
“Spalla contro spalla” è la trasposizione fisica della congiunzione “ed”. E’ la tipica
postura di Levi testimone e del suo deutero-testimone. In due la prospettiva del futuro
appare più nitida: “Da molto tempo Alberto ed io avevamo previsto i pericoli che
avrebbero accompagnato il momento dell’evacuazione e della liberazione”[17] La
ritroviamo con frequenza quasi ossessiva: spalla contro spalla i due testimoni, secondo
Levi, non possono guardarsi in viso o tacciono. Il duale si trova in forma di soggetto,
ma anche declinato, in forma di aggettivo o di pronome, soprattutto nel caso di
Alberto: “E non vorrei peccare di immodestia aggiungendo che è stata nostra, di
Alberto e mia, l’idea di rubare i rotoli di carta millimetrata”[18]. Solo con Lorenzo
avviene il capovolgimento e il secondo testimone passa dietro: “Ora, tra me e Lorenzo
non avvenne nulla di tutto questo”.[19]
Le azioni sono iterate, con curiosi parallelismi: “Clausner mi mostra il fondo della sua
gamella. Là dove altri incidono il loro nome, e Alberto ed io abbiamo inciso il nostro
nome, Clausner ha scritto ‘Ne pas chercher à comprendre’”[20]. Nell’ultimo capitolo
Storia degli ultimi dieci giorni, Charles subentra ad Alberto: “Charles ed io trovammo
finalmente quanto cercavamo”; “Charles ed io ci dividemmo i vari servizi
all’esterno”; “Charles ed io partimmo nuovamente in perlustrazione per il campo in
sfacelo”; “Charles ed io quel mattino fummo coraggiosi”.[21]
La funzione grammaticale non è che una trasposizione dal piano della vita del
testimone a quello dell’espressione. Più di Alberto, più di Lorenzo, il testimonesuperstite
che assolve meglio questo ruolo di appoggio nella quotidianità dell’esistenza
è Leonardo Debenedetti (1898-1983), assai più di un amico fraterno.
Leonardo è il superstes per antonomasia, con cui Levi corre avanti “spalla contro
spalla” per resistere meglio al vento. Nella scrittura e nella vita, direbbe Semprun. E’ il
medico di famiglia, l’amico fraterno, che accompagna Levi per tutto il viaggio di
ritorno descritto ne La tregua e non lo abbandonerà per il resto della vita. C’è chi ha
sostenuto, non a torto, che il declino dell’ultimo Levi sia conseguente alla morte di
Leonardo[22]. E’ “l’uomo buono”, cui Levi dedica un intenso articolo in occasione
della morte: uno dei pochissimi necrologi che abbia scritto. Parlando di Leonardo,
senza nominarlo, viene ripristinata la formula classica che avvalora la testimonianza:
“Leonardo ed io”. Leonardo è “il medico senza medicine”, che ha aiutato un migliaio
di persone “sulla dubbia via di ritorno dall’esilio”[23].
Era entrato in scena nell’epopea della Tregua, con la consueta forma binaria:
“Leonardo ed io in un silenzio gremito di memoria”[24]. A quattro mani con lui, nel
1946, sulla rivista “Minerva Medica”, Primo Levi scrive e pubblica la sua prima
testimonianza su Auschwitz: il Rapporto sulla organizzazione igienico-sanitaria del
campo di concentramento per Ebrei di Monowitz (Auschwitz-Alta Slesia), che può ben
dirsi un avantesto di Se questo è un uomo e, contemporaneamente, la più considerevole
messa in pratica del principio antico: “Non stabit testis unus contra aliquem”[25].
“Eravamo partiti”, scrivono Levi e Debenedetti, “dal campo di concentramento di
Fossoli di Carpi (Modena) il 22 febbraio 1944, con un convoglio di 650 Ebrei di ambo
i sessi e di ogni età. Il più vecchio oltrepassava gli 80 anni, il più giovane era un
lattante di tre mesi. Molti erano ammalati, e alcuni in forma grave: un vecchio,
settantenne, che era stato colpito da emorragia cerebrale pochi giorni prima della
partenza, fu egualmente caricato sul treno e morì durante il viaggio”.[26]
La forma duale “Vanda ed io” attraversa i Ricordi della casa dei morti di Luciana
Nissim Momigliano, fin dalle prime righe: “Vanda ed io diciamo: Se solo questo
viaggio non finisse mai!”. La forma scelta è una forma di plurale che sconfina nel
duale fino a confondersi. Per esempio: “Ci assegnano un posto, in mezzo a persone
estranee, ma io sono con Vanda. Ci guardiamo attorno spaurite, disperate; non capiamo
nulla”. E ancora: “Io e Vanda parliamo poco l’una con l’altra. Una parola ci basta per
rievocare lunghe storie – abbiamo talmente tanta vita in comune! Studi, libri – e i
bombardamenti, i coraggiosi ragazzi della banda, la prigione di Aosta, Fossoli…
Ricordi di lunghe chiacchierate, ricordi di persone care, lontane parole
d’amore…”.[27]
3. “A Remnant shall return”
Di solito ogni tentativo di rappresentare letterariamente la Shoah, così come accade ai
nostri giorni, mette l’accento sul ricordo “nonostante tutto”, sul ricordo che trionfa sul
massacro. Solo nell’ultimo decennio la perlustrazione di nuove strade della narrazione
si è allargata verso diversi orizzonti e verso altri generi[28].
Non è stato sempre così. C’è stato un tempo in cui il discorso era rovesciato.
All’inizio, in quello che potremmo definire il buon tempo antico della testimonianza,
nella preistoria dell’”era del testimone”, il superstes coltivava un sogno virtuoso:
restituire a chi è oggettivamente un privilegiato (in quanto sopravvissuto allo
sterminio, ma anche all’ascoltatore che si rifiutava di sapere), non il misticismo
trionfalistico della memoria, ma un’idea salvifica di testimonianza. Questo è un
fenomeno che unisce altre testimonianze, assai remote rispetto all’orizzonte di Levi.
[…]
Il vocabolo inglese Remnant, sopravvissuto, è il termine che traduce Isaia 10,21 (“A
Remnant shall return”). Nelle traduzioni italiani correnti il vocabolo è reso quasi
sempre con “residuo”, vocabolo assai più nobile e ambivalente di “reduce”. Il versetto
è stato al centro negli anni Cinquanta di una serrata discussione: se ne scorgono echi in
altre pagine della “conversazione sul Lager”, da parte di chi si è confrontato con il
tema del rapporto fra testimonianza e silenzio di Dio.
La questione ha avuto un grande rilievo soprattutto negli Stati Uniti, dove negli anni
Cinquanta il tema dei Saving Remnants (i superstiti “che salvano”) hanno reso
possibile una discussione, di cui in Europa non si è avuta piena coscienza, forse perché
il nostro Lagerdiskurs è stato quasi interamente occupato da testimoni sostanzialmente
agnostici: illuministi raziocinanti, uomini di scienza, liberi pensatori come Levi o
intellettuali umanisti come Améry o Semprun, scrittori eclettici e asistematici come
Georges Perec. La questione va ben al di là dell’anatomia del testimone, singolo o
duale che egli sia.[29]
Del resto, al di fuori della meditazione religiosa, il sopravvissuto “che salva” diventa
un personaggio chiave anche nella memorialistica e nella letteratura d’invenzione. In
letteratura, fra le opere sul Lager che hanno squarciato il velo fra realtà e finzione, il
primo personaggio ad entrare in scena non sarà il prigioniero che descrive la prigionia
o lo sterminio, ma il Remnant che ritorna: figura meno impegnativa a descriversi,
rispetto al “mussulmano” senza volto.
Talora accade un fenomeno curioso: che il superstite è esso stesso uno scrittore, il
quale a sua volta entra come personaggio in una narrazione altrui, per effetto di una
sorta di contiguità, di consanguineità della scrittura. E’ il caso di Bruno Schulz
nell’opera e nella riflessione teorica di David Grossmann.
Si tratta per lo più di un superstes nel senso letterale del termine: un uomo, o una
donna, dati per scomparsi, che riemergono dal nulla e ritornano a casa quando tutti li
credono inghiottiti nel nulla. In questo senso va letto un brano di Elie Wiesel, che
descrive se stesso nella celebre sequenza conclusiva de La nuit: “Un jour je pus me
lever, après avoir rassemblé toutes mes forces. Je voulais me voir dans le miroir qui
était suspendu au mur d’en face. Je ne m’étais plus vu depuis le ghetto. Du fond du
miroir, un cadavre me contemplait. Son regard dans mes yeux ne me quitte plus”[30].
Anche nel finale de La tregua il personaggio che ci viene incontro è un Remnant che
ritorna, sebbene esonerato da ogni riferimento al luogo biblico. La riapparizione può
avvenire in sogno, in Levi così accade, anche in Se questo è un uomo, o mediante
racconti allegorici, come succede in alcuni fra i migliori racconti del periodo
americano di Isaac B. Singer.
Il personaggio del “Saving Remnant” è dominante in un romanzo come Enemies, in
racconti come Un matrimonio a Brownsville e, soprattutto, nelle straordinarie short
stories (in particolare una, intitolata per l’appunto Remnants, dove l’eco della
discussione teorica statunitense è palese, quasi una applicazione pratica, un commento
che attualizza il dettato biblico).
Nell’immediato dopoguerra i sopravvissuti, una volta arrivati in America, avevano mal
sopportato il realismo spietato con cui venivano definiti dalla stampa jiddish:
katsenikes, vale a dire prigionieri dei KZ (Konzentrationslager); ma anche si
rifiutavano di essere semplicemente etichettati con l’eufemismo del “displaced
person”.
Il protagonista di Un matrimonio a Brownsville, Salomon Margolin ha una specie di
allucinazione: a un banchetto di nozze rivede i luoghi del passato, della sua infanzia,
del suo primo amore, rivede una donna che assomiglia a Raizel, la ragazza da lui
amata, che credeva fosse stata uccisa ad Auschwitz e invece riappare, nella notte più
bella, nei panni della Saving Remnant (“come se fosse arrivato il Messia, come se
fossero resuscitati i morti”)[31]. Margolin tace, il suo silenzio sembrerebbe non avere
un perché, come la domanda di Primo Levi.
Warum? La spiegazione del silenzio è nel finale del racconto Sopravvissuti
(Remnants), là dove Singer prende la parola per rispondere, a modo suo, al paradosso
di Adorno sull’impossibilità dello scrivere poesie e alla imbarazzante, ma ingenua
domanda dello scrittore torinese: “Dopo Treblinka non si possono più fare
domande” [32].
D’altra parte, un’altra negazione altrettanto esplicita viene attribuita al massimo
storico della Shoah, Raul Hilberg, per il quale le note a pié di pagina degli storici,
dopo Auschwitz, sarebbero una barbarie (“If poetry after Auschwitz was barbarism,
what on earth could be said about footnotes?”) [33].
Converrà adesso prendere in considerazione alcun esempi concreti.

4. Un modello di scrittura: Filippo Tuena e la categoria di “variazione”
Le variazioni Reinach è un libro assai originale [34]. Racconta di due giovani vittime della
Shoah in Francia, appartenenti a due famiglie dell’alta società parigina, celebri per le
donazioni che hanno reso possibile la creazione di due meravigliose case-museo,
ammirate oggi da migliaia di turisti di tutto il mondo: il Museo Nissim de Camondo a
Parigi, rue de Monceau, la Villa Kérilos a Beaulieu. […] il rilievo che il romanziere francese avrebbe potuto offrire intorno ad una possibile soluzione del problema dello “scrivere sulla Shoah” avrebbe potuto essere maggiore se Tuena non si fosse stato prendere la mano dall’estetismo. E’ un’osservazione che non vuole suonare severa, per un romanzo di notevole significato, anzi, fra i pochi consigliabili in Italia per chi voglia affrontare il tema assai arduo della letteratura su Auschwitz. Senza scorciatoie né facili banalizzazioni Tuena si pone in Italia lungo la scia di precedenti
illustri, ma isolati e scrittori solitari, come Affinati o Zargani.

5. Il diario di Hélène Berr
“Niente diventa reale se prima non si è sperimentato, neppure un proverbio è un
proverbio se la vita non te ne ha dato un esempio”. Questa frase di John Keats,
citata da Hèlène Berr nella pagina del suo diario scritta il 1° novembre 1944,
vale come un’epigrafe.
Capita ormai molto raramente di esprimere meraviglia, incantamento di fronte
ad un libro sullo sterminio degli ebrei d’Europa. […]
L’autrice, di due anni più giovane di Primo Levi, essendo nata nel 1921, inizia a
scrivere nel 1942. Il diario ha un doppio ritmo interno: la prima parte è un
journal intime tradizionale, che s’apre con l’ingenua trepidazione di
un’adolescente cui Paul Valéry una mattina di sole aveva lasciato in dono un suo
libro con dedica nient’affatto presaga di quanto stesse per accadere (“Al
risveglio, così dolce la luce e così bello quest’azzurro vivo”). Valéry non poteva
prevalere. La morsa delle persecuzioni si fa ogni ora più stretta, parenti e amici
di Hélène sono arrestati e rinchiusi a Drancy: accade così che la velocità della
scrittura si faccia mano a mano che si procede più incalzante. All’elegia della
Parigi primaverile, con l’idillio dei suoi parchi, subentra la città nevroticamente
attraversata dai carri armati, dai tedeschi che irrompono alla Sorbona, dal
soccorso recato ai bambini rimasti orfani. Hélène si prodiga per questi ultimi,
ma capisce che di fronte all’abominio la sola difesa può venire dalla cittadella, in
breve dall’isolamento libresco. Questo diario diventa così un parco interiore di
citazioni, finemente ricostruite in una appendice bibliografica dai curatori.
[…]
Il diario di Hélène rappresenta una delle testimonianze più alte del binomio
ebraismo –europeità, sul quale tanto insiste George Steiner. Negli anni Trenta,
Parigi rappresenta per l’ebraismo europeo un crogiuolo complementare e
simmetrico alla Vienna d’inizio Novecento. Qui l’identità ebraica si conforma
seguendo la linea che Hélène riassume così bene: “Quando scrivo ebreo non
traduco il mio pensiero, infatti per me una simile definizione non esiste, non mi
sento diversa dagli altri uomini, non riuscirò a considerarmi parte di un gruppo
umano separato, forse è per questo che soffro tanto, perché non capisco più”.
Nella Parigi occupata dai nazisti il sogno di molti coetanei di Hélène svanisce
nel momento in cui si è costretti ad ammettere di non sapere perché si è
perseguitati: “Soffro nel vedere la cattiveria umana, soffro nel vedere il male
abbattersi sull’umanità, ma dato che non mi sento di far parte di nessun gruppo
razziale, religioso, umano per sostenermi ho solo i miei conflitti e le mie
reazioni, la mia coscienza personale”.
[…]
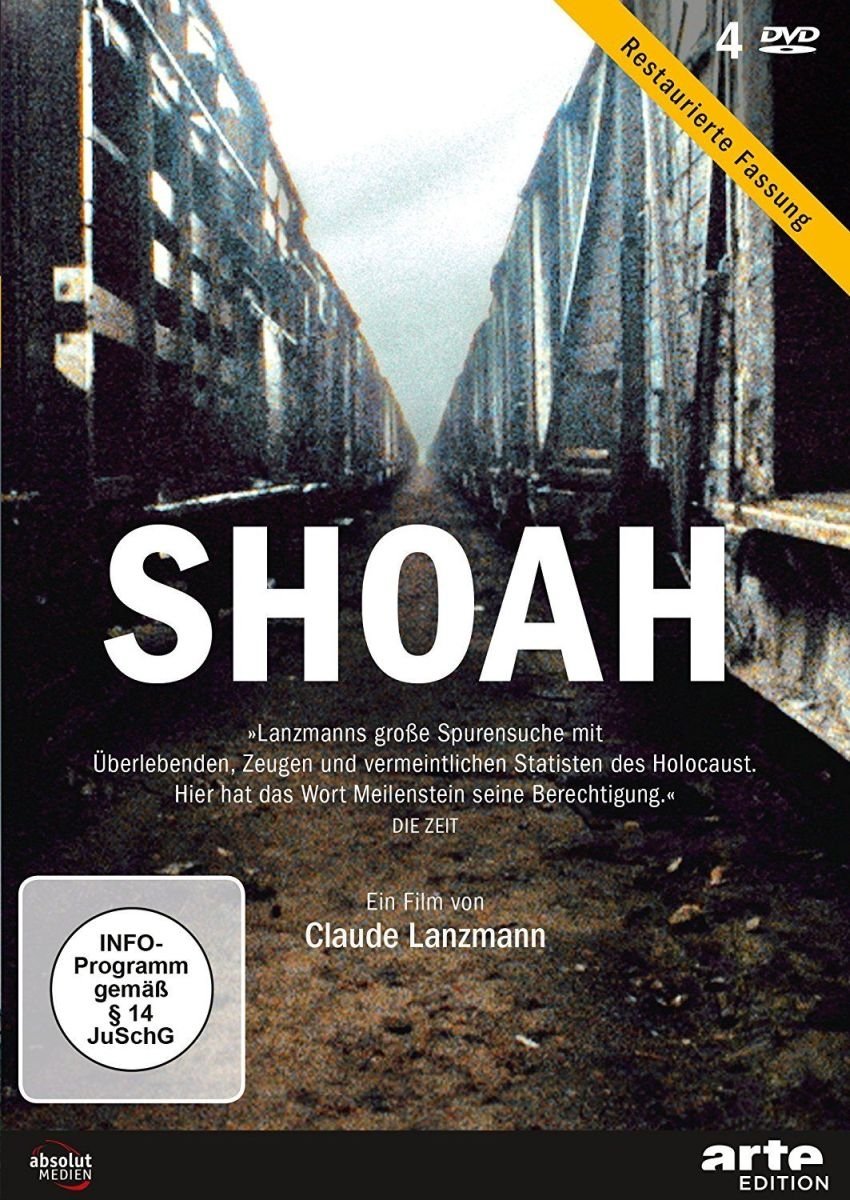 6. Claude Lanzmann: Shoah
6. Claude Lanzmann: Shoah
Il racconto del testimone dovrebbe essere restituito così com’è, senza essere
“artisticamente ritoccato”, scriveva Primo Levi in una sua dimenticata pagina,
scritta poco prima di morire. Le immagini “sono il migliore esperanto”: un
concetto nuovo, rimasto purtroppo incompiuto. […]
Lo scrittore torinese non fece in tempo a parlare di Shoah di Claude Lanzmann,
per quanto il film fosse uscito due anni prima della sua morte, né ebbe modo di
sviluppare un concetto diventato per noi assillante, non solo in Italia. Il
problema della conservazione dei ricordi o come più comunemente si dice, la
politica della memoria. Esposizioni, musei, memoriali, ma soprattutto testi di
letteratura, pellicole cinematografiche. Levi si scagliò, molti lo ricorderanno,
contro Portiere di notte di Liliana Cavani […]
L’arte della fotografia, dice sempre Levi, poiché possiede un valore aggiunto,
potrebbe forse spiegare le singolarità della storia dei luoghi, di certi luoghi
diventati non-luoghi: “la fantasia teatrale e maligna” – ad esempio – in virtù
della quale un impianto per il trattamento industriale del riso come la Risiera di
San Sabba ha potuto essere convertito, in una città-emporio, in cui buona parte
del cereale veniva importato dall’estremo oriente, in “una fabbrica di tortura”. Il
caso-Lanzmann dimostra come il cinema possa dare di più della fotografia.
Se la fotografia riesca a rendere “buona” la ricezione di un messaggio per
definizione “cattivo” – oppure, come altri sostengono, se non vi sia nulla da fare
e la verità non possa esprimersi in altro modo che con il silenzio – è questione
aperta e certamente per poterla affrontare con cognizione di causa non si può
prescindere dal capolavoro di Lanzmann.
Come osserva Sessi nella prefazione, Shoah pone inoltre un secondo problema,
non meno cruciale di quello della liceità dell’immagine filmica: la comprensione
dall’interno dell’esperienza dell’annientamento. Anche per questo nodo
complicato la comparazione con l’ultimo Levi, con il Levi dei Sommersi e i
salvati è d’obbligo. Il Levi , s’intende, ultimo ed estremo, quello del periodo
1984-1987, che, a dispetto di tanti luoghi comuni, è ben altra cosa rispetto al
Levi speranzoso dell’esordio di quarant’anni prima.
Dal medesimo principio, secondo cui nel Lager sarebbero periti i migliori – e
nella non meno pessimistica clausola accessoria, espressa nei Sommersi e i
salvati, secondo cui gli unici capaci di dare testimonianza completa sarebbero
coloro che sono stati inghiottiti nel nulla – parte anche Lanzmann, che però non
ha trovato, per sua fortuna, sulla sua strada un Agamben pronto a trarre da quella
premessa rapide conclusioni di tipo nichilistico. Eppure i Sommersi e i salvati
potrebbero ben dirsi, come scrive lo stesso Lanzmann della sua opera, un libro
“sulla radicalità della morte e non sui sopravvissuti”.
[1] Pier Vincenzo Mengaldo, La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla Shoah, Torino, Bollati Boringhieri, 2007
[2] P. Levi, Conversazioni e interviste 1963-1987, a c. di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, pp. 65-66.
[3] L. Nissim Momigliano, Due persone che parlano in una stanza. Una ricerca sul dialogo analitico, in “Rivista di psicoanalisi”, XXX, 1, gennaio-marzo 1984, pp. 1-17.
[4] Luciana Nissim. La memoria del bene, in “Diario”, II, 8, 26 febbraio 1997, pp. 14-21.
[5] Per lo specifico rapporto fra Primo Levi e “la casa dei morti” di Dostoevskij e più in generale per la fortuna di questo libro in area ebraico torinese rinvio al saggio “Sulla soglia della casa dei morti” pubblicato nel mio libro Il senso dell’arca. Ebrei senza saperlo, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2006, pp. 75 ss.
[6] C. Angier, Il doppio legame. Vita di P. Levi, Milano, Mondadori, 2004, pp. 274-275.
[7] In due dietro il lettino. Scritti in onore di Luciana Nissim Momigliano, a c. di Gabriella Bartoli, Castrovillari (CS), Ed. Teti, 1990.
[8] C. Ginzburg, Unus testis. Lo sterminio degli ebrei e il principio di realtà, in “Quaderni storici”, n. serie 80, 2, agosto 1992, pp. 529-548 da cui si cita. In una prima versione il saggio era già apparso in inglese, in un volume contenente molti contributi di grande interesse: Probing the Limits of Representation: Nazism and the “Final Solution”, ed. Saul Friedländer, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1992. Ora il saggio è confluito nel volume C. Ginzburg, Il vero Milano, Feltrinelli, 2006.
[9] C. Ginzburg, Unus testis cit., p. 532.
[10] T. Taterka, Lagertexte, Lagerliteratur, Lagerdiskurs: problemi teorici e metodologici, in M. Bandella (a cura di), Raccontare il Lager. Deportazione e discorso autobiografico, Frankfurt am Maim, Peter Lang, 2005, pp. 19-28.
[11] Intervista citata da J. Klein, Darstellungen der nazionalsozialistischen Massenvernichtung in der französischen Literatur, Wien, Böhlau, 1992, p. 54.
[12] A. Guadagni, La memoria del bene. Luciana Nissim cit., p. 19; L. Rolfi, L’esile filo della memoria, Torino, Einaudi, 1998.
[13] G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 31. Contro queste tesi di Agamben si sono espressi soprattutto C. Cahan-P. Mesnard, G. Agamben à l’épreuve d’Auschwitz, Paris, Kimé, 2001; E. Traverso, Auschwitz e gli intellettuali, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 185-186.
[14] A.Momigliano, Lo sviluppo della biografia greca, Torino, Einaudi, 1974, p. 64. Applica queste considerazioni alle stesse discontinuità presenti nella biografia di Momigliano, rispetto alla sua identità di ebreo e per i suoi studi sul concetto classico di “persona”, Margherita Isnardi Parente (A. Momigliano, la VII epistola platonica e l’autobiografia, in I miei maestri, Napoli-Bologna, Istituto italiano per gli studi storici- Il Mulino, 2004, pp. 107 e ss.).
[15] C.Segre, Lettura di “Se questo è un uomo”, in P.Levi un’antologia della critica, a c. di E. Ferrero, Torino, Einaudi, 1997, pp. 59, 68-69.
[16] P. Levi, Se questo è un uomo in Opere, a c. di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, vol. I, pp. 47, 141, 146. Qui e nelle citazioni seguenti i corsivi, naturalmente, sono miei.
[17] Opere cit., vol. I, p. 140.
[18] Opere cit., vol. I, p. 82.
[19] Opere cit., vol. I, p. 117.
[20] Opere cit., vol. I, p. 99.
[21] Opere cit., vol. I, pp. 157-157, 161.
[22] F. Maruffi, Testimonianza, in P. Levi. Il presente del passato, a c. di A. Cavaglion, Milano, F. Angeli, 1991, pp. 217 e 220.
[23] P. Levi, Ricordo di un uomo buono, in “La Stampa”, 21 ottobre 1983 ora in Opere cit., vol. II, pp. 1194-1197.
[24] P. Levi, Opere cit., vol. I, p. 394.
[25] P. Levi – L. Debenedetti, Rapporto sulla organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz (Auschwitz-Alta Slesia), in “Minerva Medica”, XXXVII, luglio-dicembre 1946, pp. 535-544 ristampato in Il ritorno dai Lager, a c. di A. Cavaglion, Milano, F. Angeli, 1994, pp. 221-240 ora in Opere cit., vol. I, pp. 1339-1360. Questa fonte, a lungo dimenticata, di Se questo è un uomo ha suscitato in questi ultimi anni una crescente
attenzione da parte degli studiosi dell’opera di Levi. Si veda innanzitutto la traduzione francese, con l’apparato critico e l’introduzione di Philippe Mesnard (P. Levi, Rapport sur Auschwitz, Paris, Kimé, 2005); un’edizione americana, a cura di Robert Gordon, è appena uscita Auschwitz Report, New York, Vento, 2006. Alcuni brani di una importante testimonianza di Leonardo Debenedetti sono riprodotti nell’antologia La vita offesa, a c. di A. Bravo-D. Jalla, Milano, F.
Angeli, 1986, passim (la versione integrale di questa intervista è conservata presso l’Archivio dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, Archivio della Deportazione ANED Torino, fasc. Leonardo Debenedetti). Dopo l’edizione del Rapporto acute osservazioni sono state svolte da J. Kelly, P. Levi. Recording and Reconstruction in the Testimonial Literature, Troubadour, Market Harborough, 2000, pp. 29-51;
D. Amsallem, P. Levi au miroir de son oeuvre. Le témoin, l’écrivain, le chimiste, Lyon, Editions de Cosmogonie, 2001, pp. 27-30 ; W. Geerts, P. Levi e i due testi del testimone, in M. Bandella (a cura di), Raccontare il Lager. Deportazione e discorso autobiografico cit., pp. 43-51.
[26] P. Levi- L.Debenedetti, Rapporto … in Opere cit., vol. I, p. 1339.
[27] L. Nissim, Ricordi cit., pp. 22, 31, 35 i corsivi sono miei. E a p. 23: “Una SS si avvicina di nuovo a noi: ci guarda bene, per fare una scelta fra noi donne; una la manda a destra, una a sinistra. Mette anche Vanda e me nel gruppo di sinistra, che è molto più esiguo dell’altro. Noi andremo a piedi…”.
[28] Penso per es. agli studi di una eccellente studiosa israeliana, di cui va almeno segnalato il contributo: Judith Kauffmann, Horrible, humour noir, rire blanc. Quelques réflexions sur la répresentation littèraire de la Shoa, in “Humoresque », 14, 2001, pp. 207-224.
[29] Un’ampia sintesi di questa discussione si legga in L. S. Dawidowicz, Saving Remnants, in From the Place and Time. A Memoir 1938-1947, New York, Bantam Books, 1991, pp. 299 ss.
[30] E. Wiesel, La nuit, Paris, Les Éditions de Minuit, 1958, p. 178.
[31] I. B. Singer, Racconti, a c. di A. Cavaglion, Milano, Meridiani Mondadori, 1998, p. 591.
[32] I. B. Singer, Racconti cit., p. 1455
[33] L’episodio è raccontato da Doris L. Bergen, The Barbarity of Footnotes: History and the Holocaust, in Teaching the Representation of the Holocaust, ed. by M. Hirsch and Irene Kacandes, New York, The Modern Language Association of America, 2004, p. 37.
[34] F. Tuena, , Le variazioni Reinach, Milano, Rizzoli, 2005.
Alberto Cavaglion, Il futuro della memoria: cinema e letteratura in AA.VV., Capire gli stermini. Per una didattica della Shoah, Dispense, Summer School per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana, Pisa, 29 agosto – 3 settembre 2010, Regione Toscana