
Mio fratello era [n.d.r.: testimonianza di Paola Del Din – vedere in calce a questo articolo – ] ufficiale di carriera ed era stato assegnato al battaglione Gemona, dove poté stare solo un mese e mezzo o due perché poi ci fu l’8 settembre.
Subito dopo quella data riuscì a mantenere i contatti con i suoi ex commilitoni ed insieme decisero di dar vita ad un gruppo partigiano che non fosse legato al partito comunista, ma unicamente rivolto alla salvezza della Patria. Questa esigenza era sentita oltre che da lui, anche da tanti altri giovani, ufficiali e semplici cittadini, che si erano trovati in una situazione precaria con l’armistizio. Fu così che mio fratello Renato, Tacoli Federico e suo fratello, Marzona ed altri, diedero vita ad uno di quei gruppi che poi si unirono e divennero, per volere di Monsignor Moretti, la Osoppo.
I componenti di questo piccolo manipolo di uomini avevano alle spalle quasi sempre una famiglia, sorelle o fidanzate o madri che cercarono in tutti i modi di dar loro una mano. Chi portava i messaggi, chi nascondeva in casa armi o carte compromettenti, chi semplicemente offriva la propria casa per le riunioni, chi preparava loro le vettovaglie da portare in montagna: questo aiuto significava la partecipazione della popolazione.
Tutto ciò era ovviamente molto pericoloso perché i fiancheggiatori dei partigiani, se scoperti, venivano sicuramente incarcerati e anche spediti nei campi di concentramento in Germania.
Anch’io, ovviamente, sentii il dovere di aiutare mio fratello, anche perché ritenevo che la sua causa fosse giusta e che fosse necessario combattere contro i tedeschi e i fascisti per portare l’Italia fuori dal baratro nel quale era precipitata. Il primo problema, quindi, era quello di andare in giro a raccogliere armi.
I giovani che scappavano dalle caserme non potevano portarsi dietro le armi di ordinanza, anzi era meglio che se ne disfacessero, che cercassero abiti borghesi, un mezzo di trasporto per allontanarsi dalla caserma e mezzi di fortuna per raggiungere le loro case senza essere catturati dai tedeschi.
Nella seconda metà del mese di settembre 1943 provvidi personalmente al recupero di piccole quantità di armi e materiale militare depositato presso famiglie di contadini nella zona tra Udine e Qualso, su indicazioni e disposizioni datemi da mio fratello e dai suoi colleghi di battaglione.
Fidandomi del fatto che assomigliavo di viso a Renato e che ero abituata ad andare in giro in bicicletta anche per lunghi tratti ed a portare pesi sul manubrio, perché andavo sempre al mulino a far macinare il granoturco che ci veniva da un terreno di mio padre, potevo andare nel posto designato e ritirare le armi. Nascosi le armi (alcune rivoltelle Beretta cal.9 con relative munizioni, una decina di bombe a mano ed altro materiale) a casa mia; più tardi le portai in parte a Savorgnano al Torre, perchè fossero consegnate a mio fratello, che si trovava allora in quella zona e in parte ai punti di raccolta in città.
Le prime riunioni avvenivano a casa nostra che era in via Vittorio Veneto al terzo piano, mentre al secondo c’era un dentista che era stato obbligato a lavorare per i tedeschi. Ciò per noi era una sicurezza più che un pericolo, intanto perché il fatto che ci fosse un viavai continuo di tedeschi e borghesi non poteva destare sospetto e poi perchè nessuno avrebbe mai pensato che si potessero fare delle riunioni clandestine esattamente sopra la testa dei tedeschi stessi. Si fecero così a casa nostra molte riunioni, in seguito le stesse vennero trasferite nella cupola del Tempio Ossario, perché lì c’era la possibilità di sfuggire in caso di pericolo ed avere una visuale migliore di ciò che succedeva in giro.
Da lì in poi è iniziata tutta la mia partecipazione alla Resistenza, perché se c’era necessità di recapitare un biglietto o fare una consegna o ritirare un pacco, partivo con la bicicletta e facevo tutto ciò che mi chiedevano di fare.
Verso la fine dell’inverno i vari gruppi di resistenti che si erano unificati sotto il nome di “Osoppo” andarono in montagna fissando il comando nel castello di Pielungo.
Si rendeva necessario far conoscere l’esistenza della formazione osovana e dei suoi principi e ideali. Questa è la ragione della rischiosa azione di Tolmezzo, che ebbe però grande risonanza in tuta la Carnia.
Il 25 aprile 1944 mio fratello cadde in combattimento a Tolmezzo, ma nessuno ci avvisò di ciò; l’unica cosa che ci dissero fu di andare via per un po’ di tempo da Udine perché io e la mamma eravamo ricercate. Andammo via così circa una quindicina di giorni: la mamma da una sua parente ed io a fare esami all’ università a Padova. Quando ritornammo a casa ci accorgemmo che si era formato il vuoto intorno a noi. Io avevo sentito delle mezze voci o delle mezze parole che potevano farci intuire che era successo qualcosa di grave a mio fratello, ma in realtà non ci pensavamo per due motivi: primo perché Renato aveva scritto pochi giorni prima dell’azione di Tolmezzo, secondo perché avevamo sentito di fatti di sangue avvenuti a Tolmezzo, ma pensavamo che Renato fosse a Pielungo. Appena tornate la mamma si preoccupò del fatto che a pochi giorni sarebbe stato il compleanno di mio fratello e che quindi bisognava fargli un regalo e mandarglielo su a Pielungo.
Decidemmo così di preparare una focaccia e io mi incaricai di trovare i contatti che potessero portargliela in montagna, ma più chiedevo informazioni in giro e più vedevo gente che cercava di cambiare discorso, alcune ragazze, che magari lo conoscevano, piangevano apparentemente senza alcun motivo: insomma c’era qualcosa di strano nell’aria e io volevo vederci chiaro. Allora andai a casa di Verdi e lui finalmente mi disse la verità. Gli dissi subito che avrei fatto qualsiasi cosa per portare avanti l’idea di Renato, per la quale egli aveva dato la vita e che quindi mi avvertisse se c’era qualcosa da poter fare oltre alla solita attività di informazioni che continuavo a svolgere.
Il 22 luglio mi fu recapitato un biglietto scritto da Eugenio, che mi invitava a raggiungere Pielungo “per importante ed urgente incarico”. A Pielungo c’era la missione inglese del maggiore Manfred, che era stato paracadutato in Friuli alla metà di giugno.
Qui Verdi ed Eugenio mi chiesero se fossi stata disposta a portare fino a Firenze, o quanto più vicino possibile, dei documenti ed altre carte che erano state richieste dal Comando Alleato. Mi fu chiesto di pensarci attentamente, giacché era una missione molto difficile e mia madre aveva già perso un figlio nella lotta partigiana: accettai immediatamente.
Non volli sapere cosa c’era scritto nelle carte per evitare di parlare nel caso in cui mi avessero catturata; sapevo solamente di trasportare anche la richiesta per la proposta per la medaglia d’oro per mio fratello.
Mi diedero 12.000 Lire per le eventuali spese di viaggio e la parola d’ordine “Cerco il Maggiore Biondo”.
Sapevo che mia madre non mi avrebbe mai detto di no, infatti anche lei era convinta che bisognava fare qualcosa per far sì che il sacrificio di Renato non fosse stato inutile e mi accompagnò addirittura fino a Padova.
Con l’aiuto della superiora del collegio dove abitavo quando andavo all’università, trovai un mezzo di trasporto e anche chi mi falsificò un permesso per attraversare il Po, perché a quel tempo non c’erano ponti agibili fino a Pavia.
Era perciò necessario poter utilizzare un traghetto militare tedesco.
La mia missione era di arrivare a Firenze o il più vicino possibile, farmi scavalcare dagli alleati che avanzavano e presentarmi al comando avanzato della N.1 Special Force dando la parola d’ordine.
Avevo quindi necessità di attraversare il Po.
Un prete mi prestò la sua macchina per la quale dovetti comprare la ruota di scorta e mi fece conoscere il capo garage della Questura di Padova, che lo aveva già aiutato a portare in salvo degli ebrei nonostante fosse un fascistone e che mi fornì un permesso per poter viaggiare sui traghetti tedeschi come se io fossi stata una dipendente te della Questura di Padova.
Quest’uomo credeva che anch’io fossi una ebrea, anche se io gli avevo raccontato che avendo incominciato l’università a Bologna, che non era più raggiungibile, dovevo assolutamente andare a farmi dare delle carte all’università per poter concludere il trasferimento a Padova, giacché Bologna non era più raggiungibile per cause di guerra.
Arrivati in riva al Po, dovemmo attendere il tramonto per poterci imbarcare. Fui interrogata da un ufficiale tedesco, ma evidentemente non lo insospettii.
La notte stessa imbarcammo la macchina sul traghetto, arrivammo di là, ma per ripartire dovemmo aspettare che facesse giorno, perchè la piccola macchina sulla quale viaggiavamo correva il rischio di essere travolta dai grossi automezzi militari che viaggiavano in senso inverso al nostro, andando verso nord.
Durante tutta la traversata fummo continuamente bersagliati dai colpi degli aerei alleati che cercavano di bloccare l’andirivieni notturno dei traghetti tedeschi, i quali, però, cambiavano ogni notte i punti di attracco, in modo tale da non essere bersagli troppo facili.
Arrivati a Bologna dovetti seminare l’autista della Questura e mi feci lasciare vicino all’università con l’accordo di rivederci dopo qualche ora in un punto determinato per ritornare indietro. Ovviamente, non mi feci più vedere.
Il mio problema era a quel punto come raggiungere Firenze. Andai così da alcuni amici di famiglia a chiedere aiuto, ma siccome erano mezzi ebrei erano terrorizzati e non potevano darmi l’aiuto che chiedevo, dato anche che non mi avevano più vista da anni.
Mi rivolsi allora alla CIT (Compagnia Italiana di Turismo), dove mi fu esplicitamente detto che non c’era altra possibilità per raggiungere Firenze che farsi rilasciare un permesso del comando tedesco.
Andai dunque al comando tedesco, ma la responsabile con la quale parlai fu veramente maleducata e mi insultò a causa della mia insistenza in tutte le maniere, dicendomi che non era possibile arrivare a Firenze. Io, che già avevo passato la notte in bianco, al sentirmi insultare e al pensiero di non riuscire a portare a termine la mia missione segretissima, mi misi a piangere.
Appena la responsabile uscì dall’ufficio i suoi colleghi, impietositi, mi dissero che vicino alle Due Torri ogni giorno partivano degli automezzi tedeschi diretti a Firenze e che se avessi chiesto a loro, mi avrebbero certamente dato un passaggio.
Così feci. Trovai due tedeschi anzianotti che guidavano un’ambulanza, i quali mi dissero che mi avrebbero volentieri portato con loro, ma avremmo dovuto aspettare fino a sera per partire e che intanto avremmo dovuto andare al loro deposito.
L’ambulanza sarebbe arrivata fino a Filigare, sulla strada della Futa, per ritirare materiale che veniva portato via dall’Istituto Chimico-Farmaceutico militare di Firenze; poi certamente avrei trovato un mezzo per proseguire.
A questi soldati avevo raccontato che dovevo raggiungere Firenze per cercare mia madre che, partita per cercare mio padre, era rimasta bloccata al sud a causa dell’ avanzata del fronte e mi aveva lasciata senza soldi.
Dato che anche loro avevano avuto disgrazie in famiglia a causa della guerra, mi aiutarono volentieri.
Infatti fermarono un camion militare che doveva portare munizioni ad Arezzo.
All’interno c’erano l’autista e un SS che avrà avuto una trentina di anni. I due tedescotti dell’ambulanza fecero loro mille raccomandazioni ed infatti fui trattata molto cortesemente.
Prima di partire mia madre si era molto raccomandata affinché io non mi facessi mettere le mani addosso da nessuno, d’altronde ero giovane e non ero né gobba né storta, ma ero ingenua e non avevo neanche pensato all’eventualità.
Nonostante tutta la mia ingenuità fui molto fortunata, perché tutti furono assolutamente corretti con me.
Quando arrivammo al bivio tra Firenze e Arezzo, quelli del camion mi affidarono a due gendarmi che erano lì di presidio.
Prima di partire mia madre mi aveva dato delle sigarette Eva, rimastele ancora da prima della guerra, quando, ricevendo le signore dei colleghi di mio padre, metteva a loro disposizione anche le sigarette.
Regalai il pacchetto all’SS per la sua gentilezza e lui mi affidò ai due gendarmi spiegando loro che avevo bisogno di raggiungere Firenze.
Appena ripartito il camion, i gendarmi iniziarono a farmi una sorta di interrogatorio e nonostante il fatto che io me la cavassi abbastanza bene con il tedesco, studiato andando all’università, ad un certo momento ebbi l’impressione di aver detto una cosa sbagliata o di non essermi fatta capire bene.
Allora offrii loro della frutta che ero riuscita a comprare a Bologna. Me ne furono molto grati, tanto che fermarono la prima macchina diretta a Firenze, dissero che avevano fatto loro l’interrogatorio e che non si trattava di un caso di spionaggio e si raccomandarono che venissi condotta fino a Firenze.
Durante tutto il tragitto pensavo a come avrei fatto, una volta giunta a Firenze, a scendere dalla macchina e andare per la mia strada senza che questi due mi conducessero, per esempio, al comando tedesco.
Per fortuna appena entrati in città, alla fine della via Bolognese l’autista si fermò, io ringraziai, scesi e me ne andai.
Erano circa le due di notte. Si sentivano forti esplosioni .
Mi trovai così da sola, in una città che conoscevo poco o niente, mentre passavano dei camion militari, con soldati che dicevano parolacce, che io, giovane ragazza, non avevo neanche mai sentito, perchè allora non usava parlare così.
Cercai quindi di allontanarmi, quando sentii da dietro un angolo un parlottare intenso.
Pensai che fossero i casigliani usciti per vedere cos’erano state le esplosioni.
Girai l’angolo del muro e capitai in un parcheggio tedesco: dalla padella nella brace!
In quei momenti bisogna essere pronti: subito pensai che se fossi scappata quelli mi sarebbero corsi dietro e allora, facendo finta di niente, continuai a camminare tranquilla.
I soldati di guardia mi chiesero che cosa volevo ed io dissi che siccome erano due notti che non dormivo, l’unica cosa che mi interessava era poter dormire.
Mi chiesero se preferivo dormire nelle macchine o nel giardino; risposi che nelle macchine c’erano i soldati e sarebbe stato meglio il giardino.
Mi diedero delle coperte e mi dissero che l’indomani mattina mi avrebbero svegliata alle cinque perché alle 5.30 c’era l’ispezione.
Non feci neanche in tempo a distendermi che già dormivo pacifica.
Avevo lasciato la mia valigetta all’ingresso, e immagino che abbiano anche guardato dentro e si siano fatti due risate perché giravo con il libro di glottologia e la grammatica di tedesco più pochi effetti personali.
Tutto questo, però, era una conferma di quello che avevo raccontato per giustificare la mia presenza a Firenze.
La mattina andai a cercare delle persone che avrebbero potuto aiutarmi e lasciai comunque la mia valigia a loro, dicendo che sarei passata a riprenderla.
In verità a Firenze non conoscevo nessuno direttamente: c’era soltanto un compagno di accademia e di reggimento di mio fratello, che era passato anche per casa nostra a Udine, che era di Firenze e che per un’altra breve missione che avevo compiuto in maggio sapevo essere già in contatto radio con le forze del Sud.
Mi presentai dunque a casa dei suoi genitori, dei quali conoscevo l’indirizzo. Dissi loro che mi rendevo conto che non mi conoscevano, ma poiché assomigliavo molto a mio fratello, avrebbero potuto credere alla mia identità.
Il padre, preoccupato per la moglie anziana ed affaticata per la mancanza di acqua, mi ospitò per un paio di giorni e poi riuscì a farmi accogliere nel Collegio delle Figlie del Sacro Cuore dove già erano rifugiati dei profughi.
Rimasi lì una quindicina di giorni, fino ai primi di agosto del 1944, quando i tedeschi fecero evacuare il Collegio e noi fummo costrette ad andare a dormire nel giardino della parrocchia.
Al 15 di agosto assieme ad un gruppo di persone capeggiate del parroco, tra le quali c’era pure un uomo che fingeva di essere pazzo, ottenemmo dai tedeschi il permesso di passare le linee.
Andai allora a cercare il Comando alleato (Comando Avanzato del Number 1 Special Force), presso il quale dovevo consegnare le carte dando la parola d’ordine: “Cerco il Maggiore Biondo”.
Feci fare un notevole soprassalto al capitano inglese, perché non avrebbe mai pensato che una persona così giovane sarebbe riuscita a fare una missione tanto difficile. Comunque il giorno seguente mi accompagnarono a Roma con una macchina e scortata da un ufficiale di marina.
Qui venni trattenuta alcuni giorni e fui obbligata a consegnare le carte. Io non avevo nessuna intenzione di consegnare le carte all’ufficiale che me le richiedeva, perché non corrispondeva alla descrizione che me ne aveva fatto Manfred.
Tuttavia se non avessi consegnato le carte mi avrebbero messo in campo di concentramento con l’accusa di spionaggio e quindi per tirarmi fuori, siccome nessuno sapeva che io mi trovavo lì, mio malgrado dovetti accettare.
Poi mi trasferirono a Monopoli e quindi verso l’interno della campagna pugliese.
Nei giorni successivi, nel corso di diversi interrogatori, diedi tutte le informazioni relative a quanto avevo visto durante il viaggio e riferii della nostra situazione in Friuli.
I problemi però non erano finiti, perché la persona alla quale avevo consegnato le carte a Roma le aveva messe in cassaforte ed era andato ad un ricevimento dimenticandosene completamente.
Così ogni volta in cui parlavo delle carte i miei interlocutori non capivano di che cosa stessi parlando e daccapo pensavano che fossi una spia.
Il direttore della villa dove mi avevano alloggiata era uno dell’intelligence. Oltre l’italiano e lo spagnolo parlava anche il tedesco, ma lo svizzero tedesco, perché sua moglie era svizzera.
Un giorno gli chiesi come mai parlasse svizzero tedesco e lui si insospettì subito perché non riusciva a capire come una ragazza che diceva di essere italiana potesse notare la differenza tra il tedesco di Germania e lo svizzero tedesco.
Vagli a spiegare che sapevo tutte queste cose perché avevo fatto l’esame di glottologia!
Però da questo discorso saltò fuori anche il problema dei documenti e finalmente le cose andarono a posto, si trovarono le carte e riuscii anche ad ottenere, come premio, il rimpatrio di mio padre dall’India dov’era prigioniero, catturato in Grecia.
Prima di partire mia madre mi aveva detto che nella prima guerra mondiale quando uno compiva una missione particolarmente importante davano un premio.
Si raccomandò che non accettassi né viaggi né soldi, ma che chiedessi il rimpatrio di mio padre.
E così fu: lo rimpatriarono in quattro giorni in aereo.
Rimasi con lui qualche giorno ed ebbi anche l’ingrato compito di dirgli che mio fratello era morto, poi finalmente riuscii a farlo partire per la Sicilia, dove abitava mia sorella.
Per ritornare a casa prima dell’ inverno, come avevo promesso alla mamma, non c’era altro mezzo che imparare ad usare il paracadute.
Ai primi di settembre del ’44 (avevo ormai assunto il nome di Renata, in ricordo di mio fratello, del quale intendevo continuare l’opera) frequentai senza problemi il corso paracadutisti a San Vito dei Normanni, presso Brindisi, effettuando i regolari quattro lanci nei quattro giorni del corso.
Entrai a far parte della missione speciale Bigelow (capomissione: Freccia; radiotelegrafista: Secondo; staffetta:io).
Praticamente dal 5 di settembre tutti i giorni rimanemmo in attesa della partenza, ma vuoi per l’andamento generale della guerra, vuoi per la situazione del Friuli ove la nostra missione era stata destinata, fino a novembre non potemmo partire.
La prima partenza avvenne su un quadrimotore.
Quando già eravamo da un pezzo sopra all’Adriatico, prese fuoco un motore, altri due si bloccarono e così dovemmo tornare indietro con un motore solo e atterrare a pieno carico da dove eravamo partiti.
Ogni mese si tentavano almeno due partenze, ma ogni volta c’era qualcosa che non andava: bufera sul Nord Italia, contraerea nel Golfo di Trieste, mancati segnali da terra, formazione di ghiaccio sulle ali, insomma dovevamo tornare sempre indietro.
Finalmente nel gennaio del 1945 il comando si spostò in Toscana.
I primi di aprile finalmente, il giorno 9, fummo paracadutati nei dintorni di Lauzana.
Per avvertire che la nostra missione era in arrivo era stato trasmesso via radio il messaggio speciale “baci a Mafalda”.
Riuscimmo a trovare il campo grazie alle segnalazioni fatte dai partigiani, che tenevano le biciclette con i fanali azzurrati rivolti verso l’alto. E ci lanciammo. Purtroppo all’ ultimo momento mi dimenticai di levarmi i guanti di lana, che soli avevo potuti avere a causa delle mie piccole misure; non potei perciò manovrare opportunamente le corde del paracadute, che mi scivolavano tra le mani a causa della lana dei guanti.
Così nell’ atterraggio, anche a causa del terreno ancora duro per l’inverno, mi procurai una frattura alla caviglia sinistra ed un doloroso schiacciamento dei dischi intervertebrali.
Però dovemmo allontanarci velocemente dal posto dove eravamo atterrati, perchè i carri dei cosacchi si erano messi in movimento, forse per il rumore dell’aereo.
Non riuscivo neanche ad alzare le braccia per farmi le trecce.
Nonostante tutto andai subito a Udine a vedere come stava mia madre, della quale non avevo più saputo niente da quando ero partita e che, come venni a sapere, era stata messa in prigione come ostaggio.
Corsi anche il mio bel rischio perché sotto all’impermeabile vestivo la divisa inglese che potei togliere solo una volta arrivata a casa, dopo aver attraversato tutta la città.
Siccome stavo male andai a fare delle radiografie, mi controllarono i polmoni, ma non trovarono niente. Ripresi subito i contatti con il comando della Osoppo.
Nel frattempo i miei compagni di missione, Freccia e Secondo, erano stati catturati dai cosacchi e successivamente liberati dai partigiani nella zona di Buia.
Erano tutti e due feriti e quindi dovetti provvedere affinché venissero curati e nascosti in posti diversi perché ricercati.
Alla fine Freccia venne nascosto in una casa di Udine, mentre Secondo, con la seconda radio trasmittente, che aveva potuto essere recuperata da dove era stata nascosta all’arrivo in Friuli, riprese i contatti con la Base, trasmettendo i messaggi che gli recapitavo a Colosomano di Buia.
Recapitavo messaggi anche ad altre stazioni radiotrasmittenti nella zona.
Il 28 aprile 1945, inizio dell’ insurrezione partigiana in Friuli, ero stata mandata a Buia per recapitare prima delle 8 di mattina messaggi sia al radiotelegrafista di un’altra missione di stanza a Ursinins Piccolo, sia a Secondo a Colosomano.
Pioveva a dirotto.
Avevo appena passato i cavalli di Frisia sulla piazza di Buia quando scoppiò il combattimento tra i partigiani della “Rosselli” ed i tedeschi, che resistevano agli attacchi partigiani dalle colline.
Io non ho mai capito se il compito che mi era stato affidato fosse veramente di portare le carte ai radiotelegrafisti o se il mio stesso passaggio costituisse il segnale dell’insurrezione.
Appena raggiunto il comando della “Rosselli” chiesi un mitra per entrare in postazione e vendicare finalmente mio fratello: mi fu severamente proibito.
Dovetti rimanere lì, bloccata, fino al primo di maggio, quando con un camion di fortuna sul quale viaggiavano anche Trieste e Fabio (Vinicio Lago) rientrai a Udine dove assistetti all’ingresso delle truppe alleate.
Il povero Fabio fu ucciso poco dopo che io ero scesa dal camion.
Il giorno 20 maggio a Siena, il n.1 Special Force scioglieva la missione Bigelow.
Nell’estate del 1945 ripresi i miei studi universitari, sostenni gli esami che mi mancavano e preparai la tesi di laurea. Il 13 dicembre 1945 mi laureai in Lettere e Filosofia.
Dopo qualche supplenza al ginnasio superiore, lavorai presso gli uffici del Governo Militare Alleato.
Nelle ore serali o nelle ore della chiusura pomeridiana insegnai in una Scuola per Mutilati e Invalidi di Guerra da reinserire nella vita civile, portandoli ad un diploma di scuola media inferiore.
Questa fu un’esperienza importantissima perché ritenevo veramente fondamentale che queste persone potessero inserirsi nel mondo del lavoro non solo perché invalidi, ma perché capaci e con un diploma.
Tempo dopo vinsi una borsa di studio Fullbright per gli Stati Uniti e così trascorsi due anni a Philadelphia, ove conseguii il Master of Arts. Siccome avevo soltanto un visto temporaneo per motivi di studio, dovetti rientrare in Italia, dove tra l’altro avevo già vinto un concorso per insegnare nelle scuole pubbliche […]
Paola Del Din, Intervista del 6 ottobre 2004
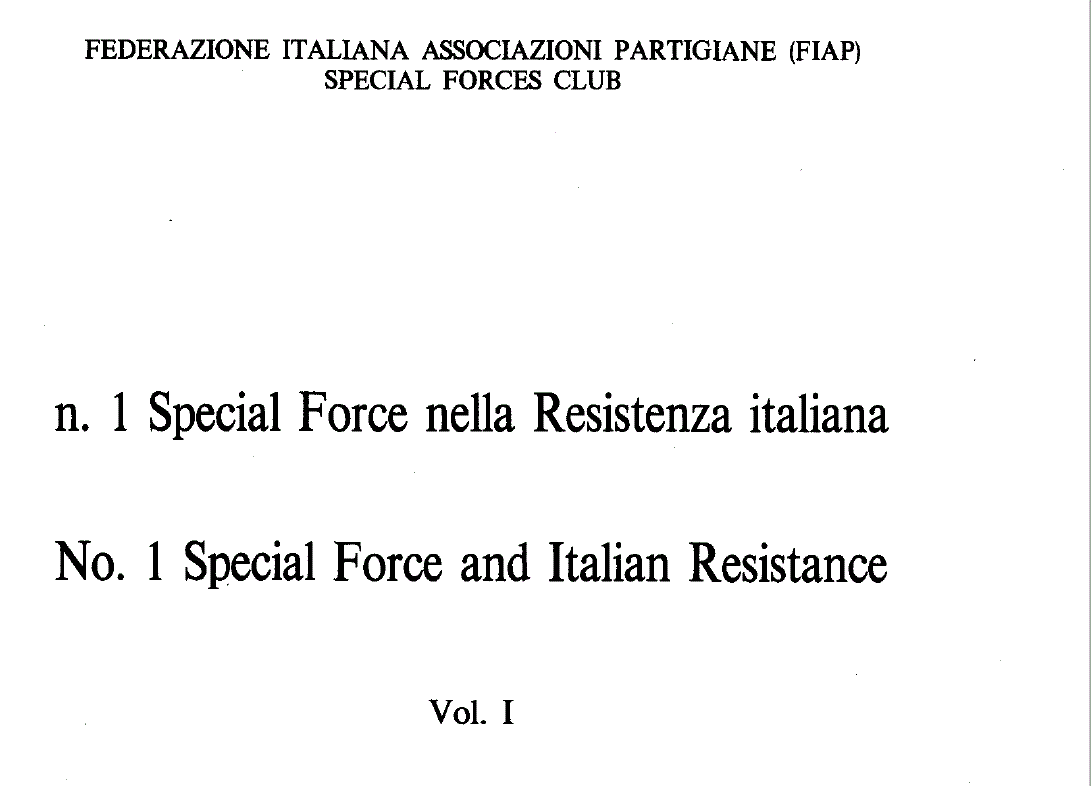
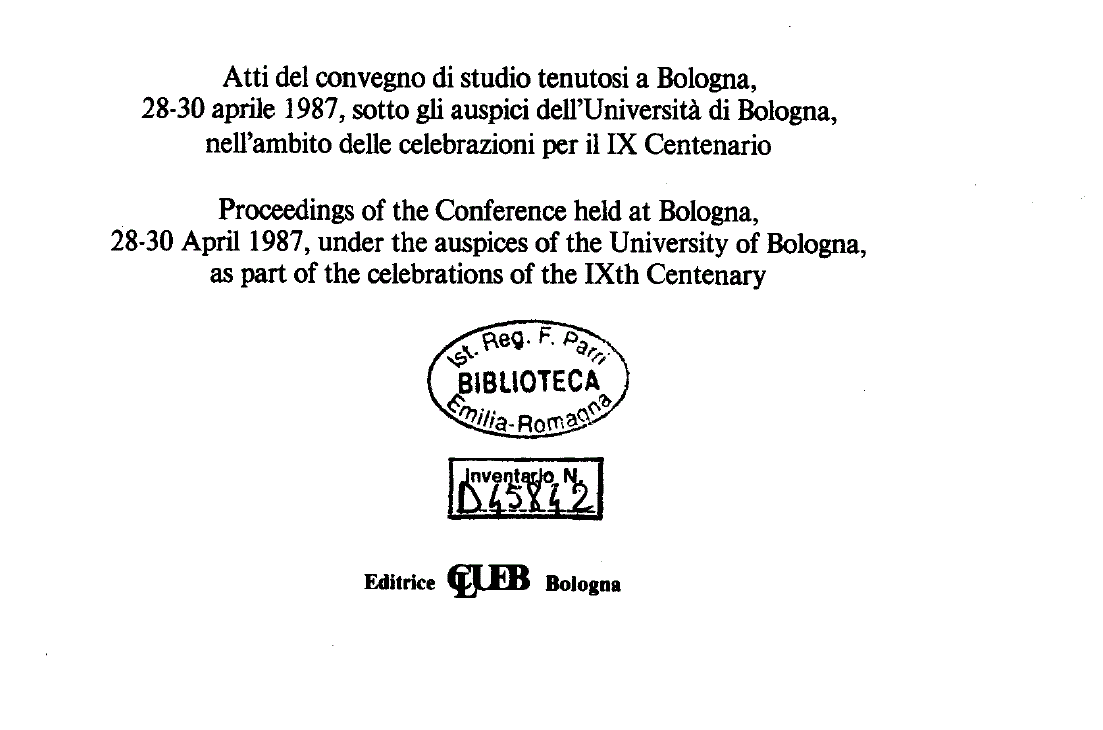
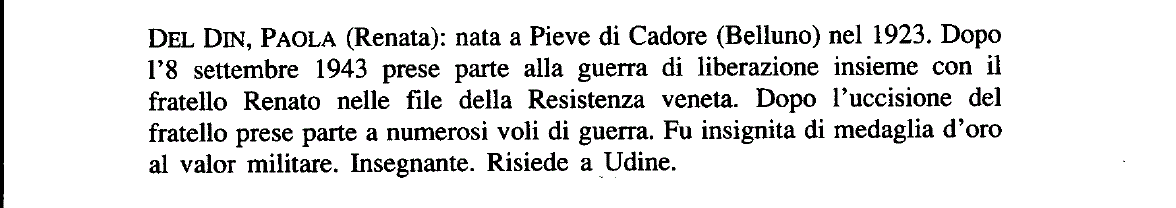 Eleonora Buzziolo, Partigiane in Friuli: storia e memoria, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 2003/2004
Eleonora Buzziolo, Partigiane in Friuli: storia e memoria, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 2003/2004
«Dopo aver svolto intensa attività partigiana nel Friuli nella formazione comandata dal fratello, ad avvenuta morte di questi in combattimento, viene prescelta per portare al Sud importanti documenti operativi interessanti il Comando alleato. Oltrepassate a piedi le linee di combattimento dopo non poche peripezie e con continuo rischio della propria vita ed ultimata la sua missione, chiedeva di frequentare un corso di paracadutisti. Dopo aver compiuto ben undici voli di guerra in circostanze fortunose, riusciva finalmente, unica donna in Italia, a lanciarsi col paracadute nel cielo del Friuli alla vigilia della liberazione. Nel corso dell’atterraggio riportava una frattura alla caviglia ed una torsione alla spina dorsale, ma nonostante il dolore lancinante, la sua unica preoccupazione era di prendere subito contatto con la Missione alleata nella zona per consegnarle i documenti che aveva portato con sé. Negli ultimi giorni di guerra, benché claudicante, passava ancora ripetutamente le linee di combattimento per recapitare informazioni ai reparti alleati avanzanti. Bellissima figura di partigiana seppe in ogni circostanza assolvere con rara capacità e virile ardimento i compiti affidatile, dimostrando sempre elevato spirito di sacrificio e sconfinata dedizione alla causa della libertà»
Motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa a Paola Del Din